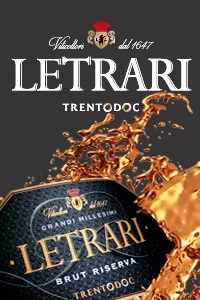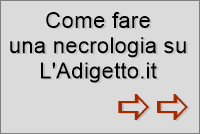Pierluigi Castagnetti: De Gasperi e Dossetti
Lectio degasperiana: I due modelli di cattolicesimo politico per la Democrazia italiana
Quando si (ri)costruiva l’Italia, quando si scriveva la Carta costituzionale, quando si ancorava il destino del paese all’Europa e all’ occidente, quando nasceva il partito dei cattolici italiani, quando nascevano per la prima volta le correnti nello stesso partito… (e si potrebbe continuare), quello era il tempo di De Gasperi e Dossetti.
Due figure molto diverse per età, formazione, esperienze, visione e ruolo, spesso in dialettica anche dura, ma sostanzialmente concorrenti nel definire una linea politica «tendenzialmente unitaria».
Non è mia intenzione nascondere le differenze e anche i conflitti tra di loro – che cercherò di richiamare uno per uno – ma mi sembra ormai giunto il momento di mettere in discussione il cliché di una diversità radicale che descrive l’uno come personaggio politico e l’altro meno politico, l’uno esperto e l’altro inesperto, l’uno statista e l’altro inguaribile idealista, l’uno roccioso e l’altro caratterialmente inquieto.
Erano entrambi uomini pienamente politici, in modo diverso riformatori e dunque realisti e concreti.
Chi ha conosciuto Giuseppe Dossetti e l’ha visto all’opera come organizzatore e mobilitatore popolare e ancor più come ideatore di grandi riforme di sistema, ha potuto apprezzarne l’intelligenza e la capacità di governo impressionanti, sicuramente paragonabili a quelle dello statista trentino.
Va aggiunto poi che i due si stimavano molto, anche se non sono mai riusciti, rammaricandosene, a capirsi fino in fondo.
Vi sono due lettere che si scambiarono al tempo dell’’adesione dell’Italia all’Alleanza Atlantica che a me pare illustrino bene i rispettivi stati d’animo. Il 22 febbraio 1949 Dossetti scriveva così a De Gasperi.
«In sostanza l’altra sera, come già tante altre volte, ho sentito che non è certo comoda e felice la posizione che spesso assumo nel seno del Partito e nei rapporti con te: posizione che ha per effetto quasi sempre di addolorare te, cui per tanti motivi devo devozione e riguardo, di contrastare molti amici, che non mi comprendono e che si allontanano quasi ritenendomi solo un dottrinario, e infine di impedirmi di impiegare più utilmente e costruttivamente delle energie, che hanno per lo meno un pregio: quello di essere spese al servizio di questo nostro Partito con una intensità e una esclusività non frequente.»
Nonostante questa dichiarazione di stima personale Dossetti continuava.
«Devi credermi se ti dico che corrisponderebbe molto di più ai miei desideri e al mio istinto rinunziare a qualche piccola, e per lo più vana protesta, pormi in una linea di piena e cordiale conformità. Ma, temo, sarebbe la via dell’istinto e non quella del dovere. Soprattutto se ciò fosse ottenuto a un prezzo che non mi pare di poter pagare: quello della rinunzia ad una misura e a un senso di responsabilità,che su di un piano di tanto più modesto del tuo tuttavia hanno una loro precisa consistenza per me in quanto deputato e soprattutto in quanto membro del supremo organo del Partito.
«Perciò l’altra sera mentre come uomo ero commosso e quasi travolto dalle tue parole, come consigliere nazionale del Partito mi sembra di non poter proprio consentire in tutto: non tanto sul merito della questione discussa quanto sul metodo della sua impostazione e sulla definizione delle rispettive responsabilità.»
De Gasperi rispose il 5 Marzo 1949 con non minore attenzione umana e sensibilità.
«Sarei felice se mi riuscisse di scoprire ove si nasconda la molla segreta del tuo microcosmo, per tentare il sincronismo delle nostre energie costruttive… ma ogni volta che mi pare di esserti venuto incontro, sento che tu mi opponi una resistenza che chiami senso del dovere… E poiché non posso dubitare della sincerità di questo tuo sentimento, io mi arresto rassegnato sulla soglia della tua coscienza.»
E, ancora, De Gasperi nella lettera dell’11 gennaio 1952 con cui risponde all’annuncio di dimissioni di Dossetti, ribadisce.
«Vorrei che anche tu credessi che anche in me non è mai mancato il vivo desiderio di comprenderti o meglio comprendere le ragioni dei tuoi atteggiamenti, rifiutando ogni interpretazione meno che nobile o deteriore».
Dunque un’incomprensione veramente importante, dall’inizio alla fine della loro relazione politica.
È del tutto evidente che se si fosse trattato soltanto di una questione di radicale alterità di strategia politica non sarebbe stato difficile comprenderla. C’è stata invece l’impossibilità o l’incapacità dell’uno e dell’altro di entrare sino in fondo nei reciproci sistemi di pensiero, linguaggi, blocchi psicologici, pregiudizi generazionali. E forse anche il pudore di raccontarsi fino in fondo le reciproche visioni del mondo, custodi nel profondo delle vere differenze politiche.
De Gasperi e Dossetti lavorarono insieme per meno di sette anni. Dossetti si dimise definitivamente all’inizio del 1952, De Gasperi morirà due anni dopo. La densità di quegli anni, come sappiamo, decise il destino del paese, segnandone il percorso politico e democratico per lunghi anni successivi.
È commovente il ricordo di una lunga lettera di De Gasperi al suo successore Amintore Fanfani,il 14 agosto 1954, cinque giorni prima di morire, in cui gli chiede un estremo tentativo per salvare la CED, l’ultimo prodotto dalla sua straordinaria strategia europeista.
Dossetti, dopo quella politica, visse una successiva esperienza, assai più lunga (morirà nel 1996) di carattere prima culturale e poi monastico con un paio di riaffacci alla politica, nel 1956 e nel 1994; un’esperienza che proietterà una luce utile a una comprensione più puntuale dei sette anni di impegno politico e parlamentare, vissuti sempre con la tensione a un’ulteriorità inevitabile in chi ritiene il proprio impegno politico generato dalla fede e misurato dalla fede.
Una tensione che porterà un amico di Dossetti, Aldo Moro, più tardi, a parlare del valore del «non appagamento» e Pietro Scoppola, in altro contesto, a parlare della politica «come valutazione razionale del possibile e sofferenza per l’impossibile.»
Ma torniamo ad approfondire la conoscenza dei nostri due, e le differenze che ovviamente non riguardavano soltanto la natura delle due personalità.
De Gasperi proveniva da un’esperienza parlamentare lunga e per molti aspetti unica, a Innsbruck, a Vienna e poi nel parlamento italiano prima del fascismo, che, insieme agli studi sviluppati negli anni di permanenza alla Biblioteca Vaticana, gli aveva aperto orizzonti culturali molto ampi.
«Nella galleria dei nostri antenati – proclamava - veneriamo anche Lacordaire, Montalémbert, Tocqueville» (oltre ovviamente a Lamennais, Sturzo, Maritain), che gli avevano consentito di elaborare l’idea che la modernità dovesse raccordarsi a un modello di stato sostanzialmente liberal-democratico.
De Gasperi non fu un restauratore, come una certa storiografia «di parte» tentò di sostenere nel dopoguerra, e non fu neppure un conservatore in senso classico, poiché vide sin da subito l’esigenza di una forte discontinuità; fu piuttosto un riformista, e come tale realista, o un «moderato creativo», come l’ha definito Scoppola nella lectio qui a Pieve Tesino nel 2004.
De Gasperi per Craveri concepiva la «democrazia come antirivoluzione», ma sapeva che la rivoluzione non si poteva combattere con l’immobilismo e la conservazione e, perciò, concepì il nuovo partito, la Democrazia Cristiana, come un partito laico ma intenzionalmente unitario dei cattolici, non il partito fra o di cattolici di Sturzo, ma il partito dei cattolici.
Per Dossetti questa era quantomeno una scelta rischiosa, perché, al di là delle intenzioni, poteva trascinare la Chiesa e dunque usurarla, mentre per De Gasperi era la scelta necessaria sia per evitare che la divisione dei cattolici, com’era accaduto negli anni ’20, favorisse una deriva della democrazia, sia per potere aiutare i cattolici tutti a liberarsi della lunga contaminazione clerico-fascista che li aveva portati ad essere all’inizio del secondo dopoguerra, la parte debole della società democratica.
Ma in lui vi era soprattutto l’ambizione di costruire un partito nazionale e popolare, il partito del paese, in cui potesse riconoscersi – dopo l’esperienza della dittatura e della guerra che avevano diviso in profondità – la maggioranza degli italiani. C’era bisogno di ri-connettere, ri-conciliare e ri-pacificare il paese; la ricostruzione aveva bisogno di tutti e non avrebbe sopportato la prosecuzione di conflittualità politiche, confessionali e di classe e, poiché il cattolicesimo nella storia italiana rappresentava un elemento di identità e unità, un nuovo partito dei cattolici avrebbe potuto fecondare il processo che si stava avviando.
Un partito unitario dei cattolici anche per scoraggiare le posizioni antirepubblicane e a-fasciste che dentro la cristianità italiana erano tentate di darsi forma politica, sostenute anche da ambienti confindustriali preoccupati delle incerte prospettive istituzionali e politiche.
Nel fare il nuovo partito De Gasperi non poteva peraltro riferirsi all’esperienza degli altri paesi europei paragonabili all’Italia: i cattolici in Francia erano infatti fortemente segnati dalla condanna dell’«Action Francaise» di Maurras e da Vichy, mentre la democrazia tedesca nasceva su basi del tutto diverse poiché là, come ha rilevato Scoppola, «il comunismo era un altro Stato», mentre in Italia il comunismo era parte costitutiva del nuovo stato e, dunque, con esso si doveva instaurare un rapporto di riconoscimento reciproco e di inevitabile competizione democratica.
Anche a questo scopo un partito grande, cioè rappresentativo della quasi totalità dei cattolici, avrebbe reso più facile l’obiettivo.
Il disegno di De Gasperi per quanto favorito dalla riflessione culturale che nella prima metà degli anni ’40 la parte più avanzata e sensibile del cattolicesimo italiano aveva elaborato (il convegno di Camaldoli nel 1943, i cenacoli dei vecchi gruppi dirigenti Popolari a Roma e a Milano, molti docenti dell’Università Cattolica) sentiva di dover personalmente farsi carico di dare attuazione a un partito che coinvolgesse tutte le esperienze associative politiche ed ecclesiali, ma anche la gran parte di quelle sindacali, professionali ed economiche. Un lavoro enorme che la sua capacità organizzativa di indole trentina, concreta e mediatrice, e la sua conoscenza di numerosi ambienti, poteva realizzare.
Paradossalmente, ma non troppo, Dossetti, che non sembrava condividere il disegno di un partito così largo e così esposto ai limiti di mediazioni eccessive, finirà per essere uno dei maggiori protagonisti della sua realizzazione concreta.
Non vi era perfetta coincidenza fra De Gasperi e Dossetti sul ruolo che il partito avrebbe dovuto avere nell’impianto istituzionale della nostra democrazia. Per De Gasperi doveva essere rafforzato il ruolo del Parlamento come luogo principe di discussione su impulso del governo e quindi di partecipazione democratica degli eletti.
Secondo Craveri, De Gasperi aveva «almeno nelle sue linee di fondo, un approccio assai simile a quello del classico modello del governo di gabinetto così schematizzabile: prima il governo, poi la maggioranza parlamentare, infine il partito. La leadership del governo avrebbe costituito dunque il punto di riferimento naturale, se si vuole il momento di sintesi di questa gerarchia istituzionale».
Anche per Dossetti il partito non doveva essere la pietra angolare dell’architettura costituzionale, ma lo strumento principale della rappresentanza.
Dossetti, influenzato anche dalla tesi sul partito politico del suo amico Costantino Mortati esprimerà più volte la sua propensione per una democrazia sostanziale, dove la sostanza è la sovranità del popolo, in cui il partito non può essere solo uno strumento di formazione di classi dirigenti e di propaganda elettorale, ma anche e soprattutto di veicolo della volontà del popolo trasferita attraverso i gruppi parlamentari nel cuore delle istituzioni.
La posizione di Dossetti appare meno moderna di quella di De Gasperi, e in parte anche contraddittoria con la sua iniziale propensione verso un’ipotesi presidenzialista, ma coglie uno dei problemi più acuti del funzionamento democratico, quello della rappresentanza: chi delega ha il diritto di vedere portato il suo pensiero nel luogo dove la delega viene esercitata e, nello stesso tempo, ha il diritto di vedere controllato l’esercizio di questa delega.
Come si vede c’è una certa attualità in queste posizioni, anche se oggi, evidentemente, la liquefazione della società non consente «rassodamenti» partitici troppo rigidi.
Alla fine, si capisce bene come nella concezione del ruolo così importante che Dossetti assegna al partito sia presente la preoccupazione di evitare che la logica del governo di coalizione imponesse costi di mediazione troppo alti per chi aveva un progetto politico da realizzare.
De Gasperi difenderà invece sino in fondo il governo di coalizione, non solo perché gli permetteva di rappresentare e coinvolgere realtà sociali e politiche che pur minoritarie esprimono un peso determinante sul piano economico ed un’apertura verso i mercati e le democrazie straniere, ma anche perché gli consentiva - come detto -di sottrarsi al condizionamento esclusivo del proprio partito e, di conseguenza, del mondo cattolico e delle gerarchie ecclesiali.
È soprattutto qui che ha origine la polemica troppo superficiale sul presunto integralismo di Dossetti.
Dossetti non era insofferente verso la politica delle alleanze, semplicemente riteneva che compito della Democrazia Cristiana fosse quello di realizzare un cambiamento profondo del paradigma del potere e dunque degli obiettivi verso cui finalizzarne l’esercizio.
A suo avviso doveva essere realizzato il progetto politico iscritto nella Costituzione, non solo nella parte istituzionale, che tra l’altro Dossetti giudicava fragile e da ripensare rapidamente, (con interventi apparsi su Cronache sociali già alla fine degli anni ’40) e anzi rimproverava a sé stesso di averla lasciata troppo alla determinazione dei costituenti più anziani e più sensibili all’esigenza di un eccessivo garantismo, sia per lo spettro passato del fascismo e sia ancor più per il «pericolo comunista» che incombeva, ma nella sua parte più sostanziale,dei rapporti economico-sociali.
L’alleanza con le forze minori di centro, per Dossetti, avrebbe potuto fatalmente costituire un alibi per non realizzare l’obiettivo. Insomma, Dossetti, che ha avuto un ruolo decisivo nello scioglimento del CLN (ricevendone un importante apprezzamento da De Gasperi), perché riteneva non si potesse sottrarre alle assemblee elettive la prerogativa delle scelte politiche, pensava che in ogni caso non si dovesse ammainare la bandiera dell’antifascismo e la missione di costruire una democrazia politicamente orientata a favorire i ceti popolari più deboli.
Veniamo così alla prima delle due ragioni che a mio avviso spiegano la qualità delle diverse visioni fra nostri due personaggi: l’antifascismo.
Per Scoppola «una visione equilibrata della realtà – premessa necessaria di una sintesi politica efficace – era possibile assai più in chi aveva seguito l’esperienza della Resistenza da lontano che in chi l’aveva vissuta sulla sua carne: la posizione di uomini come De Gasperi e come Togliatti risulterà così, in definitiva, privilegiata per la maggiore capacità di cogliere la linea di un equilibrio di insieme e di possibile sviluppo della politica italiana».
Un’osservazione seria ma discutibile, nel senso che se è vero che chi la Resistenza l’ha fatta poteva essere meno obiettivo nel valutarne la portata, è anche vero che proprio l’esperienza vissuta era in grado di radicare il giudizio storico con maggiore cognizione di causa.
Ciò che in ogni caso non è discutibile è l’antifascismo anche di De Gasperi.
Ma il suo, come rileva Craveri, era «un antifascismo religioso», nel senso che coglieva la radicale contraddizione del fascismo con i principi del cristianesimo e, anche perciò, si rendeva necessario ri-educare quella vasta area di credenti ancora prigioniera dell’inaccettabile idea che il fascismo «potesse essere cattolicizzabile» e che «occorresse portare avanti una lunga guerra di posizione per consolidare gli elementi considerati positivi ed emarginare gli altri» (e in tale quadro non si può negare che lo stesso padre Gemelli avesse giocato un ruolo non secondario).
Per Dossetti invece le ragioni dell’antifascismo erano più profonde e definitive. C’era sì il riconoscimento dell’inconciliabilità con il pensiero cristiano, ma c’era anche altro.
Dossetti, come rileva Alberto Melloni, mutua da Gobetti l’idea del fascismo come autobiografia della nazione:non solo sul piano storiografico o su quello della coscienza del cattolicesimo democratico, ma proprio come dato permanente, che perdura e si ripropone nel tempo.
«È avvenuto, quindi può accadere di nuovo», – scriverà Primo Levi. – È questa la radice teologica del suo patriottismo costituzionale: ciò che Dossetti intuisce e denuncia a partire dal 1994 (sia nel discorso in memoria di Lazzati sia in numerosi interventi in difesa della Costituzione) non fu dettato da una preoccupazione politica contro Silvio Berlusconi ma dalla preoccupazione fortissima che quella novità potesse rappresentare l’inizio di una fase di de-costituzionalizzazione della nostra legge fondamentale e dei suoi meccanismi di difesa rispetto ai rischi di rottura dell’unità nazionale e del particolare equilibrio tra i poteri istituzionali che è alla base del modello democratico.
Un rischio che gli era suggerito anche dalla seconda ragione fondamentale che spiega la diversità con De Gasperi: la cosiddetta cultura della crisi.
Per Dossetti la crisi vissuta dalle istituzioni dell’Europa liberale e democratica non era di natura temporanea né era apparsa all’improvviso, non una parentesi, per dirla con Benedetto Croce, ma un segno più profondo, un solco che bisognava colmare attraverso una paziente opera di ricostruzione morale.
Il pensiero dossettiano lavorava secondo una metodologia precisa, seguendo una pista ben definita: la crisi della civiltà occidentale. Crisi che aveva prodotto eventi terribili e radicalmente anticristiani: basterebbe ricordare la originalissima e intensa introduzione a Le Querce di Montesole di Luciano Gherardi dove si parla degli eccidi nazisti come di delitti «castali».
Il fratello Ermanno Dossetti ha ricordato che molto influì sulla formazione di Giuseppe il libro di Huizinga «La crisi della civiltà», una tematica affrontata anche da altri autori frequentati da Dossetti, come Romano Guardini e soprattutto Jacques Maritain.
Come ha scritto Paolo Pombeni, Dossetti «era figlio della crisi degli anni ’30, quella che si era interrogata sul perché del fallimento del mondo precedente, ma che soprattutto si era chiesta perché la Chiesa e i cristiani fossero stati incapaci di essere sale e lievito in quei frangenti».
Per Dossetti la civiltà contemporanea poteva essere letta come «civiltà della crisi», di fronte alla quale non soltanto gli strumenti puramente politici ma anche la Chiesa stessa si rivelava impotente.
È Paolo Prodi a ricordarci che «nonostante i richiami di continuità che Dossetti fa rispetto alla sua esperienza politica e spirituale e alle diagnosi già date sulla crisi, mi sembra che la novità del suo pensiero fu proprio quella del giudizio di “catastroficità” sulla situazione mondiale, che si traduceva in un giudizio sulla criticità del momento ecclesiale a causa del prevalere nel cristianesimo di un modo razionalistico e attivistico – compromesso con la politica, semipelagiano sul piano teologico – di vivere la fede».
La chiave della crisi di civiltà assume nel pensiero di Dossetti un significato ancora più accentuato dopo la seconda guerra mondiale, un evento che aveva segnato per sempre non solo il secolo ma i tempi a venire. Ne parlò con straordinaria intensità a Monteveglio nel dibattito con Nilde Iotti nel 1994 quando ricordò i 55 milioni di uomini uccisi, la Shoah, l’invenzione della bomba atomica, la spaccatura del mondo in due blocchi contrapposti, un «crogiolo ardente e universale» da cui fortunatamente e per grazia di Dio è scaturito quell’opus maius rappresentato sul piano politico dalla ripresa e dal perfezionarsi del costituzionalismo interno e internazionale e sul piano ecclesiale dalla convocazione del Concilio Vaticano II.
Non si capisce Dossetti se non si tiene presente questa sua chiave di lettura della storia e, necessariamente e di conseguenza, di definizione delle responsabilità che competono alla politica e alla Chiesa.
Pur in presenza di tali diversità, ripeto che a me pare giusto sottolineare i momenti non rari e non marginali di intesa politica con De Gasperi.
Il lavoro costituente rappresentò in particolare un momento di convergenza. Se è vero infatti che De Gasperi partecipò pochissimo ai lavori dell’Assemblea Costituente essendo impegnato a guidare il governo, non è privo di significato il fatto che in quella sede Dossetti e i suoi amici godessero di fatto di titoli di rappresentanza dell’intero partito e margini di autonomia che hanno utilizzato sino in fondo, soprattutto nel definire l’impianto complessivo della Carta e, in particolare, i principi fondamentali.
È giusto ricordare che va a merito di Dossetti e di altri costituenti che gravitavano attorno alla Comunità del Porcellino aver definito il sostrato culturale che regge l’impianto costituzionale, ma è non meno importante dare atto che gran parte di quello stesso sostrato si trova nelle Idee ricostruttive di De Gasperi, soprattutto nella prima provvisoria stesura che Scoppola considera il manifesto politico dello statista trentino.
Entrambi convergono in modo significativo sull’art. 7 della Costituzione, su quello che sarebbe stato un esempio di laicità dialogante e di comprensione del ruolo della Chiesa in Italia. Sia Dossetti che De Gasperi si muovono con l’intento di sanare una ferita storica che risale al Risorgimento e più tardi al Concordato tra la Chiesa e il regime.
De Gasperi, nel discorso del 25 marzo 1947 dirà: «Vi aggiungo – ed è l’unico riferimento che faccio alla mia carica di governo – che io mi sento portato e deciso a votare anche per l’impegno che ho dato, che ho preso, di consolidare, di universalizzare, di vivificare il regime repubblicano».
Dossetti, nel suo intervento di quattro giorni prima, aveva delineato con finezza, e forse con qualche forzatura, come ammetterà egli stesso, il senso dell’impegno democristiano rispetto al Concordato: «…perché non si inserisca in questo momento decisivo (come già alle origini del nostro primo Risorgimento) alla base del nuovo edificio quel contrasto interiore, quella riserva che potrebbe impedire a molti di noi, se non di dare la nostra opera e il nostro contributo esteriore,perlomeno di effondere nello sforzo ricostruttivo tutta la nostra interiorità, la porzione più gelosa e più preziosa del nostro spirito».
Fu uno dei momenti più alti del dibattito costituzionale nel quale i costituenti cattolici hanno finito per operare verso la Chiesa quella che Alberto Melloni (parlando nello specifico di Dossetti) ha definito una manuductio.
Avevano portato cioè per mano la Chiesa ad accettare il sistema democratico, allontanando le tentazioni di uno stato confessionale e accettando di contribuire a radicare le masse cattoliche nel cuore della Costituzione, al centro del sistema democratico.
Era un tempo in cui fra la chiesa e i politici cattolici si determinò una significativa circolarità di apporti e di influenza.
Com’è noto, date le premesse che abbiamo fatto, non rinuncio a ricordarlo, non mancarono i momenti di incomprensione e qualche volta anche di conflitto tra queste due personalità. È inevitabile menzionarne almeno i tre più significativi: la scelta del referendum istituzionale, la scelta dell’Alleanza atlantica e la politica economica all’inizio degli anni ’50.
Referendum istituzionale.
Quella del referendum per la scelta istituzionale, monarchia o repubblica, non fu una scelta facile per la divisione tra e nelle forze politiche. In particolare i liberali lo volevano nella speranza di confermare la monarchia e il potere delle vecchie classi dirigenti ad essa legate, mentre le sinistre non lo volevano, quantomeno non volevano che fosse preventivo per non sottrarre all’assemblea costituente una scelta fondamentale.
All’interno della Democrazia Cristiana era invece temuto dalla parte repubblicana: dallo stesso Sturzo, che dall’estero guidava, attraverso Mario Scelba, una forte opposizione al referendum; ma anche dalle sinistre interne, soprattutto quella dossettiana, nel timore che potesse prevalere la scelta della monarchia grazie all’appoggio di una parte importante della chiesa che si sentiva più garantita rispetto al rischio di una repubblica eventualmente guidata dalle sinistre.
Era per lo più l’elettorato meridionale ad essere schierato su quest’ultimapropensione, nonostante la posizione espressa da Scelba e dai dirigenti siciliani, in primo luogo dall’altro vicesegretario Bernardo Mattarella e da esponenti di spicco in Campania e in Puglia.
In questo contesto, era forte il sospetto che De Gasperi fosse animato dalla riserva mentale di favorire la monarchia non schierando in modo netto il partito a favore della repubblica.
De Gasperi, in realtà, voleva ancorare la scelta istituzionale a un coinvolgimento diretto del popolo, avendo viva la memoria – come ha sottolineato Paolo Pombeni in varie occasioni – della Repubblica di Weimar, dove pur in presenza di una costituzione certamente di qualità non si era riusciti a frenare la crisi terribile della democrazia anche perché il popolo tedesco, in fondo,non l’aveva mai sentita come «propria».
In ogni caso, quello che premeva a De Gasperi era poter arrivare alla repubblica senza lacerazioni nel mondo cattolico e nella DC, con un largo consenso che sin dall’inizio assicurasse al nuovo stato una solida base.
È infine da dire che la scelta del referendum istituzionale lacerò a lungo anche i partiti della sinistra, che pure erano convinti dell’esito a favore della repubblica, ma temevano che l’associazione del referendum alla richiesta degasperiana di introdurre insieme al suffragio universale il voto obbligatorio favorisse la mobilitazione delle masse cattoliche e dunque introducesse qualche rischio per l’esito previsto.
È interessante l’esame dei verbali della direzione del Partito Comunista da cui si evince questo travaglio e in particolare il ruolo che hanno avuto Pietro Nenni e, all’interno del PCI, Giorgio Amendola e Girolamo Li Causi, nel modificare le posizioni di partenza.
Dossetti, persa la battaglia sulla scelta dell’indizione del referendum, come vicesegretario si impegnò moltissimo a sostenere in sede elettorale l’opzione della repubblica, sia nella base del partito, sia nell’elettorato, al punto di vantarsi legittimamente del risultato:
«Ma i voti alla repubblica chi li ha portati al primo congresso della Democrazia Cristiana? Ci sono dei fatti. In un certo mio itinerario, federazione per federazione, comitato provinciale per comitato provinciale.»
Se è possibile affermare, come fa Leopoldo Elia, che la scelta di De Gasperi per il referendum «fu un vero e proprio capolavoro» nondimeno è doveroso sostenere che il risultato finale è non poco merito di Dossetti e degli altri dirigenti democristiani che si mossero sulla stessa linea, contravvenendo all’indicazione di quello che allora fu definito «l’agnosticismo istituzionale» della Democrazia Cristiana.
La scelta dell’Alleanza atlantica.
Per molti aspetti anche questa può essere definita un capolavoro di De Gasperi, nel senso che, determinatesi le condizioni, in parte anche cercate attraverso un intenso lavoro diplomatico, il capo del governo italiano vide nell’adesione al Patto Atlantico la possibilità di ancorare definitivamente l’Italia all’occidente, non senza il pagamento di alcuni costi politici ritenuti discutibili ed esosi non solo da parte di Dossetti e delle altre sinistre interne ma anche di una parte importante della Santa Sede si disse che lo stesso card.
Tardini fosse piuttosto freddo sul tema. Com’è noto, la battaglia di Dossetti si sviluppò tutta all’interno del partito, nella direzione nazionale e nei gruppi parlamentari, dove, al dunque, votò contro, mentre in sede parlamentare, pur con qualche resistenza, lui e i suoi amici votarono a favore.
Dall’esame dei verbali della direzione e del gruppo parlamentare emerge chiaramente la preoccupazione di Dossetti di portare l’Italia nelle braccia degli Stati Uniti senza possibilità di esercitare una qualche influenza, essendo mancato l’impegno preventivo a costruire una strategia di intesa con gli altri paesi europei dell’Alleanza.
Dossetti era molto preoccupato del clima che andava consolidandosi sullo scenario internazionale di forte contrapposizione fra i due blocchi oltre che della rinuncia dell’Italia a giocare un ruolo nel bacino del Mediterraneo e in Europa.
Era preoccupato che questa scelta legittimasse definitivamente e ingessasse la linea economica liberista che a suo avviso il governo italiano stava definendo in modo sempre più preciso.
Ma non arrivò mai a contestare in radice la scelta. Nel verbale della riunione del 29 novembre 1948 del gruppo parlamentare, in cui si discuteva la mozione Nenni, si legge dell’intervento di Dossetti la seguente sintesi: «Sulla linea è difficile essere in disaccordo. Il pericolo URSS esiste. Il patto di Bruxelles non ha per sé lo stimolo offensivo. Italia (ragione economica, culturale, storica, ideologica) sostanzialmente nell’orbita del mondo occidentale. Ingenuo pensare che l’Italia possa fare il vaso di terra tra vasi di ferro. Quindi non è in questione la neutralità a priori. Astratta. Quindi no alla mozione Nenni, nient’affatto di neutralità e di pace… Di fronte al problema abbiamo avuto quasi la certezza che dalla fine di settembre a metà novembre Min. esteri e alta diplomazia abbiano fatto passi in avanti che non corrispondono esattamente a quanto detto da De Gasperi il quale ha esposto tesi più graduale e concreta.».
Con ciò veniva posta ancora una volta una «questione di metodo» (questo avrebbe dovuto essere anche il titolo della rivista che poi si chiamerà «Cronache sociali»), cioè di non adeguata trasparenza dei propositi e di non completa informazione sugli indirizzi e sugli atti dell’azione governativa, pur mantenendo una sostanziale riserva verso l’Alleanza.
La linea economica. Soprattutto durante la seconda vicesegreteria di Dossetti, 1950-51, si accentua la polemica verso la politica economica di Giuseppe Pella, legatissimo agli ambienti confindustriali tessili e a quello che veniva definito il «quarto partito». V
Vi è traccia di questi suoi giudizi in numerose lettere al segretario nazionale Guido Gonella.
Queste critiche dossettiane alla linea liberista di Pella esprimevano uno stato d’animo diffuso non solo negli ambienti sindacali ma anche in alcune aree imprenditoriali preoccupate che una strategia di mera difesa della moneta potesse penalizzare il processo di crescita i cui benefici incominciavano a vedersi.
Alcune polemiche recenti che tendono a contrapporre l’eredità positiva del degasperismo liberale a quella negativa del dossettismo statalista, prescindono dalla necessità di storicizzare e di cogliere il maggior problema della stagione riformatrice centrista, quello della ricostruzione delle basi economiche del sistema, per creare occupazione e collegare il mercato interno a quello internazionale.
Dimenticare la condizione materiale del paese di allora, ignorare la sterilità di talune posizioni liberiste nazionali chiuse al confronto con la modernità keynesiana, nata non a caso all’interno di un liberalismo più moderno come quello britannico, vuol dire fare la caricatura di un dibattito interno alla D.C. tutt’altro che banale.
Ospitare le tesi keynesiana, attraverso gli articoli di Federico Caffè in «Cronache Sociali», non può essere liquidato come neo-statalismo, essendo al contrario un tentativo di modernizzazione del nascente sistema.
Tant’è che lo stesso De Gasperi finì per orientarsi pragmaticamente per un mix di scelte liberiste e interventiste: sostenne la strategia inflazionistica di Einaudi, salvò l’IRI, appoggiò Mattei, avviò le riforme agraria e del mezzogiorno affidandone una sorta di alta vigilanza politica proprio a Dossetti, aprì al commercio internazionale, diede spazio a tecnici di formazione nittiana, il più significativo dei quali – Giuseppe Medici – fu reclutato da Dossetti stesso.
Si aggiunse poi a tal proposito in Dossetti l’amarezza di constatare che all’interno del proprio gruppo di amici si era operata la dissociazione importante di Amintore Fanfani che sempre più si affiancò ad Alcide De Gasperi ritenendo che la sua linea non avesse alternative.
Non è un caso se nei due incontri estivi di Rossena nel 1951 in cui fu deciso lo scioglimento del gruppo e annunciato il ritiro dalla politica del suo leader, Dossetti abbia invitato quanti restavano ad assecondare il lavoro di De Gasperi, auspicando, come rivelerà nel colloquio con Lazzati, Scoppola ed Elia, che l’iniziativa passasse nelle mani di Aldo Moro, che era considerato vicino anche se non propriamente interno al gruppo medesimo. Finì così l’esperienza politica di Giuseppe Dossetti.
La parabola politica dei nostri due, come abbiamo detto, si è conclusa, per ragioni diverse, quasi contemporaneamente.
Non è privo di significato che la maggior parte dei «compagni di strada» dell’uno e dell’altro si ritrovasse, dopo il 1953, nello stesso correntone di «Iniziativa democratica», che dominò la D.C. e il governo del paese sino alla svolta del centro sinistra di Aldo Moro.
Tutti, tranne Andreotti e Scelba.
Sarebbe tuttavia un errore ritenere che quelli fossero i loro eredi. Per un certo periodo ne furono i prosecutori, ma eredi in senso proprio sul campo non ne restarono, considerate la grandezza e l’unicità di queste due figure politiche.
In particolare è doveroso riconoscere che l’esperienza di De Gasperi non ha paragoni storici possibili, identificandosi con l’invenzione di un partito nuovo (non solo un nuovo partito, come si direbbe oggi), ma soprattutto con la ricostruzione materiale di un paese uscito in macerie dalla seconda guerra mondiale
Per entrambi si può però parlare di un’eredità politica, in parte condivisa e in parte no, che conserva – pur nella diversità dei contesti storici – per una parte significativa, una certa attualità.
Il tema dell’Europa unita ad esempio, reso ancora più urgente oggi dalla globalizzazione.
Quello della autonomia della politica rispetto ad ogni tipo di «pressura» esterna.
Quello di una strategia «unitiva» del paese, a partire dall’esigenza di forti politiche per il mezzogiorno.
Quello della selezione e della formazione di una classe dirigente non “fedele” (come sembra preferirsi oggi) ma leale e competente.
Quello infine di una difesa definitiva dell’impianto della nostra Carta costituzionale, in particolare dei suoi principi supremi. È solo il caso di ricordare che Dossetti ebbe modo di guidare una campagna in difesa di questi valori negli anni 90 che destò molta impressione e risultò efficace e fruttuosa.
Ma la loro è soprattutto un’eredità morale, che in ultima analisi riguarda il senso, la finalità e la qualità umana della politica. Senso e finalità significano visione e futuro.
Significa guardare, come diceva De Gasperi, «non alle prossime elezioni, ma alle prossime generazioni».
Dossetti in particolare ci affida l’impegno a una «dilatazione del cuore e della mente, nella ricerca nova e creativa di traguardi più alti di vita spirituale e sociale».
«Se ci lasciassimo indurre a ritenerlo un dispensatore di utopie, disperderemmo la sua più autentica testimonianza cristiana e civile: l’impegno rigoroso a riconoscere i segni dei tempi e a scrutare l’avvenire per costruirlo con passione».
Infine, la concezione della politica. Se, come diceva Weber, «il mondo è governato da demoni e chi s’immischia nella politica, ossia si serve della forza e della violenza, stringe un patto con potenze diaboliche… chi non lo capisce in politica non è che un fanciullo», allora bisogna essere attrezzati per reggere un tale patto.
È necessaria fortezza interiore e, soprattutto nei cristiani, una vita spirituale profonda, com’era per De Gasperi, Dossetti e la maggior parte della loro generazione. La politica aveva bisogno allora e, a maggior ragione oggi, di donne e uomini che «vestano abiti virtuosi».
Ha bisogno di uomini integri, di uomini verticali. Ha bisogno di uomini distaccati da ogni interesse personale. Di uomini effettivamente liberi di servire il bene comune.
Su un altro piano possiamo rilevare come l’inizio del pontificato di Papa Francesco stia rivelando i frutti di una pedagogia dell’esempio e della coerenza che, se trasferita in politica, potrebbe produrre in tempi rapidi il frutto del «riavvicinamento» dei cittadini, senza del quale essa rischia sempre più la propria delegittimazione.
La politica ha bisogno di quei dodicimila santi di cui parla Dostoevskij nella Leggenda del Grande Inquisitore.
Ha bisogno che la loro virtù sia esempio imitabile, ma anche presupposto per un’adeguata comprensione della profondità della crisi morale e antropologica di questo tempo, per poterla affrontare, pur nel rispetto dell’autonomia della società.
Oggi ci troviamo nel mezzo di un cambio d’epoca che impone scelte inedite e forti non solo sul piano dell’economia e della definizione di una sovranità europea.
È necessario anche ricostruire un nuovo terreno umanistico sul quale possano ritrovarsi e riconoscersi i tanti cittadini ormai stremati da un individualismo esasperato e distruttivo di ogni legamento sociale oltre che di ogni senso esistenziale.
Servirà recuperare da parte di tutti quella vera laicità che consente la libertà di una ricerca di senso in ogni direzione laddove lo si possa ritrovare, a partire dalla forza di un cristianesimo essenziale e misericordioso, ancora oggi utile compagno di strada dell’uomo contemporaneo.