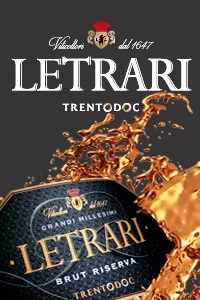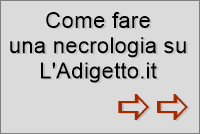Mediterraneo e Medio Oriente, sorvegliati speciali/ 2 – Afghanistan
Proseguiamo la serie di servizi geopolitici sul tema parlando dell’Afghanistan a oltre tre mesi dall’ultima tornata elettorale per L’Afghanistan

>
Dopo oltre tre mesi dall’ultima tornata elettorale per la designazione del nuovo Presidente, i due candidati, Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah, hanno raggiunto, lo scorso 21 settembre, un accordo per la formazione di un governo di coalizione, che sembrerebbe porre termine ad una fase di transizione politica che stava immobilizzando l’Afghanistan dallo scorso aprile.
Il rifiuto di entrambi i candidati di accettare un’eventuale dichiarazione di sconfitta in seguito alla verifica di validazione delle schede elettorali ha portato i due schieramenti a cercare un’intesa preliminare all’ufficializzazione degli effettivi risultati del ballottaggio e, dunque, alla formazione di un nuovo governo di larghe intese.
In virtù di tale accordo, raggiunto ancor prima che fossero resi noti gli esiti del tanto discusso scrutinio elettorale, Ghani è stato designato nuovo Presidente e Abdullah ha assunto l’incarico di Chief Executive Officer (CEO), carica assimilabile a quella di Primo Ministro, abolita a partire dal 2001 e reintrodotta ad hoc per assegnare un incarico anche al candidato di etnia tagica.
Per la prima volta in più di quindici anni, dunque, l’Afghanistan si trova a dover riformulare il proprio sistema presidenziale e a sperimentare un nuovo meccanismo per assicurare l’equilibrio tra i diversi poli di potere nell’esecutivo.
Nonostante la Comunità Internazionale abbia espresso il proprio plauso per il raggiungimento dell’accordo, dunque, sull’effettiva tenuta del nuovo governo di coalizione pesano ancora numerose incognite. Innanzi tutto, non sono ancora stati definiti con precisione gli effettivi poteri del Chief Executive, le cui competenze dovrebbero dipendere dalle deleghe concesse dal Presidente.
Già negli Anni ’90, sei anni prima che il governo dei talebani abolisse definitivamente la carica, il Primo Ministro, di fatto, era una figura meramente cerimoniale, totalmente subordinata al Presidente e che non godeva di poteri effettivi.
La Costituzione formulata nel 2004, dunque in un periodo in cui il premierato era già stato abolito, attribuisce alla carica presidenziale prerogative esclusive nelle materie di primario interesse per la gestione dello Stato, tra le quali la nomina dei Ministri e di tutte le cariche apicali all’interno delle istituzioni afghane, la definizione dell’indirizzo delle politiche adottate dal governo, anche in materia di esteri e, in qualità di Capo di Stato Maggiore della Difesa, di sicurezza.
La definizione di quali tra le competenze presidenziali possano essere ora attribuite al Chief Executive rappresenta, quindi, una priorità per il nuovo governo. In mancanza di un compromesso, infatti, l’alleanza tra i due ormai ex candidati potrebbe rivelarsi meno duratura delle aspettative.
Benché in fase negoziale sia stata definita la possibilità per il CEO di nominare un proprio Gabinetto dei Ministri, quest’ultimo dovrebbe svolgere esclusivamente una funzione consultiva per il Gabinetto presidenziale, a cui spetta invece ogni decisione in merito alla gestione del governo.
Appare però poco probabile che Abdullah sia disposto ad occupare una posizione al momento così marginale per l’effettiva gestione dello Stato: già nelle ore successive alla firma dell’accordo, infatti, Abdullah aveva paventato la possibilità di nominare un uomo di sua fiducia per occupare la carica di CEO, per non rimanere imbrigliato in una posizione che si sarebbe potuta rivelare, di fatto, solo istituzionale. La decisione di assumere l’incarico lascerebbe ora pensare che il candidato tagico abbia ricevuto rassicurazioni sull’effettivo spessore, anche se ancora in via di definizione, della nuova carica.

In secondo luogo, la formazione di un governo bicefalo, sebbene apparentemente rappresentativo delle diverse realtà etniche che compongono il tessuto sociale afghano, potrebbe in realtà rivelarsi un meccanismo di difficile gestione per una classe politica i cui attori sono fortemente legati ai gruppi di potere etno-tribali di cui sono espressone.
Per poter rispecchiare l’eterogeneità etnica del Paese, infatti, tradizionalmente all’interno del governo eletto, le cariche apicali (Presidente e i due Vice Presidenti) vengono spartite tra attori di etnia diversa, secondo precise alleanze, stabilite in precedenza alle elezioni e a garanzia degli interessi dei diversi gruppi etnici.
Benché la formazione di un esecutivo etnicamente eterogeneo non sia, dunque, un elemento innovativo per le istituzioni afghane, tuttavia, la coalizione tra Ghani e Abdullah potrebbe ora scontare la mancanza di una solida alleanza pre-elettorale: tale complicazione deriverebbe dalla difficoltà non solo di omologare le rispettive agende ma soprattutto di trovare possibili punti di contatto, e dunque di sostegno, tra i rispettivi gruppi di potere, rispettivamente di etnia pashtun e tagica.
La scelta di dar vita ad un governo di coalizione, infatti, è frutto dell’urgenza di uscire da un’impasse politica che stava mettendo a repentaglio la credibilità, nazionale e internazionale, delle istituzioni di Kabul più che di una genuina comunione di intenti di lungo periodo.
I due ex contendenti, inoltre, potrebbero essere stati spinti ad affrettare la firma dell’accordo per trovare il plauso, nonché l’indispensabile aiuto, internazionale, necessario per far fronte alla disastrosa situazione economica in cui versano le casse delle Stato.
Se l’intesa, nei prossimi mesi, non dovesse risultare effettivamente genuina, il governo di coalizione potrebbe trovarsi immobilizzato dalle rivalità tra rappresentanti dei due schieramenti, con ovvie ripercussioni sulla capacità di gestione delle già complicate questione interne.
L’interesse del nuovo governo a ricucire i rapporti con la Comunità Internazionale sembra trovare conferma nella repentina decisione di Ghani, a pochi giorni dall’insediamento ufficiale come nuovo Presidente, di procedere alla conclusione degli accordi di sicurezza con Stati Uniti e NATO, rispettivamente il Bilateral Security Agreement (BSA) e il NATO Status of Force Agreement (SOFA).
Tali accordi, indispensabili per definire il quadro giuridico di riferimento per le truppe internazionali che rimarranno nel Paese a partire dal 2015, sono stati, nell’ultimo anno, il principale motivo di deterioramento dei rapporti tra l’ormai ex Presidente Hamid Karzai e le diplomazie occidentali, in primis quella statunitense.
Il perpetrato rifiuto di Karzai a firmare il BSA, infatti, ha portato l’Amministrazione Obama a prendere più volte le distanze da quello che un tempo era considerato il pupillo di Washington in Afghanistan e ha causato un significativo raffreddamento dei rapporti bilaterali.
Con la firma dei due documenti, apposta il 30 settembre dall’ambasciatore statunitense a Kabul, James Cunnigham e dal consigliere afghano per la sicurezza nazionale, Hanif Atmar, sembra ora spianare la strada alla definizione del numero e del dispiegamento dei contingenti internazionali, stimati approssimativamente intorno alle 12.000 unità, che rimarranno nel Paese a partire dal prossimo gennaio.
Gli Stati Uniti avrebbero formulato un piano di rimodulazione del proprio contingente da implementare nel corso del triennio 2015-2018: il numero iniziale di effettivi, stimato introno alle 9.800 unità, dovrebbe essere dimezzato entro la fine del 2016, e dislocato tra la base di Bagram e Kabul, per mantenere poi, nell’ultimo anno, esclusivamente un numero di uomini idoneo a costituire una Forza di protezione all’interno dell’ambasciata.
Accanto al personale militare di Washington, dovrebbero essere ridispiegate anche le truppe internazionali di quei Paesi NATO, tra cui l’Italia, che hanno acconsentito a prendere parte alla nuova missione dell’Alleanza Atlantica in Afghanistan, Resolute Support (RS). Nonostante il considerevole ritardo con cui è stato possibile definire il NATO SOFA, a ormai poche settimane dal termine di ISAF, la nuova missione dovrebbe partire il prossimo 1 gennaio, come previsto dalla pianificazione dei mesi precedenti.

Rispetto ad ISAF, iniziata nel 2002 a Kabul ed estesasi poi in modo capillare per garantire la sicurezza in tutte le province, RS dovrebbe intraprendere il percorso contrario. Infatti la struttura addestrativa dovrebbe prevedere per il 2015 una presenza ancora organizzata sugli attuali quattro Comandi Regionali, per procedere poi, dall’anno successivo, all’accentramento di tutti gli advisor su Kabul. Resta ora da valutare se gli Stati membri dell’Alleanza che dovrebbero essere partner in Resolute Support, potranno rispettare le scadenze dettate dall’avvio della nuova missione o se la dilatazione dei tempi di definizione degli accordi di sicurezza ha avuto ripercussioni sulle possibilità tecniche di un tempestivo ridispiegamento della Forza.
Secondo quanto fino ad ora ipotizzato dal nostro governo, l’Italia dovrebbe mettere a disposizione circa 800-1.000 uomini, tra personale addestrativo e di supporto (protezione delle Forze, logistico e soccorso), e mantenere il comando dell’area di responsabilità delle province di Herat, Baghdis, Ghor e Farah, nell’ovest del Paese.
Nell’ambito di tale missione i contingenti internazionali dovrebbero portare avanti fino al 2018 i programmi di addestramento e advisoring per le Forze di sicurezza afghane (Afghan National Security Forces – ANSF), e scongiurare così la messa in discussione dei risultati raggiunti in dieci anni di presenza sul terreno.
Nonostante i progressi registrati dalle ANSF nel rispondere con efficacia agli attacchi della militanza talebana, le condizioni di sicurezza all’interno del Paese sono sensibilmente peggiorate negli ultimi tre mesi.
Nel solo mese di settembre, infatti, sarebbero circa 200 le vittime causate dalle violenze dell’insorgenza, sia civili sia militari.
La situazione risulta particolarmente precaria soprattutto nelle regioni orientali, da sempre meno gestibili dalle Forze di sicurezza sia per una maggior predisposizione del tessuto sociale ad appoggiare la causa dell’insorgenza sia per il vantaggio logistico che i militanti riescono ad ottenere dalla porosità del confine con le Agenzie Tribali pakistane, spesso luogo di rifugio per molti dei combattenti impegnati in territorio afghano.
Lo scorso 26 settembre, infatti, un gruppo di talebani ha preso il controllo del distretto di Ajerstan, nella provincia di Ghazni, uccidendo 70 persone, 15 delle quali decapitate perché sospettate di collaborare con le autorità di Kabul.
Nei giorni precedenti un assalto coordinato al palazzo del governo della città di Gazhni, nell’omonima provincia, aveva provocato 10 vittime e il ferimento di altre 160 persone.
Possibile testa di ponte per intensificare le operazioni nell’est del Paese, la provincia di Gazhni non è il solo punto strategico di cui i talebani sembrano ormai avere il controllo.
A metà settembre, infatti, un’offensiva talebana nel distretto di Sangin (Helmand) ha permesso all’insorgenza di guadagnare il controllo di uno degli hub strategici per la coltivazione e il commercio dell’oppio.
Il progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza e il rinvigorimento dell’efficacia operativa dell’insorgenza ha un impatto non solo sulle effettive possibilità di controllo da parte delle ANSF del territorio ma anche sul morale delle stesse Forze Armate, spesso obiettivo privilegiato degli attacchi dell’insorgenza.
La frustrazione per i precari risultati contro la militanza talebana rischia però di acuire la pressione psicologica a cui i militari afghani sono sottoposti, con il pericolo che si verifichino episodi di violenza interni alle fila militari o, più frequentemente, contro gli addestratori e il personale militare internazionale (i così detti attacchi «green on blue»).
Risale allo scorso 5 agosto la morte del Generale statunitense Harold Green per mano di un soldato afghano a Camp Qargha, accademia di addestramento gestita dal contingente britannico, vicino a Kabul. Green, vice comandante del Combined Security Transition Command, è il militare statunitense più alto in grado deceduto in Afghanistan dal 2001.
L’intensificazione dell’attività talebana nel Paese, al momento, sembra non lasciare grandi prospettive per la ripresa del dialogo con le autorità del governo.
L'apparente opportunità di intavolare trattative tra l’Alto Consiglio per la Pace, organo preposto alla guida di un’eventuale trattativa, e alcuni rappresentanti dei Talebani a Doha, già nei mesi scorsi non era sembrata effettivamente perseguibile. Il fermo rifiuto da parte della leadership talebana di riconoscere l’ex Presidente Karzai come proprio interlocutore, infatti, ha sempre ostacolato qualsiasi progresso in questa direzione.
Nonostante il nuovo governo afghano abbia espresso la necessità per Kabul di cercare una soluzione politica alla pluriennale insorgenza nel Paese, tuttavia, rimangono ancora numerose le incognite circa l’effettiva percorribilità di questa soluzione.
Innanzi tutto, appare poco probabile che, in un momento in cui la militanza riesce a mettere in seria difficoltà le autorità statali, i leader talebani accettino di sedersi ad un tavolo negoziale che, inevitabilmente, ridimensionerebbe la portata della propria agenda politica all’interno del Paese.
In secondo luogo, qualora dovesse aprirsi uno spiraglio per un eventuale dialogo tra le parti, la posizione di forza da cui, in questo frangente, gli esponenti talebani condurrebbero eventuali trattative, limiterebbe considerevolmente lo spazio d’azione della delegazione governativa.
Gabriele Iacovino
Cesi
(Precedente - Continua)