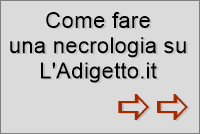Il silenzio delle case chiuse – Di Maurizio Panizza
Il fenomeno della prostituzione e la svolta del ’58 fra Trento e Rovereto

Foto di gruppo in una casa di tolleranza.
| L’articolo che segue, con un tema inusuale, può sembrare quasi antifemminile per la Giornata della Donna. Il nostro collaboratore Maurizio Panizza descrive quelle che furono le case di tolleranza a Trento e a Rovereto e la «svolta» del 1958 con la loro definitiva chiusura. Ripercorrere quella storia così lontana nel tempo, conoscere quel doloroso fenomeno sociale, significa aiutare a comprendere molte donne che per la società d’oggi sembrano non esistere e di cui non si parla mai. Nemmeno all’8 marzo. |
Oggi, lungo la strada poco illuminata c’è chi passa in macchina e si gira dall’altra parte: ipocrita, non vuole vedere, né sapere nulla.
Poi c’è chi, con aria perbenista e giudicante, usa parole sprezzanti appellandosi all’ordine pubblico e al rigore della legge.
All’opposto, c’è chi guarda con morbosa insistenza e non resiste all’istinto di fare sorrisini e battute idiote, di dire una cosa per pensarne un’altra. Eppure, stiamo parlando di donne, non di oggetti o di animali.
In genere, purtroppo, è sempre stato così: le prostitute o le si ignora, come non esistessero, o le si condanna, oppure le si sfrutta in vari modi. E dire che lo «sfruttamento» della prostituzione (non la prostituzione in sé) in Italia è proibito dal lontano 1958, da quando cioè la cosiddetta Legge Merlin decretò, fra mille polemiche, la definitiva chiusura delle case di tolleranza.
Per questo, tornare là, a quel settembre di quasi sessant’anni fa, è utile per comprendere meglio il fenomeno.
E farlo attraverso una visione locale - indagando cioè la prostituzione nell’area fra Trento e Rovereto - può essere ancora più illuminante, anche se comunque è da dire che per tutto il Paese, quella del ’58 fu indubbiamente una grande vittoria della dignità della donna e la fine di  un’epoca buia.
un’epoca buia.
Purtroppo, però, non si rivelò la soluzione definitiva del problema. Infatti, subito dopo si assistette all’inizio dello sfruttamento clandestino della prostituzione e all’affiorare di ulteriori dubbi nell’opinione pubblica su come affrontare una questione che periodicamente si sarebbe riproposta con forza sino ai nostri giorni.
Così, conoscere questa storia, anche quella più lontana nel tempo, significa comprendere a fondo queste donne.
Donne spesso schiave, a volte - paradossalmente - più libere ed emancipate di tante loro contemporanee.
Donne ignoranti o istruite, povere o benestanti, disperate o fiduciose nel futuro, vere o finte.
Donne che si portano appresso lo stigma sociale della riprovazione, donne oggetto di un vergognoso contratto mercantile all’interno del quale, però, molto spesso sono proprio loro a risultare i soggetti migliori, i più ricchi di cuore, di altruismo e di umanità.
Del resto anche Fabrizio De André, il grande poeta dei sentimenti, parlando di chi fa la vita, cantava «Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior».
Un silenzio imbarazzante durato più di un secolo, scomodo e scabroso soprattutto se rapportato a piccole realtà come il Trentino.
È quanto successe alla questione delle cosiddette case chiuse, ovvero case di tolleranza, bordelli o casini che dir si voglia.
Una questione controversa, incessantemente sussurrata, ma sempre rimossa ovunque come la peggiore delle depravazioni e quindi da non affrontare mai in pubblico perché moralmente scorretta.
Già il fatto di parlarne ora, a qualcuno potrà suscitare fastidiose pruderie o compiaciuti desideri inconfessabili.
Tuttavia, nessuna partigianeria si cela dietro a queste righe se non il desiderio di capire e di raccontare con obbiettività un fenomeno sociale, e, assieme ad esso, l’ipocrisia che sta dietro da sempre, le pulsioni che ha soddisfatto e i dolori che ha causato, corsi e ricorsi che continuano allo stesso modo ancora oggi senza grandi differenze.

Ma veniamo al punto cruciale. In Italia, quasi sessant’anni fa, esattamente il 20 settembre 1958, le case del sesso libero chiudevano definitivamente le porte, buttando sulla strada - è il caso di dire - quasi tremila prostitute.
Eppure, fino ad allora, tollerare un fenomeno antico come il mondo era sempre stata un’azione condivisa fra Stato e Chiesa, a patto però di non parlarne mai esplicitamente, men che meno in pubblico.
Tollerare nella doppiezza è sempre stata una specialità italiana. Nel corso del Ventennio, lo aveva fatto egregiamente il regime fascista, come prima l’avevano fatto l'Italia di Cavour, quella di Crispi e quella di Giolitti e come, dopo il 1946, per dieci anni lo fece pure quella repubblicana e democristiana.
Tutti a condannare in pubblico e tutti a tollerare in privato, ognuno con i propri interessi e le proprie debolezze da nascondere.  In effetti, dietro a quelle finestre perennemente chiuse e dentro a quei locali impregnati di talco e di lisofomio, si fondevano e si confondevano spinte uguali e contrarie: moralità e peccato, dio e demonio, libertà e sfruttamento, gioie e sofferenze, passioni private e partecipazioni di Stato.
In effetti, dietro a quelle finestre perennemente chiuse e dentro a quei locali impregnati di talco e di lisofomio, si fondevano e si confondevano spinte uguali e contrarie: moralità e peccato, dio e demonio, libertà e sfruttamento, gioie e sofferenze, passioni private e partecipazioni di Stato.
Tutto ciò, insieme ipocritamente, per avere ognuno il proprio tornaconto.
Nessuna classe sociale rimaneva esclusa dal novero degli «ospiti» di quelle case particolari. La media borghesia era stata da sempre quella più rappresentata attraverso professionisti, imprenditori, impiegati (e pure qualche prete), ma dopo la metà degli anni Cinquanta anche il popolo degli operai si affacciò sempre più numeroso alle porte dei casini: il boom economico, che di lì a poco avrebbe trasformato profondamente la società italiana, stava dando anche in questo campo i primi timidi segnali dai quali neppure il Trentino sarebbe rimasto escluso.
Così, con il passare del tempo e con l’apertura degli orizzonti culturali - per così dire - il sabato e la domenica iniziarono a scendere in corriera dalle valli pure frotte sempre più numerose di contadini.
Costoro, con la scusa di qualche fiera di attrezzi agricoli o di animali si recavano, in realtà, là dove di fiere ce n’era sì una, ma purtroppo di tutt’altro genere.

Tuttavia, il momento magico dell’iniziazione al sesso, quello che segnava il passaggio all’età adulta, era da sempre riservato ai giovani coscritti che andavano alla visita di leva.
Fu la classe del 1940 - quelle cioè di chi aveva già compiuto i diciotto anni all’entrata in vigore della legge - l’ultima generazione che varcò le porte delle case chiuse.
E fra tutte queste varie tipologie di clienti, chi poteva farlo evitava di frequentare le case chiuse della propria città per ovvie ragioni di riservatezza. In tal modo si innescava spesso un pendolarismo sessuale da Trento verso Bolzano (celebre nella città del Talvera, il «Navarro», o la «Casa» di via Conciapelli), oppure verso Rovereto e viceversa.
A Trento, fino al settembre del 1958, erano tre le case ufficiali in funzione: quella di via Brennero, frequentata più che altro dai militari presenti nel capoluogo (durante la Prima Guerra una casa per soldati era presente in via Malpaga e, negli anni ’40, una in via Petrarca), poi una casa in via San Martino e un’altra in via Secondo da Trento, nei pressi della vecchia caserma dei pompieri, in piazza Centa.  Per via di questa sua collocazione, nel gergo dei trentini «andare dai pompieri» aveva assunto negli anni un significato ben preciso che nulla, ovviamente, aveva a che vedere con i vigili del fuoco.
Per via di questa sua collocazione, nel gergo dei trentini «andare dai pompieri» aveva assunto negli anni un significato ben preciso che nulla, ovviamente, aveva a che vedere con i vigili del fuoco.
Qui, in un’antica palazzina, nascosta in parte da un’alta fila di pioppi, era ospitata la casa più importante della città.
Ad essa si accedeva per un giroscale di gradini in pietra e per una piccola porta al primo piano che dava su di una sala comune. Solo per entrare si pagavano dieci lire. Da lì, seduti su delle panche poste al perimetro della stanza, i clienti potevano osservare le signorine, poi scegliere quella che più piaceva e quindi salire nelle camere.
Sulla sala, inoltre, si affacciavano quattro stanze - i salottini, come venivano chiamati - usati da quei clienti più danarosi che volevano mantenere un assoluto riserbo sulla loro visita.
Una curiosità: per permettere a costoro di non essere visti, sia nel momento della loro entrata che in quello dell’uscita la tenutaria tirava una lunga tenda che veniva a creare una specie di corridoio separato dalla sala comune, permettendo così a questi ospiti di potersi muovere nella casa con la massima riservatezza.
A Rovereto, invece, circa negli stessi anni operava una sola casa di tolleranza. Era l’ultima di una sparuta pattuglia di casini che sin da tempi immemorabili erano presenti in città.
La più antica casa di incontri di cui si ha cognizione, già esistente nel ’600, era quella che alcuni ricercatori individuano oggi in Via della Terra, al civico 27, dove oggi (ironia del destino!) è ubicata l’associazione «Casa delle donne».
Due secoli più tardi, una casa di tolleranza troverà collocazione in Scala della Torre, fra Piazza Erbe e Via della Terra, dove attualmente si trova una trattoria tipica, mentre negli anni ’30 del Novecento, pare che un altro bordello fosse collocato in una casa isolata in Via Ronchi, nei pressi della S.S. 12, vicino all’attuale caserma dei pompieri.

Quella che fu l'ultima Casa chiusa di Rovereto.
Tuttavia, il bordello che rimase in attività fino all’inizio degli anni Cinquanta - quindi fino a pochi anni prima che la legge decretasse la chiusura delle case - fu quello ospitato nei locali di un’elegante palazzina in stile liberty - chiamata allora «Villa delle Rose», tuttora esistente in Lungo Leno destro, a quel tempo zona del tutto isolata dal contesto cittadino.
Lì, in quella casa borghese, dedicata in particolar modo ad un erotismo altolocato, sembra esercitassero la loro professione 3 -4 giovani donne, le quali ogni quindici giorni lasciavano il posto ad altrettante, secondo la vecchia regola dell’avvicendamento per evitare che nascessero legami troppo stretti con i clienti.
Riguardo al numero parliamo al condizionale, per un motivo ben preciso. In effetti, prima di continuare questo singolare racconto è importante ricordare come qualsiasi ricercatore che in passato si sia accostato a tale argomento, abbia sempre trovato enormi difficoltà a reperire informazioni di prima mano. Ed è ovvio che più passa il tempo, più complicato diventa poter trovare testimoni diretti di quegli anni. Se a ciò aggiungiamo che la bibliografia locale su tale questione è quasi del tutto inesistente, possiamo allora ben capire come nel corso del tempo sia stata eretta attorno alle case di tolleranza una barriera di silenzio pressoché invalicabile.
trovare testimoni diretti di quegli anni. Se a ciò aggiungiamo che la bibliografia locale su tale questione è quasi del tutto inesistente, possiamo allora ben capire come nel corso del tempo sia stata eretta attorno alle case di tolleranza una barriera di silenzio pressoché invalicabile.
Del resto, nei decenni precedenti la loro chiusura, le leggi emanate dal regime fascista e poi mantenute per consuetudine anche nel dopoguerra, furono molto rigorose in tema di riservatezza. Si pensi, ad esempio, che negli anni ’30, Mussolini impose ai tenutari delle case di tenere sempre le imposte chiuse (da qui il termine entrato nel lessico comune) e in certi casi di isolare gli edifici con i cosiddetti «muri del pudore», alti almeno dieci metri; oppure che nessuna indicazione doveva essere affissa sulla pubblica via e nemmeno esserci la possibilità di vedere cosa succedeva all’interno della proprietà, pena gravi sanzioni amministrative o condanne penali per adescamento.
Addirittura si era arrivati al punto che le disposizioni di polizia vietavano severamente a chiunque di fornire per strada indicazioni sull’ubicazione dei postriboli.
Solo gli agenti di pubblica sicurezza erano autorizzati a dare informazioni ai clienti su come raggiungere le «case di piacere». Nessuno, insomma, in quel clima ambiguo e ipocrita poteva parlarne.
Ma torniamo alla villa di Rovereto. Al suo interno, nella prima sala in cui venivano ricevuti gli ospiti, era collocata bene in vista una targa che riportava le tariffe.
Verso la metà degli anni ’50 ogni prestazione costava da un minimo di 200 lire (5 minuti in una casa di terza categoria) fino a 8.000 (un'ora in una casa di lusso), cioè in moneta attuale, per approssimazione, da 3 a 95 euro.
Detto così, sembra molto poco, ma tenendo conto che ogni ragazza serviva da 30 a 50 clienti al giorno, il totale che si ottiene non è affatto indifferente.  Inutile dire che a fronte di tali ritmi a dir poco disumani, solo una parte infinitesimale di quell’enorme fiume di denaro finiva in mano alle prostitute. La parte più cospicua, infatti, andava ai tenutari delle case e, in percentuale, alle casse statali, le quali incameravano annualmente circa 100 milioni di lire, pari a 1,2 milioni di euro di oggi. In cambio, lo Stato forniva alcuni servizi, fra cui la registrazione agli Uffici del Lavoro che prevedeva, fra l’altro, un periodo di apprendistato e il versamento dei contributi obbligatori per la pensione e la disoccupazione.
Inutile dire che a fronte di tali ritmi a dir poco disumani, solo una parte infinitesimale di quell’enorme fiume di denaro finiva in mano alle prostitute. La parte più cospicua, infatti, andava ai tenutari delle case e, in percentuale, alle casse statali, le quali incameravano annualmente circa 100 milioni di lire, pari a 1,2 milioni di euro di oggi. In cambio, lo Stato forniva alcuni servizi, fra cui la registrazione agli Uffici del Lavoro che prevedeva, fra l’altro, un periodo di apprendistato e il versamento dei contributi obbligatori per la pensione e la disoccupazione.
C’era poi il servizio sanitario attraverso il quale un ufficiale medico eseguiva due-tre visite di controllo alla settimana alle prostitute e due volte all’anno per il rimanente personale della casa. Inoltre, doveva essere tenuto con scrupolo un Registro giornale nel quale veniva descritta in maniera dettagliata ogni cosa attinente l’andamento dell’impresa, come ad esempio i nomi delle ragazze in servizio, le loro assenze (che dovevano essere sempre giustificate), le ispezioni sanitarie, ma soprattutto l’elenco dei clienti con scritto l’orario di entrata e di uscita, gli estremi dei documenti e le loro generalità.
È da notare, ancora, come tutta l’organizzazione fosse sottoposta al rigoroso controllo della Prefettura, del Podestà (ovvero del Sindaco in epoca repubblicana) e del presidente la Commissione per la Censura, nella fattispecie un alto religioso nominato dalla Curia. In più è da dire che ogni tre-cinque anni la prostituta doveva rinnovare tutti i documenti fra cui il suo certificato di moralità che attestava essere, oltre ad un’integerrima cittadina, pure una brava cristiana dedita ai sacramenti.

Con il 1958, ormai sappiamo, tutto ciò venne azzerato. A Trento, quel giorno, un attento testimone, forse non del tutto disinteressato, annotò: «Mi trovavo lì per lavoro e vidi una gran folla in via San Martino. Era la coda per l'ultimo giorno di apertura della casa di tolleranza».
A Rovereto, invece, la casa lungo il torrente Leno aveva già sospeso l’attività da tempo ed era stata venduta. Adesso le finestre erano tornate ad aprirsi e il vecchio proprietario, da una delle poche testimonianze potute acquisire, si era trasferito in un appartamento in centro città. Lì era andato ad abitare con una bella giovane che un tempo era stata una delle sue ragazze di vita.
Certamente la chiusura delle case di tolleranza per la storia del costume italiano fu una svolta epocale. Una svolta che comunque divise il Paese perché la riforma abolì un «qualcosa», ma non lo sostituì con nient’altro.
Per molti fu una vera conquista di civiltà; per altri fu solo un'ipocrisia.
Per i movimenti femminili venne giustamente considerato un importante passo per affermare la dignità della donna.  Invece per tanti intellettuali, fra cui Indro Montanelli, opinionista controcorrente - ma anche per lo scrittore Dino Buzzati - fu addirittura «un colpo di piccone capace di far crollare l'edificio della Fede cattolica, della Patria e della Famiglia».
Invece per tanti intellettuali, fra cui Indro Montanelli, opinionista controcorrente - ma anche per lo scrittore Dino Buzzati - fu addirittura «un colpo di piccone capace di far crollare l'edificio della Fede cattolica, della Patria e della Famiglia».
Perché era nei postriboli - sosteneva Montanelli - che queste tre istituzioni trovavano l’equilibrio su cui si basava la società italiana. E spingendosi ancora più in là, in un impeto dissacrante tutto suo, aggiungeva: «Il bordello è l'unica istituzione italiana dove la competenza è premiata e il merito riconosciuto».
Per l’ordine pubblico, infine, fu un problema, perché la prostituzione uscì dalla case chiuse ma non sparì affatto: si riversò sulle strade e in pensioncine compiacenti, sfuggendo al controllo statale per finire quasi sempre in mano alla malavita.
Fra le prostitute ci fu chi riuscì a tornare ai propri paesi e alle famiglie di origine. Altre, soprattutto quelle convinte di essere in grado di fare solo quel mestiere, si riciclarono in proprio, oppure trovarono un protettore.
Altre, ancora, riuscirono a farsi sposare da qualche ricco e vecchio cliente, rientrando in una normalità che forse per anni avevano solo sognato.
Comunque sia, per tutte quelle ragazze, che nella maggior parte erano state iniziate a tale vita dalle necessità familiari, rimase l’amaro di un’epoca di sfruttamento, di condanna e di emarginazione sociale .
Una di loro, Margherita (forse «nome d’arte» in onore della santa protettrice delle prostitute), così tristemente annotava nel 1934 sulle pagine del suo diario.
«Se tutte le madri allevassero con la giusta educazione i propri figli nel rispetto di se stessi e degli altri.
«Se tutte le mogli amministrassero l'intimità del matrimonio come fanno per il salario del proprio marito.
«Se tutti i padri si preoccupassero di dare sempre il buon esempio, oltre che portare a casa il pane, il nostro lavoro di prostitute non avrebbe più nessun senso di esistere, perché saremmo tutte disoccupate.»
 Maurizio Panizza - ©Cronista della Storia - [email protected]
Maurizio Panizza - ©Cronista della Storia - [email protected]
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, del testo e/o delle fotografie originali sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta.