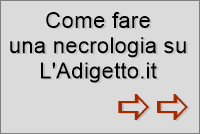Street art: 2501 – Di Daniela Larentis
L’artista milanese è uno dei più importanti esponenti dell’arte urbana a livello nazionale e internazionale – L’intervista

2501, San Paolo Brasil 2015, foto dell’artista ©.
Jacopo Ceccarelli, in arte 2501, è un artista milanese di fama nazionale e internazionale che opera principalmente in Italia, in Europa, negli Stati Uniti e in Sud America, considerato uno dei maggiori esponenti di arte urbana non solo nel nostro Paese.
Cresciuto in una comunità tibetana, lavora principalmente attraverso linee e forme, in composizioni libere. Ha un passato da writer, prima di firmarsi 2501 era conosciuto come Robot inc, citato peraltro nel volume curato da Tristan Manco dal titolo «Street Logos», edito da Thems and Hudson, pubblicato per la prima volta in inglese negli anni Novanta.
Nel 2005 partecipa con questo pseudonimo a Urban Edge Show a Milano, insieme a Blu, a Obey venuto dall’America, e ai più importanti esponenti della Street art mondiale.
Per quanto riguarda la sua formazione, dopo il liceo scientifico frequenta la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano e poi consegue un Master in Visual Communication alla Nuova Bauhaus a Weimar, in Germania.
In Brasile, dove va a vivere per diversi anni, si forma artisticamente, venendo a contatto con il mondo della Street art sudamericana e grandi artisti come Os Gemeos, diventati poi molto famosi, Herbert Baglione, Higraff, Vitché e altri.
«La linea, la superficie e il punto sono le unità minime necessarie alla rappresentazione grafica» sottolinea l’artista, da sempre affascinato dall’idea che la complessità di una struttura derivi dalla somma e dalle interazioni di sotto strutture più semplici.
Un concetto, quello di interconnessione, tradotto con grande efficacia nei video del ciclo Nomadic Experiment, frammenti che cercano di raccontare le impressioni sul suo lavoro dell’ultimo decennio, una sorta di mappa mentale che traccia, come lui stesso racconta, «una traiettoria emozionale», ma è evidente anche nella serie di video e sculture LA MACCHINA.
I Nomadic Experiment ben rappresentano la condizione dell’uomo contemporaneo sempre «sull’orlo del precipizio», in rapido movimento e in preda a una frenesia crescente.
È quella postmoderna che Bauman definisce nelle sue pubblicazioni «società liquida», contrapposta alla modernità solida, un passaggio in cui vengono meno tutte le certezze su cui è stata costruita la modernizzazione.
Sottolinea il grande sociologo e filosofo polacco, scomparso nel 2017, che si tende a vivere un’esistenza liquida: nella contemporaneità la vita e la società non sono in grado di conservare la loro forma.
Abbiamo avuto il piacere di raggiungere telefonicamente 2501, porgendogli alcune domande.

2501, Berlino 2017, Urban Nation, foto Dario Laganà ©.
Partiamo dal suo nome d’arte: perché ha scelto lo pseudonimo 2501?
«Prima mi firmavo Robot inc, con questo pseudonimo sono presente anche su uno dei primi libri sulla Street art curato da Tristan Manco, dal titolo Street Logos, edito da Thems and Hudson, uscito in inglese negli anni Novanta.
«Robot inc era più legato al mondo dei graffiti, a un certo punto ho avvertito l’esigenza di cambiare; ho adottato lo pseudonimo di 2501 per diverse ragioni, anzitutto mi piaceva il numero, optare per un nome strano mi sarebbe sembrato troppo giovanilista come atteggiamento, sono ripartito da me stesso e quindi dalla mia data di nascita, che peraltro è la data di fondazione della città di San Paolo in Brasile.
«Quella che ho vissuto in Brasile è stata un’esperienza che effettivamente ha rivoluzionato il mio modo di concepirmi come artista, ho vissuto là parecchi anni in un periodo di pieno fermento.»

2501, Chicago 2015 ©.
L’esperienza vissuta a San Paolo come ha influito sul suo modo di approcciarsi all’arte?
«Ho vissuto a San Paolo per quasi 5 anni. È da questa esperienza che è scaturito il lavoro di 2501. Prima facevo altre cose, più legate ai graffiti e a un momento iniziale della mia ricerca, sono stato un writer puro dall’età più o meno di 14 anni fino ai 20.
«San Paolo peraltro è stata fondata lo stesso giorno in cui sono nato io, il 25 gennaio, il giorno del mio compleanno è sempre festa della città, e 2501 è anche il nome che ho scelto.
«La prima mostra di 2501 si è tenuta a San Paolo dove ho incontrato la scuola sudamericana che era molto avanti, rispetto agli artisti europei, là esisteva già quello che poi verrà identificato con la Street art. C’era un gruppo di persone che ho conosciuto, come Os Gemeos, diventati poi molto famosi, Herbert Baglione, Higraff, Vitché e altri, che già dipingevano in strada invece di lettere veri e propri mondi popolati da personaggi, facevano nel 2000 quello che nel 2010 sarebbe stata ancora considerato innovativo da noi; anche se ero molto giovane e per lo più stavo con quelli della mia età, sono venuto a contatto con una serie di personaggi della prima generazione, spiriti innovativi, fra cui Daim, per fare un nome di un artista europeo, esperienze importanti che hanno completamente rivoluzionato il mio modo di intendere cosa volesse dire fare poi effettivamente un intervento in strada, personaggi che nel corso della mia vita ho avuto modo di conoscere meglio, in viaggi posteriori in Brasile.
«Quello che facevano Os Gemeos negli anni 2000 era già arte pubblica, molto di più di quello che all’epoca facevo io dipingendo treni o facendo tag. Sicuramente il Brasile ha avuto un impatto notevole sul mio modo di fare arte, dandomi modo di approfondire le possibilità di lavorare all’interno dello spazio urbano. È stato fondamentale.»

2501, Kiev, 2016, part. ©.
Lei lavora principalmente attraverso linee e forme, in composizioni libere. Quali sono i soggetti da cui trae maggiormente ispirazione?
«Con 2501 ho effettuato una sottrazione di tutti i colori per dedicarmi effettivamente solo al bianco e nero, quindi alla luce e a questi due non colori, ho poi aggiunto nel tempo il magenta fluo e l’oro metallizzato. L’idea era un po’ quella di dare il via, attraverso una sintesi di quello che avevo fatto nei primi dieci anni, a un nuovo percorso.
«All’inizio, mi riferisco al primo anno, ho continuato a lavorare sulla parte figurativa e quindi usavo la tecnica delle linee per renderizzare delle figure che rinviavano al Buddismo Vajrayāna, tantrico tibetano, in quanto mi sembravano degli archetipi di una serie di riflessioni che stavo facendo e che interessavano anche il mio lavoro.
«Poco dopo mi sono accorto che in realtà il lato figurativo inibiva l’inizio di questa nuova fase, tramite la mia tecnica io in realtà cercavo di descrivere il tempo di esecuzione dell’opera stessa, quindi, cercavo di lasciare una traccia del processo e l’astratto era ciò che si addiceva al tipo di riflessione che stavo portando avanti, la rappresentazione dell’atto del dipingere in sé.
«Ogni elemento, le persone, la superficie del muro, il tempo, concorrono quindi alla formazione delle forme che vengono a crearsi. I primi 14 anni di attività, non avendo fatto l’accademia, hanno rappresentato per me una sorta di scuola, di gestazione di quello che considero il mio vero lavoro e che parte intorno al 2010 con la sperimentazione delle linee in bianco e nero.
«L’inizio di un lavoro artistico non giovanilista, accompagnato da una consapevolezza di quello che sto facendo molto più sviluppata, risale a una decina di anni fa, anche se io faccio mostre da 20 anni. La mia prima mostra l’ho fatta nel 1999-2000.
«Nel 2005 ho partecipato come Robot inc a Urban Edge Show a Milano, insieme a Blu, a Obey venuto dall’America, e ai più importanti esponenti della Street art mondiale. Se parliamo specificatamente della mia attività su muro, i miei lavori oltre ad essere descrittivi del tempo dell’esecuzione, oltre a parlare sempre e comunque della centralità del processo all’interno del processo artistico, parlano anche di tematiche, per esempio una tematica su cui ho lavorato molto è lo spazio negativo.
«Ho fatto anche delle installazioni video, in Nomadic Experiment ho cercato di raccontare una serie di impressioni sul mio lavoro degli ultimi dieci anni, tracciandone una traiettoria emozionale.»

2501, La Macchina, Museo di Lissone, foto Ronny Campana ©.
Quali sono le tecniche che lei utilizza nella realizzazione delle sue opere?
«Spazio a 360 gradi: parto dal muralismo, sicuramente arrivo alla pittura, con gli acrilici su tela, con la china su tela, con i colori a base d’alcool su superfici plastiche, che è stata per molto tempo una mia caratteristica, sperimentando vari materiali. Pittura su alluminio, partendo da serigrafia per poi muovere la serigrafia a mano prima che si asciughi, come nell’ultima mostra, ho fatto tantissimi monotipi, tantissima incisione, acquarelli.
«Mi sono dedicato anche alla scultura, ho realizzato sculture di grosso formato come quella nel castello di Bomarzo, un uomo di grandi dimensioni fatto di foglie alto quasi 4 metri e lungo quasi 7, ho realizzato una scultura analoga al museo archeologico di Como, un uomo sdraiato fatto di legni, muschi, il tutto senza chiodi, opere che risalgono a prima del 2010.
«Dopo, mi sono concentrato molto sulla ceramica e sui metalli, ho lavorato molto con l’alluminio e con il rame. E poi mi sono dedicato alla videoarte, il video accompagna la maggior parte dei miei lavori, è come se fosse una specie di sotto testo di ciò che faccio.
«Con la mia formazione cinematografica, io ho fatto la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano e poi ho conseguito un Master in Visual Communication alla Nuova Bauhaus a Weimar, in Germania, è tutto molto a cavallo fra il documentario e la videoarte.
«Alcuni sono proprio dei mini documentari girati e montati da me, altri sono degli esperimenti nomadici, i Nomadic Experiment (visualizzabili sul sito a questo link).»

2501, Roma 2015 per personale a Wunderkammern gallery, foto Blindeyefactory ©.
La tecnica dell’acquarello è immediata, difficile, in quanto non permette errori, trasparente non solo dal punto di vista del colore…
«Queste caratteristiche che ha appena elencato sono parte fondante del mio lavoro pittorico, quindi l’immediatezza, l’assenza di uno sketch preliminare, il prediligere il fatto di non cancellare mai all’interno di una realizzazione, dando vita a un’opera che si autosostiene e viene creata in un unico movimento senza ripensamenti.
«Ovviamente provengo dal mondo del graffitismo, dove c’è immediatezza, richiesta di una pittura quasi sportiva, poco tempo a disposizione per poterla realizzare, un certo tipo di tensione esplosiva che poi è il motore del dipinto stesso.»
C’è un particolare messaggio che lei ama trasmettere attraverso le sue opere?
«Se dovessi far passare un unico messaggio sicuramente sarebbe quello dell’importanza del processo, quindi il fatto che il processo spesso e volentieri è più interessante del risultato finale. Il processo necessità di lucidità, bisogna essere presenti, coscienti, trarre piacere dal fare durante il suo sviluppo.»
Assumendo quest’ottica, dal suo punto di vista il processo creativo è quindi più interessante del risultato finale che a quel punto ne diventa conseguenza…
«Certo, è un discorso che non vale solo per il processo creativo ma spesso e volentieri anche per altri processi, per esempio di crescita; più che avere l’ansia di diventare qualcosa che non si è meglio cercare di godersi il tentativo di cambiare e di studiarsi, di capirsi, senza perdersi in troppe proiezioni nel futuro, cercando di rimanere nel presente, vivendolo appieno.»
![]()
2501, Visual sequencing and tracking skils 2019, Solo Show Miami . Ceramic and gold leaf, ©.
Lei è recentemente tornato dal Perù. Può parlarci di questa esperienza?
«Sono nato e cresciuto in una comunità tibetana, con un maestro Vajrayāna tibetano, ultimamente in occasione degli ultimi ritiri in Indonesia ho conosciuto una ricercatrice dell’Unesco di una sessantina d’anni che lavora da 20 anni in Perù e che ha reso la pratica del mio maestro tibetano Juan Flores Salazar patrimonio immateriale dell’Unesco (sta facendo la stessa cosa con un Kurandero di 70 anni Asháninka peruviano).
«Sono due anni che vado a fare dei ritiri da questo maestro. È un percorso spirituale, di cura, di introspezione e automaticamente anche di sviluppo di tutta una serie di tematiche che poi inevitabilmente escono anche attraverso quello che faccio a livello artistico.
«Sono andato là ad aiutare questa ricercatrice, anche lei discepola del maestro Juan Flores Salazar, anche per aiutare ad espletare una serie di questioni che potrei definire pratiche.»
![]()
Visual sequencing and tracking skils 2019, Solo Show Miami, foam tarpaulin, white acrylic, ceramic ©.
Come traduce il concetto di sostenibilità ambientale artisticamente?
«Sicuramente è un concetto che mi sta a cuore e di grande attualità, in realtà fa parte di una mia visione che ho sull’opera d’arte in generale. Gli autori che preferisco sono quelli che con pochissimo riescono a fare molto.
«Il mio è un lavoro artistico introspettivo, che parte da una riflessione su me stesso per poi collegarsi a tematiche più ampie, più universali, in una maniera non proprio didascalica, tant’è vero che spesso nel sito Nomadic Experiment cerco di porre in video tutta una serie di idee e suggestioni che magari, se qualcuno non conosce approfonditamente la mia arte, non può cogliere semplicemente guardando una mia opera.
«Già nell’atto di realizzare graffiti c’è una protesta intrinseca su tutto quello che può essere considerato inquinamento visivo; ne nasce subito una riflessione sul fatto che è vero per esempio che i graffiti sono illegali e chi li fa in una qualche maniera senza chiedere il permesso a nessuno, neanche alla cittadinanza, si appropria di uno spazio, ma è anche un gesto che sicuramente rimanda anche al mondo della pubblicità, al fatto per esempio di come si appropria del tuo spazio visivo, del tuo spazio immaginifico, senza chiederti il permesso.
«Stessa cosa vale, secondo me, in maniera forse più velata l’atto di dipingere una fabbrica dismessa, di recuperare uno spazio che spesso è abbandonato ed è stato riconquistato dalla natura, spazio che spesso non è valorizzato dal Comune di appartenenza, bisogna anche considerare che ovviamente un artista come me, che nasce a livello artistico all’interno dello spazio urbano, lavorerà su tematiche sicuramente legate al contesto urbano.
«La caratterizzazione di un artista come me è molto forte, segnata dal rapporto con la città e quindi anche le tematiche ecologiste vanno in quella direzione.»

Video del ciclo Nomadic Experiment, intitolato: «On the brink of disaster».
A cosa sta lavorando?
«Sto lavorando su me stesso, sono rimasto in Perù più del previsto perché a causa dell’emergenza Coronavirus non si poteva rientrare. Poi, sono rientrato in Italia nel pieno della quarantena, tutti i progetti avviati sono in stand by sfortunatamente, fra i quali una realizzazione a Detroit, nel Michigan, un grosso lavoro a Oakland, in California, e altre che sono saltate.
«In questo momento sto portando avanti un progetto di Land-art, sarei dovuto andare come ho detto a Detroit e a Oakland, avevo già fissato delle date in cui avrei dovuto presentarlo, però al momento è tutto fermo.»
Nello specifico di che progetto si tratta?
«Il progetto Paesaggi animati è un lavoro performativo di geometrie effimere dipinte nel paesaggio. Questa idea parte dalla mia pratica: immortalare un lasso temporale ben preciso, la materializzazione pittorica del tempo impiegato per creare l’opera stessa. Una ricerca che valorizza l’aspetto progressivo, l’esperienza della pittura nel suo divenire in relazione allo spazio fisico che la ospita.
«Un numero imprecisato di azioni viene prodotto a seguito dell’esplorazione del paesaggio e delle architetture che circondano le città, accumulando materiali attorno ai quali si costruisce esteticamente l'idea di una mostra che nasca di riflesso ad azioni performative sul territorio.
«I territori, scelti di volta in volta per specifiche caratteristiche ambientali e antropologiche, vengono indagati e raccontati attraverso la creazione di tratti, forme e composizioni geometriche eseguite con materiali legati al territorio e filmate in zenitale da un drone.
«È land-art viva, che diventa pretesto per attivare interazioni sociali, mostrare uno spaccato dell’urbanizzazione moderna e il suo dialogo con le aree non costruite; non soltanto una riflessione sul contenuto estetico dell’opera ma un radicale spostamento di attenzione dal prodotto finale all’atto creativo.»
Daniela Larentis – [email protected]