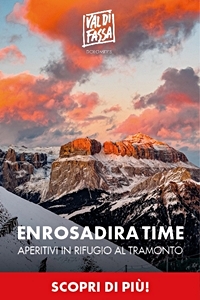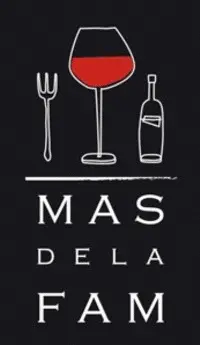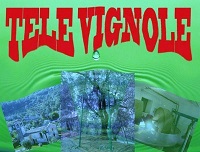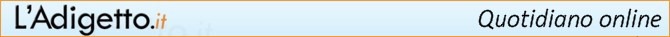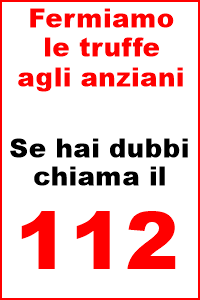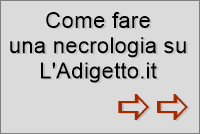Un bilancio sindacale dell’esperienza degli operai Malgara
Una vicenda che sta arrivando alla sua definitiva conclusione con il licenziamento di tutti i lavoratori dello stabilimento di Borghetto d’Avio
Quanto segue è'l'amara nota inviata dai sindacati alle redazioni sulla vicenda Malgara
La vicenda Malgara sta arrivando alla sua definitiva conclusione con il licenziamento (messa in mobilità) di tutti i lavoratori dello stabilimento di Borghetto d’Avio (l’altro stabilimento, quello di Parma della Pandea, è stato ceduto tramite vendita pochi giorni fa dalla stessa Malgara).
È importante tentare un bilancio e trarre i necessari insegnamenti. Necessari in primo luogo per i lavoratori, non solo ovviamente per quelli della Malgara, ma soprattutto per quelli che oggi si trovano di fronte a problemi simili a quelli con cui, nel corso di svariati anni, si sono dovuti confrontare gli operai della Malgara senza, per vari motivi, poterne venire a capo.
Iniziamo dalla situazione attuale che si è conclusa come in media si chiudono da qualche decennio a questa parte vicende analoghe.
Le imprese ingrassano con lo sfruttamento degli operai e con i contributi pubblici (pagati in generale dai lavoratori e dagli strati popolari) e non investono più nell’azienda e nell’attività industriale.
Lentamente, ma inesorabilmente, le aziende deperiscono, diventano obsolete, perdono colpi, quote di mercato, ordinativi, mentre salgono i debiti e mentre, anche per questi motivi, gli operai vengono spremuti, precarizzati, ricattati ed oppressi sempre più.
A fronte di tutto questo, i profitti accumulati spariscono inghiottiti dagli, attualmente più redditizi, investimenti speculativi di carattere finanziario.
Di questi investimenti e dei relativi affari non rimane, sul piano pubblico, praticamente traccia, anche perché nessuno -stato, governi locali, partiti, sindacati, ecc.- ovviamente intende approfondire la questione vista la profonda comunità di interessi che lega questi «soggetti» con i poteri e gli interessi finanziari ed industriali.
Alla fine dunque le aziende chiudono, gli operai vengono licenziati e si apre per loro una nuova ed ultima fase, quella dell’aria fritta rappresentata dalle nuove promesse di lavoro e quella dei diritti e delle spettanze (es. gli stipendi arretrati, il TFR ecc.) sanciti dalla legge che vengono invece «corrisposti» e «anticipati» come fossero esito di concessioni, aiuti, supporti, beneficenze, oppure presunte conquiste dell’iniziativa dei sindacati confederali.
Lo scopo ancora una volta è quello di smussare le contraddizioni, dividere i lavoratori licenziati, addormentare la situazione sino a quando ogni lavoratore, o per lo meno la maggior parte, non cercherà esausto una via d’uscita individuale (un altro lavoro ? un lavoro in proprio ? i servizi sociali ?). Diciamo che alla Malgara forse peggio di così, per gli operai, non poteva andare. Non è certo una consolazione pensare che sono anni che la stessa situazione con gli stessi esiti si ripete in centinaia di fabbriche e aziende italiane.
Perché si è arrivati a questa situazione ? C’era la possibilità di una diversa prospettiva e via d’uscita?
Pensiamo che se anche non si fosse riusciti a vincere la partita, sicuramente si sarebbe potuto, almeno, non perderla in questo modo disastroso.
Questa via d’uscita c’era ed è anche stata tentata in una certa fase dallo slai cobas in condizioni peraltro già estremamente difficili.
Si sarebbe dovuto nell’ordine :
1) formare un cobas di lavoratori attivi, coscienti, determinati ad essere protagonisti nella lotta alla Malgara (cosa che non si è potuto fare),
2) questo cobas avrebbe dovuto lavorare seriamente e sistematicamente per convincere i lavoratori;
3) i lavoratori avrebbero dovuto riunirsi autonomamente in modo periodico e sistematico, discutere e prendere iniziative adeguate nella fabbrica e via via anche fuori (anche questo quindi non è stato fatto);
4) questi lavoratori avrebbero dovuto, palmo a palmo, lavorare per conquistare la maggioranza nella Malgara tramite la distruzione dell’egemonia, dell’influenza, del consenso, dei sindacati confederali;
5) il passaggio successivo che sarebbe dovuto avvenire era quello della lotta, partendo da forme semplici e limitate sino, in modo eventualmente graduale, arrivare alle forme storiche della lotta di classe (gli scioperi con corteo, l’occupazione della fabbrica, i blocchi stradali ecc.);
6) si sarebbe dovuto anche portare la lotta sul territorio ossia fuori dallo stabilimento nei paesi (Ala, Avio) e nelle città (Rovereto, Trento) costruendo alleanze con altri lavoratori, disoccupati, precari, studenti;
7) solo sulla base della lotta e della conseguente costruzione di reali ed effettivi rapporti di forza si sarebbe dovuti andare alla contrattazione con le istituzioni, mettendole di fronte alla concreta possibilità di rendere la questione Mlalgara oltre che una questione di rilevanza civile, politica e sociale anche un problema di «ordine pubblico».
Diciamo che lo Slai Cobas, in particolare nella fase immediatamente successiva a quella dell’«RSU Slai Cobas Malgara» gestita dal rappresentante interno Massimo Barletta, ha cercato con l’intervento diretto del suo coordinatore provinciale Sebastiano Pira, di aprire questo percorso.
A quel punto però la situazione era molto difficile e seriamente compromessa, infatti l’azienda riusciva facilmente, grazie anche al pieno supporto di sindacati confederali e provincia, a continuare l’operazione strategica volta ad:
1) accumulare capitali da investire altrove; a disinvestire nello stabilimento lasciando deperire (senza innovazioni, campagne pubblicitarie, ricostruzione di un sistema di alleanze tra imprese, concentrazione di imprese ecc.) l’azienda e rendendola ovviamente sempre meno interessante per altri eventuali soci apportatori di capitale);
2) illudere, passivizzare e dividere i lavoratori prospettando, sempre con l’appoggio ed il consenso di sindacati confederali ed istituzioni, nuovi investimenti dovuti all’intervento di un fantomatico capitale straniero;
3) continuare quindi il proprio gioco speculativo sino alla fine portando di fatto a conclusione quello iniziato decenni prima con lo smembramento ed inghiottimento finanziario (e politico) dell’impero rappresentato dall’allora Gruppo Malgara.
Sul versante opposto, quello rappresentato dai lavoratori Malgara, bisogna dire che non esisteva un’esperienza classista all’interno della Malgara, non c’era, all’interno dell’azienda, una vera organizzazione sindacale di classe ed un’effettiva coscienza di classe nemmeno tra una minoranza di lavoratori, tutto era praticamente da costruire.
Dopo la gestione Barletta dell’«RSU Slai Cobas Malgara», è stato quindi il coordinatore provinciale Pira Sebastiano ad affrontare direttamente la difficilissima situazione.
Al dimissionario Barletta si era sostituito un nuovo rappresentante dell’«RSU Slai Cobas Malgara», un’operaia, la Signora Piera Coatti, ed è anche con questa nuova rappresentante che si è tentato di fare qualche passo in avanti per iniziare la costruzione del sindacato di classe all’interno dell’azienda.
Insieme a tutto questo si è cercato di costruire un sistema di alleanze tra lo Slai Cobas e settori del Sindacalismo di Base, l’SBM di Flammini Fulvio e l’allora appena costituita USB di Ezio Casagrande (ex-funzionario CGIL).
Gli operai Malgara hanno però preferito continuare lo stato di dipendenza dai sindacati confederali oppure, in minima parte, supportare chi prometteva (USB) loro una facile soluzione dei loro propri problemi personali. Non solo ancora una volta non si è costruito nessuna organizzazione sindacale di classe tra gli operai Malgara, ma ancora una volta si sono cercate delle scorciatoie.
Questa volta la maggioranza del piccolo gruppo di operai più volenterosi di affrontare il problema Malgara, insieme alla stessa rappresentante dell’RSU, la Signora Piera Coatti, si è messa nelle mani di Ezio Casagranda (USB, Unione Sindacale di Base).
Decisivo è stato l’appoggio dato al Casagranda (USB), da una parte dell’ex-direttivo provinciale dello Slai Cobas rappresentata in primo luogo da Federico Menegazzi e Sergio Mattioli (del Partito Comunista dei Lavoratori di tendenza trotskijsta) che hanno deciso di rompere con l’impostazione classista dello Slai Cobas per aderire a quella dell’USB.
A danno degli operai si è così arricchito il teatrino di Malgara, PAT e CGIl-CISL e UIL, con l’aggiunta questa volta dell’USB di Ezio Casagranda.
Da allora ad oggi sono passati quasi due anni, un tempo più che sufficiente per fare un bilancio anche del ruolo svolto da Ezio Casagranda nella vicenda Malgara.
Si tratta di un ruolo chiave perché da una corretta impostazione della questione sindacale, anche solo da parte di un gruppo relativamente piccolo di operai, in una situazione critica come quella della Malgara, sarebbero potuti derivare risultati assai differenti per i lavoratori della stessa Malgara ed una ben differente sedimentazione di coscienza ed esperienza di lotta per i lavoratori di varie altre imprese ed aziende a livello provinciale.
Così non è avvenuto. Casagranda ha impostato male la questione sindacale e questo ha avuto rilevanti conseguenze negative.
In sostanza il bilancio attiene non ad un giudizio morale o individuale sul Signor Casagranda, ma alla valutazione critica di quello che è andata configurandosi come l’impostazione USB della questione e dell’sindacale.
L’impostazione USB è quella di costruire un «quarto sindacato», non un sindacato strutturalmente e culturalmente diverso da CGIL-CISL-UIL, non un sindacato di classe fondato appunto sulla lotta di classe (cioè sulla lotta degli operai per resistere ai padroni e per vincere sui padroni), ma appunto un sindacato corporativo e conciliatorio (come lo sono CGIL-CISL-UIL) capace di affiancarsi, pur in modo concorrenziale, a CGIL-CISL-UIL.
L’impostazione USB, impersonificata dunque a livello locale da Ezio Casagranda -sino a pochi anni fa funzionario di spicco CGIL ed ex-FIOM- è quella dell’«opportunismo».
Bisogna capire bene il concetto di opportunismo, che indica una linea ed una categoria politica e sindacale che, di per sé, non ha niente a che vedere con gli insulti o le critiche personali.
L’opportunismo USB significa essenzialmente:
1) ottenere a tutti i costi il consenso, l’appoggio e la delega dei lavoratori all’USB, prospettando ai lavoratori piccoli risultati immediati cosiddetti «credibili», conquistabili principalmente con la «contrattazione» con le istituzioni locali e «soggetti terzi» (es. Banche) o con la contrattazione sindacale interna all’azienda incentrata sul ruolo (oggi praticamente nullo) delle RSU;
2) dimostrare quindi ai lavoratori che si può ottenere comunque qualcosa.
I due anni di esperienza di questo opportunismo alla Malgara ne svela pienamente le conseguenze :
1) Gli operai non vengono affatto stimolati e formati per diventare militanti e quadri sindacali protagonisti dell’organizzazione operaia e della lotta;
2) non viene quindi costruita alcuna organizzazione sindacale classista (cobas) all’interno della fabbrica;
3) gli operai vengono anzi diseducati e spinti a delegare problemi, ragionamenti, responsabilità e decisioni al funzionario di turno (nel nostro caso il Casagranda) ed alla sua capacità (vera o presunta) di gestire i rapporti con le istituzioni;
4) agli operai si prospettano piccoli vantaggi che però portano a distoglierli dal problema generale e dalle questioni di fondo e questi piccoli vantaggi a volte sono anche dei piccoli imbrogli (es. la proposta della cessione di credito per il recupero degli stipendi arretrati fatta a partire da un anno e mezzo a questa parte agli operai Malgara da USB);
5) ci si dà un gran daffare per portare gli operai alla corte delle istituzioni per dimostrare di avere un potere di contrattazione che non si ha affatto, e che comunque attiene sempre alle briciole;
6) in questo modo si indicono anche scioperi ed iniziative, ma con scarsa preparazione e significato, sul modello quindi delle iniziative di facciata di CGIL-CISL e UIL.
Esaurendo lentamente, invece di accumulare, le già poche energie degli operai in iniziative inutili ed illudendo gli stessi operai che le istituzioni (che sono sempre collegate ai padroni, alle banche ed ai politici corrotti) abbiano un qualche interesse ad andare loro incontro senza essere costrette a fare questo dalla lotta operaia e dalla costruzione di adeguati rapporti di forza.
In sintesi si può dire che il bilancio dell’iniziativa USB alla Malgara è che USB ha scelto una linea fondamentalmente simile, anche se formalmente più chiassosa e roboante, di CGIL, CISL, UIL, con esiti non molto diversi da quelli dell’iniziativa degli stessi sindacati confederali.
Ossia, in ogni caso, con il sicuro esito di fondo di lavorare per impedire, in un modo o nell’altro, che dalla cosiddetta crisi Malgara emergesse un’esperienza di lotta operaia capace di crescere, resistere e di avanzare e quindi di intimidire in generale, oltre che il padron Malgara anche aziende, banche e governi locali (PAT) dando l’esempio, e chiamando così a raccolta ed alla lotta, centinaia e centinaia di operai, disoccupati, precari e studenti dell’intera provincia che vivono e subiscono problemi (in atto o in prospettiva) di sfruttamento selvaggio, taglio del salario, precarizzazione, perdita del posto di lavoro.