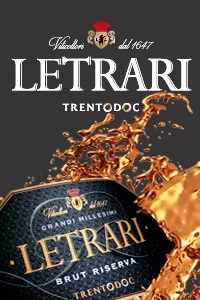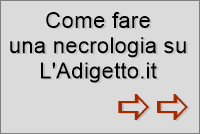Storie di donne, letteratura di genere/ 244 – Di Luciana Grillo
Jacqueline Woodson: «Autobiografia di una foto di famiglia» – Questa «autobiografia» lascia sotto traccia a chi la legge un senso di impotenza

Titolo: Autobiografia di una foto di famiglia
Autrice: Jacqueline Woodson
Traduttrice: Chiara Baffa
Editore: Edizioni Clichy 2018
Pagine: 185, Brossura
Prezzo di copertina: € 15
Dopo aver letto e recensito in questa rubrica il precedente romanzo della Woodson,«Figlie di Brooklyn», leggere l’«Autobiografia di una foto di famiglia» è stato semplicemente riannodare un filo e ritrovare l’ambiente, i personaggi, le tante sofferenze e i pochi sorrisi degli afroamericani che vivono a New York.
Anche in questo romanzo, ambientato fra gli anni 60 e 70 del secolo scorso, Woodson sottolinea il disagio dell’essere afroamericano, «Se sei bianco… puoi diventare presidente. Questa è l’unica differenza», dell’abitare «in un palazzo che odora di vomito. Una porta annidata nell’angolino di un quartiere nato come ghetto, assaltato dalla povertà e lasciato a marcire» dove «i vicini malconci spiano dalle finestre sgangherate, zitti come la morte».
La famiglia della foto è numerosa, c’è la madre che «quando non trova il foulard, si mette un paio di mutandine in testa e preghiamo tutti in silenzio che non si sbagli e non esca senza toglierle», che ha nostalgia delle «dolci querce verdi che crescevano giù al Sud, nel giardino della nonna», che vorrebbe una casa «dove la notte non ci sono ratti che ballano tra un’asse del pavimento e l’altra», che regala ogni anno alla figlia una bambola («…si aggiungerà alla mia collezione di giocattoli inutili che prendono polvere sulla mensola sopra il letto»).
La figlia, in realtà, le bambole le smonta per rimontarle poi «in modo che quelle nere abbiano le braccia bianche, quelle bianche abbiano le gambe nere…»; la figlia descrive se stessa e le amiche senza indulgenza, senza tentativi di migliorare una condizione di disagio: «Siamo bambine, piccole bimbe cattive… che non alzano gli occhi verso quelle facce che ci guardano sorridendo, che ingoiano, diventano vuote come il cielo, non gridano, ma aspettano aspettano aspettano e presto sarà tutto finito».
Violenza familiare e violenza extrafamiliare, sempre violenza, subita con un fatalismo incredibile e drammatico.
Sanno diventare cattive davvero, queste povere bambine cresciute troppo in fretta, quando trovano un bambino bianco da spaventare, o da picchiare, quando progettano un’azione da bulle di periferia: «…sarò io a picchiarla, a farle saltare un dente dall’angolo della bocca, e a spedirla a casa in lacrime, sanguinante».
La bimba – l’io narrante – che sta diventando una giovane donna, capisce che la loro è una vita difficile, perché nessuno «ammetterebbe ciò che succede in certe case mentre la madre è al lavoro per cercare di sfamare quattro bambini e i bambini crescono, crescono, prosciugandola con il loro crescere, imparando a odiarla mentre crescono e lei non sa dove ha sbagliato»; sa che lontano si combatte una guerra, sa di aver perduto un fratello che era andato a combattere, sa: «Cresco vuota, deviata, spaccata, mi sposto da un luogo all’altro, da un lavoro all’altro. L’inverno scorso sono tornata in macchina a Cape Cod, ho parcheggiato alla spiaggia e sono entrata in acqua con tutti i vestiti. Forse non mi sarei voluta fermare».
Poi, vedendo le sue amiche diventare mamme, nonostante tanti problemi, «anche io voglio un bambino ma so che non dovrei perché ho solo quindici anni. Ma lo voglio così tanto, qualcuno di piccolo da amare… voglio qualcuno di piccolo che sia mio, da portare via con me in un altro posto, molto lontano», in un posto dove finalmente sentirsi accettata, dove qualcuno forse non griderà «Ehi, questo non è posto per voi».
Questa «autobiografia» lascia tracce in chi legge, lascia un senso di impotenza e la voglia di accarezzare la testolina della quindicenne che ha raccolto i capelli in «un migliaio di minuscole trecce, le perline che mi sfiorano le spalle».
Luciana Grillo – [email protected]
(Recensioni precedenti)