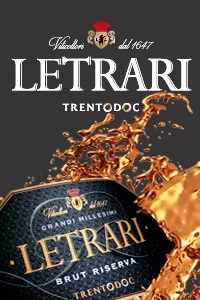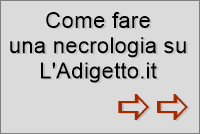Ricordati i Caduti nelle missioni internazionali per la pace
Ma sono ancora troppi quelli dimenticati dalla Storia, dal Paese e dalla Pietas latina

>
Il nostro giornale è sempre stato vicino a coloro che, militari o civili che fossero, sono caduti nel corso di una missione militare.
Questo non solo perché ci siamo trovati più volte a fianco dei nostri ragazzi e li abbiamo visti lavorare davvero per la pace a rischio della loro vita, ma soprattutto perché nessuno di quelli che abbiamo conosciuto voleva la guerra. Chi la decide, questa è la Democrazia, non è mai il soldato ma il Paese.
Il soldato deve solo obbedire e fare il lavoro cui è comandato, nel miglior modo possibile. Questo accade quasi sempre. Soprattutto da quando i militari sono volontari, le Forze armate sono diventate una delle strutture più affidabili del nostro Paese. Grazie a loro l’immagine che nutriamo all’estero con le divise è quella di un grande paese.
Lo stato, da parte sua, deve mettere i nostri ragazzi in condizioni di lavorare al meglio, di rischiare la vita il meno possibile, ma soprattutto deve far sentire il proprio sostegno, fisico e morale. Questo non è accaduto sempre e ogni volta che prendiamo atto che un parlamentare si comporta in modo irriverente nei confronti dei nostri caduti, ci sentiamo feriti anche noi. Un cittadino caduto per conto e in none del suo Paese merita il rispetto di tutti, anche di coloro che erano contrari all’operazione militare per cui è morto.
Oggi sono stati commemorati tutti i soldati caduti nel corso di missioni di pace.
Le manifestazioni hanno avuto inizio con la deposizione di una corona d’alloro alla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria da parte del Ministro della Difesa Roberta Pinotti.
Al termine della deposizione l’Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia, Mons. Santo Marcianò, ha celebrato la Santa Messa nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli presenti, tra gli alti, il Presidenti della Camera Laura Boldrini, ex Ministri della Difesa e i Vertici delle Forze armate.
Le celebrazioni sono poi proseguite al Belvedere Caffarelli in Campidoglio, dove il Ministro Pinotti ha deposto una corona di alloro alla Stele commemorativa dedicata ai Caduti.
Le manifestazioni sono state accolte anche polemicamente da parte di qualcuno che, a torto o a ragione, aveva qualcosa da dire alle Istituzioni. Non ne vogliamo parlare. Non nel giorno in cui dovremmo solo ricordarci di chi caduto al posto nostro.
Oggi vogliamo solo ricordare.

Chi scrive questo articolo era piccolo quando accadde il primo tragico massacro ai danni dei nostri militari a Kindu (foto qui sopra), che avvenne il 12 novembre 1961 nell'ex Congo belga, dove furono trucidati tredici aviatori italiani facenti parte del contingente dell'Operazione delle Nazioni Unite in Congo inviato a ristabilire l'ordine nel paese sconvolto dalla guerra civile.
I tredici militari italiani formavano gli equipaggi di due C-119, bimotori da trasporto della 46ª Aerobrigata di stanza a Pisa, il cui compito era quello di portare rifornimenti alla piccola guarnigione malese che controllava l’aeroporto ai margini della foresta equatoriale.
Gli aerei italiani si dovevano fermare a Kindu solo il tempo di scaricare e, per gli equipaggi, di mangiare qualcosa. I due C-119 comparirono nel cielo della cittadina poco dopo le 14 e, dopo aver fatto alcuni giri sopra l'abitato, atterrarono all'aeroporto controllato dai malesi.
La vista dei due aerei italiani, scambiati per velivoli katanghesi carichi di paracadutisti, scatenò la reazione incontrollata dei soldati di stanza a Kindu. Diverse centinaia di congolesi si recarono in camion all'aeroporto dove in quel momento i tredici uomini degli equipaggi italiani, comandati dal maggiore Parmeggiani, si trovavano alla mensa dell'ONU, una villetta distante un chilometro dalla pista, insieme a una decina di ufficiali del presidio malese.
Intorno alle 16.15 i congolesi fecero irruzione nell'edificio, dove italiani e malesi, quasi tutti disarmati, si erano barricati: circa 80 soldati congolesi sopraffecero rapidamente gli occupanti della palazzina e li malmenarono duramente, accanendosi in particolare contro gli italiani scambiati per mercenari belgi al soldo dei katanghesi. Il tenente medico Francesco Paolo Remotti tentò di fuggire lanciandosi da una finestra aperta, ma fu rapidamente raggiunto dai congolesi e subito ucciso.
Intorno alle 16.30 arrivarono altri 300 miliziani congolesi guidati dal comandante del presidio di Kindu. Il comandante malese, maggiore Maud, tentò inutilmente di convincerlo che gli aviatori erano italiani dell'ONU e alle 16.50 i dodici italiani furono caricati a forza sui camion e portati in città, per poi essere rinchiusi nella piccola prigione locale.
Quella notte, soldati congolesi fecero irruzione nella cella dove erano detenuti i dodici aviatori italiani e li uccisero tutti a colpi di mitra.
Abbandonati i corpi sul posto, questi furono spostati poche ore dopo dal custode del carcere che, temendone lo scempio, li trasportò con un camion nella foresta fuori città e li seppellì in una fossa comune.
Per giorni non si seppe nulla della sorte degli aviatori, e lo stesso comando delle truppe ONU temporeggiò per evitare di scatenare una rappresaglia contro gli italiani senza sapere che questi erano già stati uccisi. Solo alcune settimane dopo l'eccidio il custode del carcere si mise in contatto con i fratelli Arcidiacono, due italiani residenti da tempo a Kindu: questi riuscirono a ricostruire le circostanze dell'eccidio e a contattare le autorità ONU per predisporre il recupero delle salme.
Nel febbraio del 1962 un convoglio della Croce Rossa austriaca, scortato da un contingente di caschi blu etiopi e accompagnato da due ufficiali della 46ª Aerobrigata, rinvenne la fossa comune dove erano stati seppelliti gli italiani nel cimitero di Tokolote, un piccolo villaggio sulle rive del Lualaba ai margini della foresta.
I corpi, protetti da una grossa crosta di argilla, erano ancora in buono stato di conservazione e furono facilmente identificati. Trasportati all'aeroporto di Kindu, furono imbarcati su un C-119 italiano e inviati a Leopoldville, da dove rientrarono in Italia a bordo di un C-130 statunitense.
Oggi un grande monumento eretto all’aeroporto di Fiumicino ricorda quei ragazzi che sono morti praticamente senza aver neppure avuto l’opportunità di difendersi perché stavano compiendo un’operazione non strrettamente militare.
Chi scrive non era più un ragazzino invece quando era scoppiata la guerra del Vientam. Anzi, aveva l’età dei ragazzi americani che partivano per il Golfo del Tonchino.
Il ricordo pesante che porto con me di quella guerra assurda è stata l’accoglienza che i caduti, i feriti e i reduci hanno avuto dal proprio Paese una volta tornati a casa. Uccisi sul campo o al ritorno a casa.
Il paese li aveva voluti dimenticare e solo un muro a ricordo dei 58.000 morti è stato eretto nel Cimitero militare di Arlington a Washington. La pietas latina vive solo nelle vie riservate e incancellabili del ricordo.
Questo lo abbiamo scritto perché è un po’ quello che accadde ai soldati trentini che 100 anni fa erano partiti per la Galizia e altri fronti dell’Impero Austro Ungarico. Ne furono arruolati 60.000, ne morirono 11.400.
A guerra finita, i reduci dovettero fingere di non essere stati in guerra perché avevano «virtualmente» combattuto anche contro l’Italia, alleata dei russi. Perfino i cimiteri dovettero far finta di non essere stati l’ultima dimora di militari caduti per la Monarchia Danubiana.
Ci vollero quasi 100 anni perché la Provincia autonoma di Trento rendesse loro gli onori del ricordo.
L’allora assessore alla Cultura Franco Panizza aveva recuperato tutti i nomi di quegli 11.400 caduti e ne aveva fatto un piccolo monumento mobile esposto nella sala di rappresentanza della Regione (foto).
Ma quel monumento non è stato «a imperituro ricordo», come si dice in questi casi. Quel monumento ai caduti è scomparso. Giace in qualche magazzino della Provincia.
Il nostro desiderio sarebbe quello di poterli ricordare così come seppero fare gli USA con il muro del Vietnam.
Ma sembra che neanche la pietas latina possa mai dar pace ai nostri ragazzi che un secolo fa partirono per una guerra che non avevano voluto, che non avevano capito, che avevano perso anche se il loro paese finale, l’Italia, l’aveva vinta.
G. de Mozzi