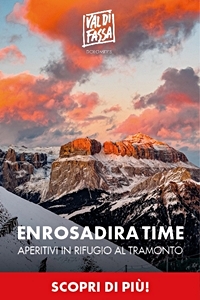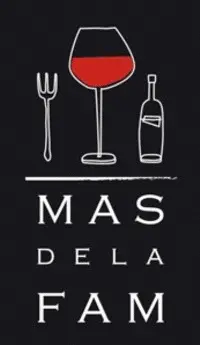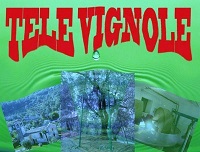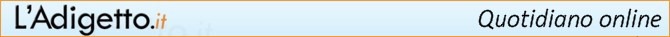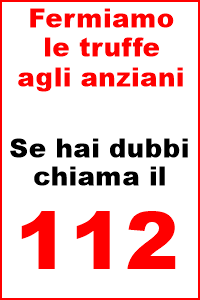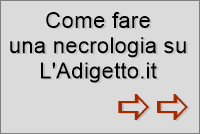Presentato a Palazzo Trentini il libro «E lo chiamano lavoro»
Dorigatti: «Una riforma che riduce i diritti dei lavoratori non genera sviluppo economico»

>
«La flessibilità introdotta negli ultimi anni con la riforma del mercato del lavoro ha generato più precarietà e un preoccupante arretramento rispetto ai diritti fondamentali conquistati negli anni 70 con lo Statuto dei lavoratori.»
A sottolineare con forza il concetto è stato il presidente del Consiglio provinciale Bruno Dorigatti introducendo stasera un dibattito ospitato in una Sala Aurora di palazzo Trentini molto gremita, che ha avuto per protagoniste Carla Ponterio e Rita Sanlorenzo, giudici del lavoro invitate dall’Associazione magistrati a presentare il volumetto «E lo chiamano lavoro» (edizioni GruppoAbele), fresco di stampa e di cui sono autrici.
Dopo il saluto del presidente della sezione locale dell’Associazione magistrati Pasquale Profiti (ad organizzare l’incontro intitolato «Dalla Costituzione al Jobs Act: dal diritto del lavoro al diritto dei lavoratori?», sono stati anche Anpi, Libera e Cgil), Dorigatti ha lamentato che la questione del lavoro meriterebbe di essere oggi al centro del dibattito politico attuale dove invece «rimane ancora troppo sullo sfondo».
Dorigatti: queste riforme creano precarietà
Questo libro, ha proseguito il presidente, tratta di diritto del lavoro ma affronta soprattutto il tema dal punto di vista sociale ed economico.
Il lavoro, ha ricordato Dorigatti, ha un ancoraggio costituzionale negli articoli 2 e 3 eppure, di fatto, oggi nel nostro Paese manca, perché il tasso di disoccupazione è alto e ne soffre l’esigenza di dignità delle persone.
«Il lavoro, ha aggiunto il presidente, manca oggi soprattutto ai giovani e questo è un problema grave in termini di sviluppo.»
Il problema per Dorigatti è che «anziché affrontare la questione della disoccupazione si è molto parlato di riforma del mercato del lavoro pensando di produrre lavoro, ma non è stato affatto così.»
Perché per creare lavoro, ha proseguito il presidente, occorre mettere in moto le leve della crescita economica.
«Le ultime riforme del mercato del lavoro – ha denunciato il presidente – non vanno nella direzione dell'occupazione ma dell'impresa, chiedendo più flessibilità. Flessibilità che ha determinato una crescita molto alta della precarietà.»
Se si tolgono i diritti l’economia cresce meno
Che fare allora? Per Dorigatti «serve quindi un cambio di prospettiva che consideri lavoratrici e lavoratori un fattore fondamentale dello sviluppo», perché «permettere i licenziamenti non è certo un elemento di crescita».
Secondo il presidente non è cancellando i diritti visti come lacci e lacciuoli che si favorirà lo sviluppo.
«E infatti – ha ricordato Dorigatti – la riforma dell'articolo 18 non ha favorito la nascita di alcuna nuova impresa. Anzi, abbiamo assistito ad un arretramento rispetto alla legge 300 del 1970, quando il verificarsi di una grande unità sindacale ha coinciso con una fase di crescita.»
Il punto per il presidente è che «quando si tolgono diritti l'economia cresce meno».
Dorigatti ha rammentato anche che «prima del 1970 i diritti sindacali non c'erano, i licenziamenti erano consentiti per legge e le assemblee sindacali si facevano nelle cantine».
Il presidente ha ricostruito poi le fasi che dagli anni 90 alla crisi attuale hanno visto cambiare il mercato del lavoro e portato ad una sua scomposizione con la nascita di nuove figure come le partite Iva.
Alla scomposizione del mercato del lavoro, ha proseguito Dorigatti, si è accompagnata una forte riduzione dei diritti, l’esplosione della precarietà e l’affacciarsi sulla scena dell’ipotesi di un rapporto di lavoro individuale.
«E – ha aggiunto – con un rapporto dio lavoro così tra lavoratori e impresa non si tratta.»

La crisi di rappresentanza dei sindacati e la mancanza di unità
«Dentro questo processo di scomposizione, ha detto il presidente – le forze di sinistra e sindacali non hanno più saputo ritrovare l'unità degli anni 70 e da questo è scaturita una crisi di rappresentanza che tocca anche i sindacati e di cui le imprese approfittano per ridurre, appunto, i diritti acquisiti come avviene con la vicenda della Fiat.»
Arrivando con questa breve ricostruzione storica «ai giorni nostri – ha concluso Dorigatti – il Job Acts mostra un governo di sinistra che riduce i diritti dei lavoratori, perché nessun governo come questo era riuscito a cancellare con l'articolo 18 un diritto fondamentale dei lavoratori che ancora esiste invece in tutta Europa.»
Un esempio citato in tal senso dal presidente è stato quello dei lavoratori del Colosseo, della cui assemblea il governo ha approfittato per ridurre il giorno dopo il diritto di sciopero.
Dalla cancellazione dell’articolo 18 al Jobs Act
Rispondendo alla prima domanda del giornalista Alberto Faustini, che ha moderato il dibattito, Rita Sanlorenzo ha messo il luce il passaggio da un concetto di diritto del lavoro inteso come diritto dei lavoratori che negli anni 70 il legislatore aveva introdotto anche istituendo la figura del giudice del lavoro a tutela dei lavoratori considerati soggetti deboli, al Jobs Act che rendendo il lavoro più flessibile e modulabile ha risposto soprattutto ad un bisogno dell’imprenditore.
«Si creano così lavori che non danno al lavoratore stabilità nell’azienda e al suo posto di lavoro togliendoli tutte le armi con cui far valere i diritti a ciò connessi.
«L'articolo 18 aveva una valenza protettiva perché dissuadeva da manifestazioni di forza da parte di chi ha più potere nei confronti della parte più debole.
«Finché il lavoratore era coperto da questo ombrello e da questa garanzia universalistica dell'articolo 18 sorgevano conflitti che spingevano in avanti il fronte delle rivendicazioni e consentiva un ampliamento dei diritti, mentre ora tutto questo non c’è più.
«Con il Jobs act nulla è più lavoro stabile e si torna a un'uniformità di rapporti di lavoro che non danno né garanzia di stabilità né tutele. Restano le ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento, ma con le nuove norme il giudice del lavoro può essere facilmente baipassato.
«A questo si deve aggiungere il destino della contrattazione collettiva sostituita dalla contrattazione di prossimità che può peggiorare le condizioni dei lavoratori.»
I magistrati pretori d’assalto perché custodi della Costituzione
Incalzata dalle domande di Faustini, Carla Ponterio, altra autrice e giudice del lavoro, ha ricordato come la Fiat sia stata più volte condannata in cause di lavoro per l’illegittimità dei licenziamenti e per condotta discriminatoria. Per Ponterio un magistrato ha il compito e il dovere di far rispettare i diritti del lavoro previsti dalla Costituzione.
Per questo alcuni magistrati sono stati chiamati «pretori d'assalto», ma se ci si trova di fronte a comportamenti che contrastano con i diritti previsti dalla carta costituzionale, un giudice del lavoro deve preoccuparsi della loro attuazione e non dell'economia.
Il diritto del lavoro oggi è inteso come la difesa di un privilegio
Rita Sanlorenzo ha aggiunto che «quello che in questo libro noi consideriamo diritto del lavoro e dei lavoratori oggi viene dipinto da un certo mainstream come difesa di un privilegio».
A questo pensiero dominante poco è stato opposto è si è fatta passare per democratica questa operazione di riduzione dei diritti dei lavoratori.
Si sono tolti diritti a chi li aveva invece di darne di più a chi non li aveva.
Quanto ai lavoratori del Colosseo, Sanlorenzo ha precisato che il decreto assunto per necessità ed urgenza dal governo ha modificato la legge sugli scioperi mentre in questo caso si era svolta un'assemblea dei lavoratori.
I sindacati non hanno raccolto la sfida del cambiamento
Sul ruolo dei sindacati Carla Ponterio ha osservato che di fronte al cambiamento del mercato del lavoro diventato atipico, precario e poco tutelato, le organizzazioni dei lavoratori non hanno avuto la prontezza e la capacità di raccogliere queste nuove esigenze.
«E la crisi del sindacato si accompagna a una grossa crisi dei partiti di sinistra incapaci di esprimere una politica di tutela dei diritti dei lavoratori.
«E lo spostamento della contrattazione verso il livello aziendale acuisce il problema, perché il sindacato in periferia è una forza minore.»

Perché Biagi e D’Antona sono stati uccisi
Su Biagi e D’Antona, i due docenti di diritto del lavoro assassinati per le loro idee dai terroristi e diventati popolari solo dopo la loro morte, per Sanlorenzo questi ha detto che questi studiosi avevano «capacità di visione» e di dare un futuro al diritto del lavoro.
Loro sostenevano che decidere che il futuro è nell'impresa e che da lì si può e si deve ripartire, non significa affatto sbilanciare tutto a favore dell'imprenditore rendendolo dominus e padrone di un futuro che invece riguarda tutti.
Questa è una soluzione che pecca di semplicismo, per cui se anche a causa del fenomeno migratorio occorre pensare per il futuro ad un mercato del lavoro sempre più mobile, è anche necessario allora immaginare un sistema che tuteli i lavoratori più deboli senza lasciarli in balia dell'imprenditore la cui legge è ovviamente quella della convenienza.
Secondo Sanlorenzo, Biagi e D'Antona sono morti anche perché non difesi da chi avrebbe dovuto difenderli, come dimostra il fatto che a Biagi era stata tolta la scorta «e questo indica una precisa responsabilità della politica».
Il soggetto debole non è più il lavoratore ma l’imprenditore
Per Ponterio le leggi sul mercato del lavoro «hanno capovolto l'individuazione del soggetto debole. In passato il soggetto da tutelare era il lavoratore attraverso diritti non derogabili come il contratto.
«Oggi questo sistema è ribaltato e le nuove norme identificano in modo sempre più accentuato il soggetto debole con l'imprenditore.
«L’imprenditore è diventato il soggetto che le leggi vogliono proteggere e a cui si rivolgono, e per questo occorre creare uno spazio in cui l'imprenditore si possa muovere liberamente per cui tutto ciò che gli è d'intralcio, come i diritti dei lavoratori, dev'essere messo da parte. “
«Si tratta allora – secondo Ponterio – di verificare se questo è compatibile con la nostra Costituzione, che se da un lato tutela le imprese, dall’altro attribuisce lo stesso valore anche ai diritti e alla sicurezza dei lavoratori. Invece la legislazione oggi ha è creato attorno all'imprenditore un grande spazio sacrificando gli altri soggetti.»
Questa manovra per il lavoro “flessibile” non ha previsto la creazione di un paracadute sociale.
«Giusto rendere l’impresa libera ma altrettanto irrinunciabile è tutelare i lavoratori nel mercato, perché anche nel caso in cui perdano il lavoro vi sia una rete che li aiuta a trovarne un altro.
«Invece oggi la riforma del mercato del lavoro non ha alle spalle un'idea di sistema sociale diverso.
«Nel Jobs act non si è neppure citato l'articolo 18. Si è nascosto che l'obiettivo principale era di lasciar morire l'articolo 18 senza dichiararlo.
«E questo è un problema di politica del lavoro.»
Senza lacci e lacciuoli, per l'attuale capo del governo si sistema tutto?
Per Sanlorenzo in un paese in cui si dovrebbe garantire la legalità, ossia il rispetto delle regole, la legalità viene invece dipinta oggi come un ostacolo, Il problema è che l’Italia è un paese ad alta insofferenza per le regole e quindi occorre chiedersi se è giusto che la legalità sia considerata un peso, un fardello e un ostacolo allo sviluppo oppure un valore prioritario per garantire una convivenza civile.
A partire dall'approvazione dello statuto dei lavoratori in poi si è affermata la tendenza a ritornare indietro ritenendo che le regole fossero lacci e lacciuoli.
Al punto che tutti si sono convinti che nel lavoro nero stia una grande parte della ricchezza del Paese.
Legame sociale e principio di cooperazione
Ponterio ha evidenziato come il libro suo e di Sanlorenzo cerchi alla fine una strada per tornare a parlare di diritti dei lavoratori e di giustizia sul lavoro (anche «perché il problema del lavoro nero è che non arriva mai nelle aule dei tribunali perché le vittime non hanno i mezzi per potersi tutelare e le nuove norme hanno aumentato i costi del processo»).
E questa strada consiste nella ricostituzione dei rapporti sociali e nella creazione di legami tra le persone, perché solo così si può ricominciare a parlare di esigenze di tutela e di conseguente di rivendicazione di diritti del lavoro e dei lavoratori.
«Oggi siamo tutti singoli individui e i lavoratori si sentono soli perché ciascuno ha un suo contratto. In questa condizione in cui vi è ben poco che unisce è difficile costruire qualcosa, per cui il passo primario da compiere è quello di riallacciare i legami sociali. E le cooperative possono offrire una luce in fondo al tunnel.»
«Questo libro – ha commentato Faustini – fa capire come è nato e dove sta andando il diritto del lavoro nel nostro Paese.»