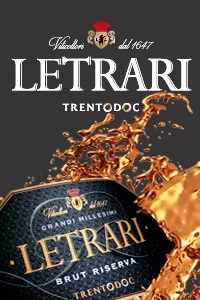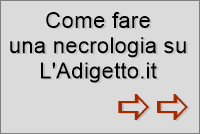Le parole dell’odio – Di Giuseppe Maiolo, psicoanalista
Colpiscono a morte perché narrano un non-sentire e un non-vedere in quanto chi le pronuncia è sintonizzato in modo eccessivo su se stesso

Le parole dell’odio circolano realmente attorno a noi, oggi più che mai in rete e, attraversano le relazioni, le contaminano e le feriscono.
A volte devastano i rapporti reali, altre volte uccidono fisicamente anche quando le parole dell’odio restano virtuali.
Perché le parole sanno essere proiettili, frecce avvelenate e mortifere.
In fondo tutte le parole non sono mai neutre e innocenti, hanno invece un corpo, un peso e una sostanza.
Sono appunto sostantivi, qualche volta anche aggettivi e verbi, ma più di tutto vocaboli che schiacciano come macigni quando veicolano pensieri ostili e emozioni incontrollate.
Diceva Tullio De Mauro che «L’odio non sa fare a meno delle parole».
Anzi, dovremmo dire noi che se ne serve copiosamente soprattutto in questo tempo di avanzata comunicazione digitale in cui è condivisa l’idea che si può dire tutto quello che si vuole ed esprimere liberamente qualsiasi cosa si si pensi o si provi.
Così l’odio online, chiamato ovunque «Hate speech», si moltiplica in maniera esponenziale, si diffonde e si alimenta di tutti quei sentimenti inconsapevoli che albergano dentro ciascuno di noi.
Cresce a dismisura tra gli adulti spesso esclusivamente autocentranti, ma ancor più si sviluppa tra i bambini e i giovani che, incapaci di governare ciò che vivono, trasformano il bullismo reale in cyber e mettono in circolo con leggerezza e divertimento, le tossine pericolose dell’intolleranza e del disprezzo, degli insulti e della svalutazione.
E poi in rete le parole diventano ancora più odiose e mortifere perché appaiono assolute e senza risposta, deturpano ogni immagine e deformano irrimediabilmente il reale, rendono negativo il diverso quando invece è solo differente o fuori dalla norma, cioè dal dato statistico.
Le parole dell’odio tolgono la dignità e aggrediscono con una misera originalità verbale perché in genere sono espressioni offensive sempre uguali a se stesse, schemi ricorrenti e impersonali che non nascono da un proprio sentire né dall’esperienza diretta.
Sono espressioni violente in sequenza, di solito frasi fatte che si basano su stereotipi e preconcetti, modi di pensare già pronti che non subiscono critica e confronto.
Idee non partecipate, ma imposte da chi sa più urlare che dialogare, imporre che condividere.
Colpiscono a morte perché narrano un non-sentire e un non-vedere in quanto chi le pronuncia è sintonizzato in modo eccessivo su se stesso, incapace di ascoltare l’altro e «mettersi nelle sue scarpe».
Giuseppe Maiolo
Psicologia delle età della vita
Università di Trento
www.officina-benessere.it