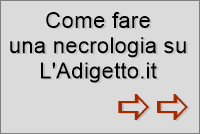Il tempo dell’attesa e del silenzio – Di G. Maiolo, psicoanalista
D’improvviso ci siamo accorti che ovunque è venuto a mancare il rumore

«Adda passà a ’nuttata» diceva Eduardo in Napoli milionaria.
Una frase memorabile come finale di una storia che ha dentro di sé il tempo duro della sofferenza e del vuoto, insieme al tempo lungo dell’attesa e del silenzio.
A rivederla oggi quella commedia, capisci che pure dentro l’angoscia più cupa ci può, anzi ci deve essere, una piccola speranza capace di farti attendere un giorno nuovo.
Trovi familiare quel dolore che adesso ti appare globale e per questo infinito e insopportabile.
Tutto, nella sofferenza è simile. Tutto tranne l’attesa e il silenzio.
Il saper attendere sembra una capacità quasi del tutto scomparsa nel tempo frenetico che viviamo e nella società impaziente che abbiamo costruito.
Quando manca questa risorsa, finisce per prevalere la metafora della lotta dichiarata e della guerra contro un nemico invisibile chiamato virus.
Ma è una risposta all’angoscia del contagio, al suo mortifero potenziale che vogliamo eliminare.
In realtà sappiamo bene e da tempo che la guerra tra l’uomo e i virus va avanti dalla notte dei tempi e che le epidemie non sono state mai sconfitte.
Il coronavirus non è tanto il nemico da eliminare, quanto piuttosto un microrganismo da conoscere e con cui trovare una forma di convivenza.
Soprattutto oggi che la scienza e la ricerca medica ci offrono strumenti preziosi per trovare equilibri sempre più adeguati alla nostra realtà complessa e all’interazione tra uomo e ambiente, ma soprattutto urgenti attenzioni da dare alla natura che ci ospita.
Naturalmente non c’è nulla di strano nel fatto che l’evidenza del contagio e la rapidità dell’epidemia, più che la paura alimentino l’angoscia.
Questa, come tante altre esperienze «perturbanti», nasce quando incontriamo un «male» sconosciuto che sta attraversando il territorio che consideriamo nostro.
Ci paralizza l’insieme degli elementi minacciosi che d’un colpo emergono dal sottosuolo della coscienza ma, come diceva Freud, che ci appartengono e ci sono familiari, anche se parti occultate e nascoste di noi. Rimosse.
È questa la ragione per cui il tempo dell’attesa ci appare infinito e insopportabile.
Azzera la fiducia e dà spazio alle nostre fantasie persecutorie facendo assumere al virus il volto del nemico su cui possiamo proiettare intenzioni malevoli, certamente giustificate dal potenziale distruttivo che stiamo vedendo ovunque.
Ma l’incapacità di reggere a questa minaccia, l’impazienza che viviamo, proviene dall’aver scoperto come un piccolissimo organismo sia in grado di metterci sotto scacco, capace di farci vivere a una vita mai pensata e forzarci ad un tempo di sospensione e di silenzio.
Il silenzio, per l’appunto. Quello che adesso attraversa le strade e le città.
Il silenzio spettrale e insopportabile che non è il vuoto delle metropoli d’estate quando tutti sono in vacanza, ma quello dato dalla distanza dei corpi e dall’impossibilità di narrare fisicamente all’altro ciò che stiamo vivendo.
Una narrazione però da molto carente e deficitaria per il fatto che fino all’avvento del Covid-19 abitavamo luoghi e rapporti rumorosi, dominati da un’incessante logorrea e da una diffusa incapacità di ascolto reciproco.
D’improvviso però, ci accorgiamo che ovunque è venuto a mancare il rumore.
E ci rendiamo conto di esserci abituati ad un sottofondo incessante di rumorosità con il quale abbiamo imparato a dormire di fianco ai binari del treno e a soffrire d’insonnia nei luoghi silenziosi e tranquilli.
È un cielo capovolto che ci appare e forse da questo nasce il pensiero di ritrovarci profondamente diversi dopo l’emergenza.
Ma per esserlo davvero dovremo avere risposte nuove e significati diversi da dare alla speranza che passi la nottata.
Sapremo valorizzare l’attesa che ci è imposta ora, se non la avremo sprecata e saremo stati capaci di impiegarla per ascoltare le parti inascoltate di noi stessi.
E non ci sembrerà inutile il tempo del silenzio ma, come dice Chandra Livia Candiani, lo sentiremo come «cosa viva».
Perché «lasciare uno spazio intorno ai gesti ordinari, dargli una stanza, li fa brillare, permette che aprano un varco nell’oscurità in cui di solito viviamo, nel nostro quotidiano sonno».
Giuseppe Maiolo
Psicoanalista - Università di Trento