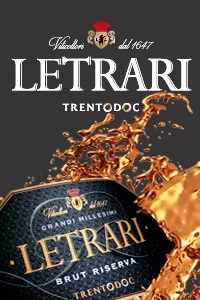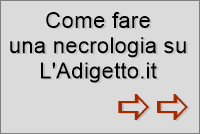Da una foto una storia/ 10 – Di Maurizio Panizza
Werk Valmorbia: un forte, due bandiere – A 100 anni dalla Grande Guerra, la cronaca di un tragico errore

Testi e immagini © Maurizio Panizza, cronista della Storia - Nella foto sopra, Forte Pozzacchio oggi.
 Ci sono immagini che nascondono segreti. Ci sono immagini che nascondono segreti.Saperle osservare senza pregiudizio, collegare più elementi, interpretare il contesto, consultare altre fonti, può diventare un’operazione molto interessante. Un’operazione che a volte può rivelare sorprese inaspettate. |
Fu nell’aprile del 1917 che un giovanissimo sottotenente del 158° Fanteria Brigata Liguria giunse spaesato ai comandi di un piccolo avamposto italiano in Vallarsa, ai confini meridionali del Tirolo (l’attuale Trentino), in quella che all’epoca era una provincia dell’Impero Austro-Ungarico.  La Prima Guerra Mondiale era terribilmente nel vivo e qui, in questa valle aspra e verdissima, a precipizio sul torrente Leno, si fronteggiavano l’esercito italiano e quello austriaco: il primo, per tentare di avanzare verso Rovereto e la Valle dell’Adige, il secondo per mantenere la posizione e contrastare l’offensiva del nemico.
La Prima Guerra Mondiale era terribilmente nel vivo e qui, in questa valle aspra e verdissima, a precipizio sul torrente Leno, si fronteggiavano l’esercito italiano e quello austriaco: il primo, per tentare di avanzare verso Rovereto e la Valle dell’Adige, il secondo per mantenere la posizione e contrastare l’offensiva del nemico.
Quel giovane ufficiale, del tutto inesperto di combattimenti, veniva da Genova e il suo nome era Eugenio Montale. Il reparto a cui venne assegnato si trovava fra il monte Corno e il piccolo paese di Valmorbia.
«In basso c’era un fiume – ricorderà Montale in una lettera, dopo la guerra – noi però si stava a mezza costa, fra le rocce, perché il fondo a precipizio era inabitabile, vi si rovesciava un po’ di tutto, rocce, sassi, fango, schegge, bombe, e pure cadaveri, che molte volte non potevano essere recuperati.»

Quell’anno la guerra aveva dato un po’ di tregua ai due eserciti portandoli a consolidare le rispettive posizioni in una specie di lungo, reciproco assedio. La prima linea austro-ungarica nel basso Trentino, iniziava da Riva del Garda, sormontava in trincea le montagne fin verso Rovereto, poi proseguiva con i forti di Matassone e di Pozzacchio che sbarravano la Vallarsa, per salire, infine, sul gruppo del Pasubio verso gli altopiani di Folgaria e Lavarone.
I soldati italiani e quegli austriaci si osservavano a distanza, talvolta però partiva da parte italiana un attacco, mentre, dall’altra, l’artiglieria austriaca rispondeva immediatamente.
Tuttavia, alla fine, i capisaldi rimanevano pressoché gli stessi, avanzando o retrocedendo in misura limitata, appoggiandosi molto a formazioni naturali o in trincea. Insomma, cambiava poco a parte il fatto che sul terreno rimanevano sempre morti e feriti.
Eugenio ben sapeva che l’anno precedente era stato molto peggio. Il 1916, infatti, era stato l’anno dove in quel teatro di guerra gli italiani avevano perso più di 3.500 soldati nel tentativo inutile di riconquistare terreno. Tutti ragazzi, tutti giovani alla pari del sottotenente Montale che all’epoca non aveva ancora compiuto i vent’anni.

Giovani come anche i protagonisti della storia che stiamo per raccontare, ma pure come i 12 milioni di soldati che vennero sacrificati sull’altare di quella carneficina durata quattro anni che passò sotto il nome di Grande Guerra.
Il primo protagonista di cui vogliamo parlare è un commilitone di Montale, di nome Giovanni  Givone, piemontese, soldato semplice del 72° fanteria della Brigata Puglie.
Givone, piemontese, soldato semplice del 72° fanteria della Brigata Puglie.
Il secondo, invece, è un soldato austriaco del K.u.K. 1° Landesschützen Reggimento Trento che si chiama Valerio Micheletti.
Entrambi hanno nomi italiani, entrambi parlano italiano, ma sono nemici. Il 24 maggio del 1915, infatti, l’Italia aveva dichiarato guerra all’ex alleata Austria (e quindi anche al Trentino), assumendo così il ruolo dell’aggressore nel momento in cui ad essa sembrava opportuna una partecipazione al conflitto in vista di una facile vittoria.
Alla fine, come sappiamo, la vittoria arriverà, ma la guerra non sarà stata affatto semplice, né tanto meno rapida. A migliaia avrà portato via a povere famiglie, sia italiane che austriache, i propri figli e mariti in quella che nel 1917 papa Benedetto XV chiamerà «l’inutile strage».
E ad accomunare tutti, un unico comune denominatore: l’obbedienza ai propri governi e l’incapacità di capire sino in fondo le ragioni di quell’assurda guerra.

Tornando a noi, dobbiamo dire che c’è anche un terzo protagonista in questa storia, che però non è un soldato, ma un «soggetto» che unirà il destino di tutti quanti.
Questo protagonista è una fortezza contesa dai due eserciti in campo, persino nel nome: viene, infatti, chiamata Forte Pozzacchio dagli italiani, Valmorbia Werk dai soldati dell’Impero Austro Ungarico.
È curiosa, oltre che drammatica, la storia di questo gigantesco caposaldo scavato nella roccia: dopo aver iniziato a costruirlo nel 1911, gli austriaci lo abbandonarono all’inizio delle ostilità per attestarsi su posizioni più arretrate, nei pressi di Rovereto.
Nel giugno del 1915 fu preso dagli italiani che vi innalzarono la bandiera tricolore, mentre poco più di un anno dopo, il 22 maggio del 1916, nel corso della cosiddetta «Strafexpedition» gli austriaci respinsero gli italiani e conquistarono di nuovo il forte.
Dicevamo delle due testimonianze, pressoché sconosciute - quella del soldato Giovanni Givone, italiano, e quella di Valerio Micheletti, austriaco, di Aldeno - attraverso le quali intendiamo ripercorrere ciò che avvenne in una tragica notte del 1916. Vediamole insieme.

Era il 28 giugno, quando gli italiani decisero di passare al contrattacco con il proposito di giungere a Trento il prima possibile. La via più breve per arrivarci era avanzare verso Valmorbia ed espugnare Forte Pozzacchio.
Venne così mandato avanti il 72° Fanteria Brigata Puglie nel tentativo di riconquistare il forte presidiato da alcune centinaia di soldati.
Dopo aspri combattimenti, durati tutto il giorno, gli austriaci si stavano ritirando dalle loro posizioni in Vallarsa per confluire verso il forte, tuttavia, con l’arrivo della notte, gli spari e gli scoppi delle granate cessarono.
A quel punto, verso le 03.30, venne ordinato a una decina di fanti italiani che sapevano parlare il tedesco, di intrufolarsi fra le truppe in ritirata, pare travestiti con uniformi austriache, e di risalire la piccola stradina che portava a Pozzacchio.
L’ordine del Comando italiano era tassativo: sfondare le linee nemiche e prendere il forte. La consistenza delle truppe italiane coinvolte era di circa 600 soldati, un numero più che sufficiente visto che si riteneva che all'interno del forte ci fossero pochi soldati.
In realtà il ripiegamento deciso dall'Alto Comando Austro-Ungarico, aveva portato numerose unità - pare ben più di un migliaio - a rifugiarsi nella fortezza di roccia viva, in attesa di nuovi ordini.
Potrà sembrare strano, ma il piano degli italiani andò alla perfezione: con il favore del buio e per il fatto che all’interno delle truppe austriache vi erano molti trentini di lingua italiana, nessuno si accorse degli intrusi. In tal modo l’avanguardia della Brigata Puglie avanzava indisturbata verso il forte.
In prossimità del primo posto di blocco, quando due sentinelle intimarono l’alt, gli italiani risposero in perfetto tedesco, ma subito dopo, spianando i fucili, colsero di sorpresa gli austriaci che vennero fatti prigionieri. Poi, con l’arrivo dei rinforzi, la stessa sorte capitò anche alle altre guardie.
Racconterà Givone nelle sue memorie: «Ormai siamo sul forte, dal nostro primo giungere subito tutti vediamo che tutto ci ha facilitato quest'impresa e ce ne rallegriamo di cuore pensando che questa forse sarà la giornata più bella e indimenticabile per il nostro reggimento, per la nostra vita. Tutta la guarnigione dorme, cosicché l'avanguardia è con facile compito che penetrata nei rifugi scavati nella roccia e riesce a fare un centinaio di prigionieri.»
Il Forte Pozzacchio, concepito per resistere al tiro degli obici da 305 mm., le artiglierie più distruttive disponibili alla vigilia della guerra, sembrava ormai in mano al nemico grazie a un ingegnoso stratagemma.

E di Valerio Micheletti, il protagonista austriaco di questa storia, cosa sappiamo? Il Micheletti - in quel momento anche lui a guardia del forte - in un racconto fatto dopo la guerra al parroco di Valmorbia, rivelerà un avvenimento sconcertante che verosimilmente contribuì a determinare l’esito di quella ardita offensiva. Un resoconto dettagliato narrato in prima persona, del tutto sconosciuto alla storiografia ufficiale.
«Io ero uno di quelli – riferì Micheletti – che per primi ebbero la sorpresa di vedersi puntare un fucile con l’ordine di arrendersi. All’alt d’arresto del finto austriaco, risposi «Sior sì» alzando le mani.
«Sei italiano?» - mi chiese quello,
«Sior sì, dal Trentim» risposi.
«Bene, allora devi sapere il tedesco – fece ancora lui – tu resta qui che mi farai da interprete».
E cosi Micheletti vide tutti i suoi commilitoni, uno ad uno, arrendersi ed essere avviati in silenzio sotto la minaccia delle armi, assieme a tutti gli altri, sul piccolo pianoro davanti al forte.
Fin qui, è da dire, tutto corrisponde con quanto scritto da Giovanni Givone nelle sue memorie.
«Prima di tutto gli italiani tagliarono i fili che uscivano dalla sala del Comando – racconta ancora il Micheletti non sapendo che l’autore di quel gesto era stato proprio Giovanni Givone – poi sistemarono davanti alla porta ferrata una mitragliatrice e quindi il Capitano intimò a voce alta di arrendersi.
«Dagli austriaci non venne alcuna risposta. Il Capitano ripeté l’intimazione. Ancora nessuna risposta. Allora diede ordine di aprire il fuoco con una raffica rabbiosa che poco dopo convinse chi era all’interno ad arrendersi e ad uscire a mani alzate. Tutti vennero disarmati e aggregati al gruppo di noi prigionieri.
«Fummo contati ad alta voce – dice il Micheletti – eravamo in 273, un numero che non dimenticherò mai.»
Come detto, anche Giovanni Givone era lì presente in quel momento e le sue parole annunciano tuttavia che qualcosa per gli italiani non andò per il verso giusto.
Riferirà, infatti, nelle sue memorie: «Ma ahimè! Fu così che la poca abilità dei nostri superiori nel farci occupare la posizione e la cretinaggine di alcuni ci cambiano la vittoria in una grave sconfitta.
«Incomincia il capitano col mandarci all'assalto quando un nemico da assalire non c'è ancora. Al rumore della mitragliatrice la guarnigione si desta e i rincalzi accorrono in tutta fretta all'aiuto di questi.»
In effetti, pare che se gli italiani avessero circondato il forte prima di intimare la resa, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente.

Nel frattempo il Micheletti, racconta: «Poco dopo, saranno state ormai le 5 del mattino e iniziava ad albeggiare, noi austriaci presi prigionieri venimmo avviati in colonna verso l’abitato di Valmorbia sotto la vigilanza armata di due soldati italiani davanti e due in coda. E ora scoppia la tragedia.
«Quando in fila fummo all’altezza delle bocche del Forte, seppi in seguito che due miei commilitoni, un tenente austriaco e un caporale sudtirolese - un certo Manica, da Pedersano - si affacciarono alla bocca prospiciente il sentiero con una mitraglia. Si resero conto dalla situazione e subito il caporale aprì la mitragliatrice contro la colonna dei prigionieri. “Fermati, - disse il tenente - sono dei nostri!”.
«Ne sei sicuro? Comunque sia - ribatté il Manica - c’è l’ordine di sparare sia sui prigionieri come sui disertori.»
Il fattore sorpresa ormai era svanito e la confusione si impossessò di chi poco prima sembrava il vincitore.
Prosegue l’italiano Givone: «Una parte della guarnigione del forte non coinvolta nell’azione perché occupava il settore nord, riuscì a rompere l’assedio a prezzo di fortissime perdite, sia fra gli assedianti che fra i prigionieri austriaci, ristabilendo così il controllo del forte.
«E qui constatai i terribili effetti della paura: i pochi soldati che con me avevano occupata l'altura, si diedero quasi tutti alla fuga.»

E il Micheletti continua: «Sotto il fuoco amico, tutti si buttarono a terra mentre la mitraglia non cessava di sparare e non servirono le nostre urla disperate per farci riconoscere».
L’angosciante descrizione del soldato austriaco, appiattito in un fosso, prosegue raccontando che sentiva le pallottole che battendo sulla roccia soprastante gli facevano piovere addosso sassi e ghiaia.
Poi prosegue: «La scena non la potevo vedere, ma le urla e i pianti si sentivano da straziare il cuore. Poi, poco a poco, non si sentì più nulla, solo qualche gemito sempre più flebile. Uno dei pochi ancora vivo alzò la testa per far cessare la carneficina, ma fu rapidamente colpito dalla raffica crudele.»
Ebbe così inizio un caos incredibile in cui gli austriaci, da tutte le bocche del forte, sparavano sugli italiani, gli italiani sugli austriaci ed entrambi pure sui propri commilitoni. Una situazione infernale dove ognuno cercava una via di fuga per salvare la pelle, chi scappando a precipizio lontano dal forte, chi cercando, all’opposto, di rientrarci.
Dei nostri protagonisti, Giovanni Givone verrà ferito e poi fatto prigioniero. Valerio Micheletti, rimasto indenne si riunirà al suo reparto.
Nei dintorni e sulla strada per il forte, invece, restarono alcune centinaia di soldati di entrambi gli eserciti. Una carneficina di corpi abbandonati in una «terra di nessuno».

Quel giorno e i successivi, infatti, nessuno poté avvicinarsi al campo di battaglia. Un testimone, infatti, riferì che «Il cannone italiano del Monte Zugna continuò a sparare senza pietà sui morti e sugli agonizzanti, cosicché il raccoglierli ed il seppellirli era semplicemente impossibile. E coloro che potevano essere ancora vivi, dovettero soccombere nella bruciante calura estiva, fossero austriaci o italiani.»
A tal proposito, dirà in seguito Micheletti: «Fu possibile solo ai primi di luglio far arrivare dei carri con buoi e cavalli per caricare i cadaveri. Con la maschera al naso per il fetore che essi per il gran caldo emanavano. E vennero trasportati nel cimitero di Volano e sepolti in due fosse comuni. In seguito, dopo la fine della guerra, saranno traslati nel Ossario di Castel Dante, a Rovereto.»
Nei documenti ufficiali italiani l’episodio del tragico assalto verrà semplicemente liquidato in poche righe.
«Il 29 giugno il 72° Fanteria tentò senza successo la conquista del Forte Pozzacchio.»
Da parte austriaca, invece, una rapida inchiesta della Procura militare decretò il non luogo a procedere nei confronti dei militari del 1° Reggimento Landesschützen, i quali avevano comunque riscattato con il loro comportamento gli errori compiuti durante l’occupazione del forte da parte italiana.

Dicevamo, all’inizio di questa storia, di Eugenio Montale, quello che in seguito diventerà un importante scrittore a cui molti anni dopo verrà conferito il premio Nobel per la letteratura. Il giovane ufficiale italiano rimase in Vallarsa a combattere la sua guerra di posizione sino al novembre del 1918, sino a quando, cioè, per l’esercito Austro-Ungarico iniziò la disfatta.
«Il 3 novembre del 1918 – scriverà Montale – fui uno dei primi soldati italiani a entrare a Rovereto. Non credo di aver mai visto un caos come quello: porte e finestre sfondate, macerie dappertutto, bombe che scoppiavano, incendi e, ora qua, ora là, i colpi dei cecchini che gli austriaci avevano lasciato indietro per ostacolare la nostra avanzata.
«Andammo avanti, sulla strada per Trento. In un paese, non saprei più dirne il nome, assistetti alla fucilazione di un nostro soldato, colpevole di saccheggio, credo che avesse rubato un orologio. Il ragazzo gridava disperato al plotone d’esecuzione: “Non fucilatemi! Sono figlio di un professore di geografia”.
«No, non mi fece un grande effetto. Ma che cosa poteva fare effetto in tali circostanze? Era come un sogno, un grande sogno in cui tutto poteva accadere.»
Montale in seguito non ritornò mai più volentieri sulle atrocità della guerra a cui aveva assistito. Tuttavia quando talvolta dava voce a quei ricordi, cercò sempre di evitare i momenti drammatici lasciando, invece, spazio a scene che potevano essere vicine a quelle di una normale vita quotidiana: alla natura incontaminata della Vallarsa, al profumo della terra, ai colori dei boschi, ai cieli stellati, al silenzio della notte...
«Ora forse dovrei parlare della battaglia finale e della vittoria – lasciò scritto nelle sue memorie – ma per me i ricordi più indimenticabili sono quelli di certe notti a Valmorbia, nella buona stagione, che passavo sdraiato sull’ingresso della mia grotta. Con la luna sembrava che la valle salpasse. In basso sentivo il torrente Leno che mormorava, roco.
«Udivo un trepestio insolito, un odore acre mi pizzicava il naso: erano delle volpi venute a farci visita; così, senza accorgersene, si arrivava all’alba.»

Dopo sette anni da quegli eventi, ad una lirica che oggi è diventata un emblema della poesia italiana, Eugenio Montale affiderà l’unico ricordo di quel periodo da lui trascorso in Trentino durante la Grande Guerra.
Valmorbia
Valmorbia, discorrevano il tuo fondo
fioriti nuvoli di piante agli àsoli.
Nasceva in noi, volti dal cieco caso,
oblio del mondo.
Tacevano gli spari, nel grembo solitario
non dava suono che il Leno roco.
Sbocciava un razzo su lo stelo, fioco
lacrimava nell'aria.
Le notti chiare erano tutte un'alba
e portavano volpi alla mia grotta.
Valmorbia, un nome e ora nella scialba
memoria, terra dove non annotta.
Maurizio Panizza - © Il cronista della Storia - [email protected]