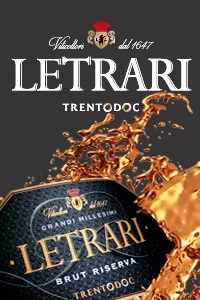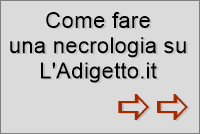La silenziosa guerra civile in Sud Sudan – Di Marco Di Liddo
Nelle ultime settimane, il conflitto inter-etnico che da oltre 4 mesi insanguina il Sud Sudan ha conosciuto una rinnovata e intensa escalation.
Tra il 15 e il 23 aprile, le milizie ribelli di etnia «nuer» hanno lanciato un’offensiva su larga scala verso le città di Bentiu, capitale dello Stato di Unity, cuore petrolifero del Paese, e Bor, nello Stato di Jonglei, nonché in diversi villaggi nello Stato nord-orientale dell’Upper Nile.
Gli episodi più cruenti hanno riguardato Bentiu, dove 200 persone, prevalentemente di etnia «dinka», sono state massacrate nei pressi di una moschea, e Bor, dove 58 civili hanno perso la vita nel corso di un attacco contro il locale campo profughi delle Nazioni Unite.
Da dicembre ad oggi, il bilancio di quella che può essere ormai definita «Guerra Civile Sud Sudanese» è giunto a oltre 13.000 morti, la maggioranza dei quali tra la popolazione civile, e 1 milione di rifugiati.
Con il passare dei mesi, il già fragile governo di Juba e la presidenza di Salva Kiir hanno dimostrato la propria incapacità militare e politica di gestire la crisi, fallendo nell’implementare un piano di riconciliazione sociale e di riforme inclusivo e nel promuovere il dialogo inter-etnico.
Inoltre, la ripresa di attività ostili da parte dei ribelli ha messo a nudo i limiti dell’azione diplomatica degli organismi sovranazionali e delle potenze regionali, su tutte l’Etiopia e Uganda, inefficaci nel sostenere un’incisiva soluzione negoziale alla crisi.
Se l’armistizio dello scorso 23 gennaio, siglato ad Addis Abeba tra il governo sud sudanese e i ribelli grazie all’intermediazione dell’Intergovernamental Authority on Development (IGAD), aveva fatto sperare in una rapida e pacifica risoluzione del conflitto, l’odierna e violenta ripresa degli scontri potrebbe spingere la Comunità Internazionale ad intraprendere un’azione militare per stabilizzare il Paese.
Questa potrebbe configurarsi in due ipotetiche maniere distinte: la prima sarebbe la trasformazione della United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) tramite la concessione di un mandato più estensivo e robusto in materia di peace enforcement, come avvenuto con la United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO); la seconda prevedrebbe la creazione di un’eventuale missione dell’Unione Africana (UA).
Tuttavia, sulla seconda opzione grava la mancanza di truppe africane sufficientemente addestrate da inviare nel teatro sud sudanese a causa dell’elevato numero di operazioni dell’UA attualmente in corso.
In ogni caso, ad oggi appare improbabile che Salva Kiir e il suo entourage siano in grado di risolvere autonomamente la crisi, sia perché le forze anti-governative usufruiscono di capacità, armi ed equipaggiamento pressoché identiche a quelle dell’Esercito lealista, sia perché la scena politica e sociale sud sudanese appare fortemente polarizzata su due fronti etnici contrapposti decisi al reciproco annientamento.
In questo contesto, il rischio maggiore è che la guerra civile assuma un pericoloso tratto genocidario e renda ancor più drammatica l’attuale catastrofe umanitaria.
Le dinamiche settarie rappresentano la principale chiave di lettura per comprendere le ragioni di una guerra civile che, pur essendo scoppiata a metà dicembre del 2013, ha radici molto più profonde ascrivibili a due elementi prioritari: gli attriti tra le diverse comunità etnico-tribali del Paese e il crescente autoritarismo personalistico di Salva Kiir.
Infatti, all’indomani dell’indipendenza dal Sudan, ottenuta nel 2011 dopo una guerra pluridecennale e grazie all’unità di intenti del fronte etnico, il Sud Sudan ha conosciuto la crescente competizione per il potere tra i dinka (35% della popolazione) e i nuer (15%), le due maggiori etnie del Paese.
Sin dai primi anni di governo, i dinka, attraverso la gestione monocratica, unidirezionale e clientelare del Presidente Kiir, hanno gradualmente imposto il proprio controllo sulle istituzioni politiche, militari ed economiche del Paese, monopolizzando i proventi dell’industria petrolifera e gli aiuti umanitari provenienti dalle organizzazioni internazionali. Inoltre, l’establishment di Juba ha intrapreso un massiccio processo di accentramento amministrativo al fine di diminuire l’influenza delle realtà tribali locali.
Di conseguenza, i nuer, gli shilluk (6% della popolazione) e le etnie minoritarie del Paese, espressione degli interessi dei singoli Stati federali, sono stati emarginati e subordinati dal centralismo propugnato da Kiir e dalle etnie vicine ai dinka, quali i Luo (4%) e i Murle (3,5%).
L’esempio concreto delle politiche assertive di Kiir è stato offerto dalle continue purghe attuate all’interno dell’apparato politico e militare del Paese.
Infatti, in poco meno di due anni (2011-2013), il Presidente sud sudanese ha costretto al congedo circa 200 ufficiali nuer delle Forze Armate, molti dei quali eroi della guerra d’indipendenza, e ha estromesso dalla scena pubblica e istituzionale del Paese ogni possibile avversario, compreso l’ex Vice-Presidente Riek Machar, anch’egli tra i «padri fondatori» della nazione sud sudanese, reo di voler sfidare Kiir alle prossime elezioni presidenziali del 2015.
L’ultimo, in ordine di tempo, a pagare il repulisti del Presidente è stato il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, il Generale James Hoth Mai, destituito formalmente a causa della pessima gestione militare della crisi ma sostanzialmente per la sua appartenenza etnica nuer e per le voci di un suo presunto imminente passaggio tra le fila dei ribelli.
In questo clima reso ancor più teso dalle continue ondate di arresti e processi sommari ai danni degli oppositori, Riek Machar ha progressivamente compattato attorno alla sua figura i nuer e i membri delle etnie minoritarie opposte al regime di Juba, reclutando attivisti politici, milizie tribali, formazioni paramilitari e interi reparti dell’Esercito.
Il punto di non ritorno è stato raggiunto a metà dicembre scorso, quando centinaia di soldati nuer e shilluk appartenenti al Sudan People Liberation Army (SPLA), l’Esercito nazionale del Paese, hanno defezionato per poi attaccare caserme, uffici governativi e stazioni radio nella periferia di Juba, tentando un rapido colpo di Stato per destituire Kiir.
Tuttavia, le fratture etniche della società sud sudanese e la fedeltà dimostrata dalla comunità dinka nei confronti del Presidente hanno impedito il successo del golpe.
A quel punto, Machar ha ordinato la mobilitazione totale delle milizie nuer ed ha cominciato una campagna militare su larga scala e in tutto il Paese. Oltre all’ex Vice-Presidente, a guidare la rivolta contro il governo centrale sono stati il Generale Peter Gadet, ex comandante dell’8ª Divisione dell’Esercito e leader del South Sudan Liberation Army (SSLA), formazione paramilitare nuer attiva nella regione nord-orientale dell’Upper Nile, l’ex Presidente del Sudan People Liberation Movement (SPLM) Pagan Amum Okiech, influente personalità di etnia shilluk, e Rebecca Nyandeng De Mabior, dinka e vedova di John Garang.
In particolare, la presenza della vedova del padre della nazione sud sudanese a supporto degli insorti lascia intendere come l’autoritarismo di Kiir abbia scontentato non solo le comunità subalterne, ma presumibilmente anche parte dei maggiori clan dinka.
Oltre agli ammutinati nuer dell’Esercito e alle forze paramilitari dello SSLA, i ribelli possono contare sull’appoggio del White Army (WA), milizia nuer dello Stato di Jonglei. In totale, le forze ribelli possono contare su circa 40.000 uomini (25.000 WA, 10.000 SSLA, 5.000 ex soldati nuer dello SPLA).
Di contro, i lealisti di Kiir sono quantificabili in circa 70.000 uomini, coadiuvati dal supporto di un contingente ugandese di 1.200 unità intervenuto, per ordine diretto del Presidente Museveni, a tutela degli interessi economici nazionali.
Infatti, il Sud Sudan non solo ospita migliaia di lavoratori ugandesi, ma rappresenta il principale mercato di esportazione per il governo di Kampala.
Ad oggi, i militari ugandesi operano prevalentemente nella capitale Juba e rappresentano una sorta ulteriore difesa per il regime di Kiir.
In questo contesto così frammentato e polarizzato, una delle incognite più preoccupanti è costituita dal ruolo che potrebbero ricoprire i signori della guerra, personaggi in grado di comandare milizie etniche di diverse migliaia di persone e che, al momento, sembrano non essersi legati a nessuno dei due fronti.
Infatti, i signori della guerra tradizionalmente perseguono agende politiche personalistiche e familistiche, senza schierarsi con nessun gruppo di contendenti finché non vengono toccati i propri interessi o finché non viene offerta loro una valida ragione (spesso di natura economica) per entrare nel conflitto.
Uno dei signori della guerra più controllati è al-Balola Hamid Abdel Bagi, ex sergente delle Sudan Armed Force (SAF), ex comandante dello SPLA, fondatore del gruppo SPLA-2 con
sede a Khartoum e leader di una milizia di circa 5.000 uomini attiva al confine tra i 2 Sudan nella regione dell’Upper Nile.
In questi quattro mesi, il conflitto sud sudanese è restato sempre in bilico e nessuna forza si è dimostrata in grado di poter prevalere nettamente sull’altra.
L’aspetto più preoccupante è il crescente coinvolgimento della popolazione civile e la volontà, sempre più marcata da parte di dinka e nuer, di cercare la vicendevole e sistematica distruzione.
Inoltre, la profonda diversità etnica che caratterizza il Paese ha determinato la creazione di più livelli di guerra civile. Infatti, mentre a livello nazionale lo scontro è tra dinka e nuer, a livello locale si moltiplica il coinvolgimento delle etnie minoritarie.
Questo è il caso dello Stato di Jonglei, tradizionalmente oggetto di violenza settaria dove alcuni clan minori nuer combattono contro i murle, sostenuti dai dinka, per l’accesso alle risorse naturali e per l’esercizio dei diritti sulla terra e sul bestiame.
In ogni caso, la chiave di volta militare del conflitto risiede nel controllo degli Stati di Jonglei e di Unity, preziosissimi per le risorse agricole e energetiche.
Infatti, gli scontri più efferati hanno riguardato queste due regioni, senza che nessuna delle milizie nuer o dinka riuscisse a stabilire il controllo continuativo delle aree in questione.
In ogni caso, qualora gli scontri pregiudicassero la produzione petrolifera nazionale, il danno per l’economia sarebbe incalcolabile, visto che il PIL sud sudanese dipende per il 98% dall’industria estrattiva idrocarburica.
L’eventuale mancanza di introiti petroliferi potrebbe verosimilmente privare Juba e Kiir di qualsiasi risorsa per sostenere la struttura statale e per soddisfare le basilari necessità di una popolazione già messa in ginocchio dalla guerra civile.
Se questo avvenisse, esiste la concreta possibilità del collasso totale delle istituzioni e del peggioramento della situazione umanitaria.
La radicalizzazione dello scontro tra nuer e dinka e la sostanziale uguaglianza di forze tra lealisti e ribelli rischia di prolungare a tempo indeterminato la guerra civile, replicando uno scenario di instabilità che purtroppo caratterizza da sempre il continente africano.
Oltre alla catastrofe umanitaria e al dramma delle vittime civili, il conflitto sud sudanese rischia di destabilizzare anche i Paesi vicini, aumentando il numero di rifugiati, incentivando l’afflusso di mercenari e creando un porto franco per i trafficanti di esseri umani, armi, materie prime e preziosi (compreso avorio).
Inoltre, se si pensa che anche la vicina Repubblica Centrafricana vessa in uno stato di completa anarchia da oltre un anno, è possibile comprendere l’entità dell’instabilità che caratterizza tutta la fascia africana equatoriale.
Si tratta di una minaccia concreta non solo per gli Stati della regione, ma per tutta la comunità internazionale.
Infatti, potrebbe verosimilmente aumentare il numero di migranti verso le coste del Mediterraneo, attraverso le rotte saheliane e sahariane, i traffici illegali di armi, beni preziosi ed esseri umani potrebbero arricchire i network criminali e terroristici sia in Africa Orientale che Occidentale e, infine, potrebbero esserci imprevedibili sconvolgimenti continentali a causa dei movimenti incontrollati della popolazione.
Un esempio valido e preoccupante di quest’ultimo rischio è rappresentato dalla recente epidemia di ebola scoppiata in Guinea Bissau che, secondo alcune fonti, potrebbe essere stata “importata” da migranti provenienti dall’Africa Centrale.
Marco Di Liddo
(CeS.I.)