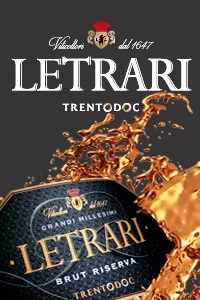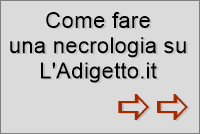Il futuro degli USA nelle elezioni di midterm – Di Lorenza Miretti
Oggi si eleggono l’intera Camera dei Rappresentanti (435 membri) e un terzo del Senato (35 senatori su 100) e in 36 Stati vengono eletti anche i governatori
>
L’America è oramai giunta ad una delle tappe più delicate del quadriennio presidenziale: le elezioni di medio termine (o di metà mandato), così chiamate perché fissate dopo i primi due anni del mandato del Presidente.
Il 4 novembre si eleggono, nell’ordine: le assemblee dei 50 Stati del Paese, l’intera Camera dei Rappresentanti (435 membri) e un terzo del Senato (quest’anno 35 senatori su 100, di cui 34 giunti allo scadere del mandato e quello della Florida dimissionario). Inoltre, in 36 Stati su 50 saranno eletti anche i governatori.
Nonostante non riguardino direttamente l’istituzione della Presidenza, le elezioni di medio termine finiscono per essere una sorta di referendum sui risultati raggiunti dal Governo nel biennio precedente nonché un indizio dei futuri orientamenti elettorali.
In linea generale, il numero dei seggi attribuiti al partito del Presidente è la spia dell’opinione dell’elettorato, così come la conquista o la perdita dell’appoggio del Congresso può influire pesantemente sull’attuazione del programma politico presidenziale.
Se il Presidente non ha l’appoggio di entrambe le Camere si può creare una situazione di impasse con Presidente e Congresso su fronti opposti ed il conseguente rischio di blocco del governo e dell’amministrazione del Paese affidata a quel punto ad una non facile politica di mediazione e compromesso.
In questo momento, però, è in gioco la stessa governabilità degli USA, poiché da quando i Democratici non hanno più la maggioranza alla Camera bassa, passata nel 2010 ai repubblicani dopo 8 anni, tutte le riforme portate avanti da Obama sono state fortemente osteggiate.
Basti pensare che, nel 2010, l’Obamacare (la riforma sanitaria voluta dal Presidente) passò senza l’appoggio del Partito Repubblicano, sempre meno disposto al dialogo con il partito presidenziale ed incalzato dall’ala destra del Tea Party.
Una fragile maggioranza democratica oggi permane solo nel Senato, con 53 seggi su 100. Tuttavia, non è da escludere un ribaltamento degli equilibri tale da consentire ai repubblicani di aggiudicarsi l’intero Congresso.
In questo momento, il clima politico non è particolarmente favorevole al Partito Democratico. Innanzitutto, la storia dimostra che, vittima del cosiddetto «six-year-itch» (il «prurito del sesto anno»), qualunque sia il partito del Presidente in carica, nelle elezioni di midterm questo è quasi sempre penalizzato e portato a perdere almeno uno dei due rami del Congresso, pur con importanti eccezioni come quelle di Bill Clinton nel 1998 e George W. Bush nel 2002.
Anche la conformazione dell’elettorato è un fattore a svantaggio dei Democratici che sono sostenuti soprattutto da quello femminile (il 57% del quale votò per Obama nel 2008), dai giovani e dalle minoranze, tutti gruppi più propensi a partecipare alle elezioni presidenziali che a quelle di medio termine, rispetto ai sostenitori del Partito Repubblicano, bianchi, di età media avanzata e tradizionalmente più partecipi alla vita pubblica statunitense.
Il disinteresse del bacino elettorale democratico appare assai pericoloso dal momento che più della metà dei seggi in gioco in Senato sono di Stati a tendenza repubblicana, quali Alaska, Arkansas, Iowa (la cui maggioranza però sostenne Obama nel 2012), Louisiana, North Carolina e Montana, e dove quindi ai Democratici sarebbe necessaria una mobilitazione elettorale totale.
Stando ad alcuni sondaggi dei principali network d’informazione nazionali, rischiano di diventare repubblicani ben 12 seggi democratici (tra questi, quelli in Arkansas, North Carolina, New Hampshire, Virginia, Iowa, Michigan e South Dakota), con il 71% delle probabilità per i Repubblicani di conquistare il Senato.
In tale situazione, l’ultima speranza per i Democratici sarebbe il voto degli Afro-Americani, gli stessi che si mobilitarono per far rieleggere Obama nel 2012 (in Maryland lo sostenne il 97% dei votanti) e che rappresentano una porzione sostanziale dell’intero elettorato.
Non sorprende allora che il candidato democratico del Maryland Elijah E. Cumming stia spingendo sul caso Michael Brown (il giovane di colore ucciso da un poliziotto bianco a Ferguson) per conquistare questa fascia elettorale e che Bill Clinton, molto popolare tra i votanti di colore, sia al suo secondo viaggio attraverso l’Arkansas per sostenere i Democratici.
Di contro, i Repubblicani rischiano di alienarsi il supporto degli ispanici (soprattutto in Arkansas, Kansan e New Hampshire) a causa delle accuse rivolte ai Democratici di non aver saputo arginare l’immigrazione illegale.
La loro campagna ha avuto molta risonanza perché associata all’idea che il Governo stia fallendo nel proteggere il Paese su più fronti, compresi quello del fondamentalismo islamico in Medio Oriente e del virus ebola, la cui diffusione negli States rischia di essere manipolata e trasformarsi in un vera e propria fobia.
La contestazione repubblicana colpisce su larga scala le scelte del Presidente, ma, mentre molti sondaggi (ABC News/Washington Post, CNN, ORC International) estendono a circa il 60% del popolo americano lo scontento sulle questioni interne (miglioramento dell’economia, aumento del minimo salariale e parità di retribuzione, riforma sanitaria, disordini a Ferguson), tale dato non riguarda la politica estera, poiché il popolo americano giudica positivamente la maggiore cautela di Obama verso le crisi in Siria-Iraq e in Ucraina, soprattutto per quanto riguarda un massiccio coinvolgimento militare del Paese.
Infatti, nelle relazioni internazionali, Obama ha privilegiato, nell’ottica di una visione idealista ed anti-isolazionista, il principio del «don’t do stupid staff» (DDSS) radicalmente diverso da quello repubblicano interventista del «act first and think last», cioè ha messo in pratica quella che si può definire l’eredità post-Bush del concludere le guerre e non dell’iniziarne in modo precipitoso.
Davanti ad un concatenarsi di crisi dalla portata mondiale (oltre alla già menzionata recentissima epidemia di ebola, le questioni siriana, iraniana e libanese oppure la crisi ucraina e le rinnovate tensioni con la Russia) la politica estera americana degli ultimi anni è stata completamente rivoluzionata da Obama rispetto alla precedente «era-Bush», caratterizzandosi per i toni moderati volti al dialogo (anche con Paesi fino a qualche anno fa non oggetto dell’interesse americano) più che al pugno di ferro.
Proprio questo approccio moderato e poco interventista però è quello che i Repubblicani ritengono causa della perdita della leadership statunitense nel mondo.
Se il 4 novembre i Democratici perderanno il Senato, si troveranno di fronte ad un Congresso interamente repubblicano che ostacolerà più che in passato le azioni del partito presidenziale: dai metodi messi in atto per contrastare la diffusione dell’epidemia di ebola al piano per la drastica riduzione del budget delle spese militari da attuarsi entro il 2025.
Ma la questione non è solo se i Repubblicani conquisteranno o no il Senato, ma anche quali Repubblicani occuperanno i seggi della Camera Alta.
Infatti, la grande incognita è costituita dalla forza del Tea Party, nome che deriva emblematicamente da Taxed Enough Already («già abbastanza tassati») e dalle proteste settecentesche del Boston Tea Party contro le gabelle inglesi.
Tale ala ultraconservatrice vorrebbe far eleggere un numero sufficiente di senatori e rappresentati per effettuare un radicale «turn back on a costitutional course», ossia ridurre la tassazione, le spese ed il controllo del governo di Washington, difendere gli interessi americani entro e fuori i confini dello Stato e tutelare la produzione e i lavoratori statunitensi (in Michigan il Tea Party accusa Obama di aver «dato via», aprendo le frontiere agli stranieri, posti di lavoro ben pagati che spettavano agli americani) oltre che riaffermare con forza la potenza militare del Paese (per esempio con una risposta militare più decisa contro l’ISIS).
Quindi è la composizione dell’eventuale maggioranza repubblicana al Senato che potrebbe determinare il maggiore irrigidimento del Congresso nei confronti delle politiche democratiche e l’ostacolo maggiore al procedere delle scelte del presidente Obama, riformiste entro i confini e moderate oltre frontiera.
Di Lorenza Miretti
(Ce.S.I.)