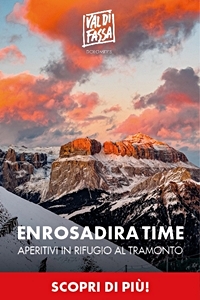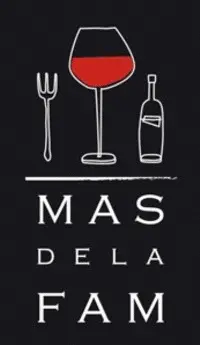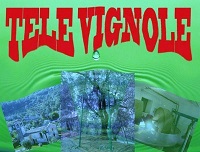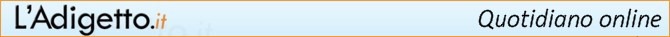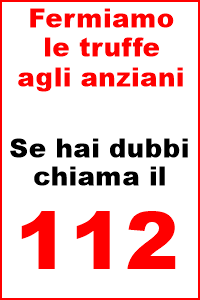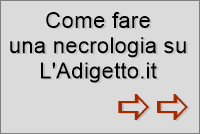Italo Svevo, Tullio Kezich, Maurizio Scaparro, Giuseppe Pambieri
Fanno rivivere (con leggerezza) la tragica quotidianità di «La coscienza di Zeno»

Italo Svevo, Tullio Kezich, Maurizio Scaparro, Giuseppe Pambieri: è firmato da un poker di nomi davvero di grande prestigio lo spettacolo che andrà in scena a Trento da giovedì 6 a domenica 9 febbraio al Teatro Auditorium. Inserito nel cartellone della Stagione di Prosa organizzata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara, «La coscienza di Zeno» è una produzione del Teatro Carcano di Milano che già nel corso della passata stagione ha ottenuto favori unanimi da parte di pubblico e critica.
Pubblicato a Trieste nel 1923 e ritenuto il romanzo più maturo e originale di Italo Svevo, La coscienza di Zeno abbandona il modulo romantico ottocentesco e, come nel caso di Musil o del pirandelliano Mattia Pascal, di Joyce o di Proust, ai quali pure è stato accostato, introduce l’aspetto tutto novecentesco dell’introspezione.
Dal romanzo narrato da una voce anonima ed estranea al piano della vicenda, si passa a una narrazione in prima persona che non presenta gli avvenimenti nella loro successione cronologica lineare, ma inseriti in un tempo tutto soggettivo che mescola piani e distanze.
Nella sua opera più conosciuta, Svevo affronta un viaggio nella mente umana, un percorso nella malattia e nella cura; ci parla dell’insoddisfazione e dell’inquietudine dell’uomo che si percepisce come corpo estraneo della società, fornendo il ritratto di un’epoca e, insieme, quello di un’umanità senza tempo.
Sullo sfondo di una Trieste cosmopolita e mercantile, ma anche crogiolo culturale della Mitteleuropa tra la fine della Belle Epoque e la prima guerra mondiale, il romanzo si apre con la Prefazione: lo psicanalista dottor S. induce il paziente Zeno Cosini, vecchio commerciante, a scrivere un’autobiografia come contributo al lavoro psicanalitico.
E poiché il paziente si è sottratto alle cure prima del previsto, il dottore pubblica, per vendicarsi, il manoscritto, articolato in sei episodi.
«Il fumo» racconta dei vari tentativi attuati dal protagonista per guarire dal vizio del tabagismo, che rappresenta la debolezza della sua volontà, senza però essere mai riuscito ad accendere l'ultima sigaretta.
Ne La morte di mio padre è raccontato il difficile rapporto di Zeno con il padre, che culmina nello schiaffo dato al figlio dal genitore morente.
In Storia del mio matrimonio Zeno è alla ricerca di una moglie. Frequenta casa Malfenti e si innamora di una delle quattro figlie del padrone di casa, Ada, la più bella. Viene però respinto e, dopo essere stato rifiutato da un’altra sorella, viene accettato dalla materna e comprensiva Augusta.
Nel capitolo La moglie e l’amante Zeno rievoca invece la relazione con Carla; egli non sa decidersi fra l’amore per la moglie e quello per l’amante, finché non sarà quest’ultima a troncare il rapporto.
Il capitolo Storia di un’associazione commerciale è incentrato sull’impresa economica avviata con il cognato Guido, a cui Zeno non riesce a perdonare di aver sposato Ada, di cui era innamorato.
Qui terminano i capitoli del memoriale.
Zeno, abbandonato lo psicanalista, scrive poi un altro capitolo, intitolato «Psicoanalisi», in cui spiega i motivi dell’abbandono della cura e proclama la propria guarigione.
«In quanto – spiega – La vita attuale è inquinata alle radici e l’unico mezzo per essere sani è l’auto-convicimento di esserlo.»
Chiude il romanzo l'apocalittica previsione di una catastrofe, prodotta dagli ordigni di una guerra e che travolgerà l'Europa.
All’interno di un’autobiografia che appare come il gigantesco tentativo di auto-giustificazione da parte di un uomo inetto che vuole dimostrarsi innocente da ogni colpa nei rapporti con gli altri, Zeno si racconta in modo così ironicamente disincantato e distaccato da far apparire l’esistenza tragica e comica insieme.
Fragile e inadeguato di fronte ai cambiamenti della società, pieno di tic e di nevrosi, sempre alla ricerca di un modo di essere plausibile in un mondo che sembra sfuggirgli, Zeno si dichiara «malato», ma la sua malattia è tutta di origine psicologica.
Di fronte alla vita egli riesce però sempre a mantenere un atteggiamento distaccato («La vita non è né brutta né bella, ma è originale») che gli permetterà di capirla meglio e, quindi, di crescere.
Maurizio Scaparro fa proprio lo storico adattamento realizzato nel 1964 da Tullio Kezich che, rimanendo fedele al romanzo, riuscì a valorizzarne lo spirito e a trasferirne le strutture teatrali in una commedia che scorre, divertente e malinconica, fino al bellissimo, inquietante monologo finale sulla ferocia e l'inutilità di quella guerra che, di lì a poco, avrebbe rivoluzionato tutto.
Nella sua nitida ed elegante regia, Scaparro (presente nella Stagione teatrale di Trento fin dal 1971 quando diresse il Teatro Stabile di Bolzano ne L'ultima analisi di Saul Bellow) vince in scioltezza la non facile scommessa di portare sulla scena il capolavoro di Svevo, non catalogabile come romanzo d’azione o d’intreccio, bensì come libro d’iniziazione e introspezione.
Tratteggia con tocchi insieme ironici e meditativi il personaggio di Zeno Cosini, Giuseppe Pambieri, attore tra i più versatili del nostro teatro che gli appassionati trentini della prosa hanno iniziato ad applaudire già nel 1981 quando interpretò sul palcoscenico del vecchio “Sociale” il ruolo di Petruccio ne La bisbetica domata di Shakespeare in un allestimento di Marco Parodi che vedeva impegnata anche la moglie, Lia Tanzi, nel ruolo di Caterina.
Accanto a Pambieri, sono in scena ne «La coscienza di Zeno» Nino Bignamini (il dott. S./Giovanni Malfenti); Giancarlo Condé (il dott. Coprosich/Enrico Copler); Francesco Wolf (Guido Speier); Raffaele Sincovich (Luciano); Anna Paola Vellaccio (La signora Malfenti); Antonia Renzella (Augusta Malfenti); Guenda Goria (Ada Malfenti); Margherita Mannino (Alberta Malfenti); Silvia Altrui (Anna Malfenti) e Marta Ossoli (Carla Gerco).
Le scene sono di Lorenzo Cutùli e i costumi di Carla Ricotti. Le musiche originali portano la forma prestigiosa di Giancarlo Chiaramello, compositore e direttore d'orchestra che, oltre ad aver curato durante gli anni '60 e '70 gli arrangiamenti per cantanti e gruppi musicali di successo quali Milva, Claudio Villa, Sergio Endrigo, i Delirium e i New Trolls, ha collaborato al cinema e in teatro con alcuni fra i maggiori registi italiani e stranieri.
Giovedì 6 e venerdì 7 febbraio il sipario del Teatro Auditorium si alzerà alle 20,30. Sabato 8 l'inizio dello spettacolo è previsto invece per le ore 21, mentre domenica 9 è in programma alle ore 16.00 la recita pomeridiana.