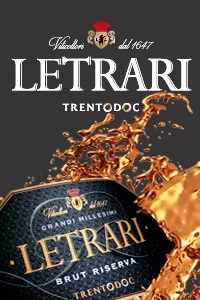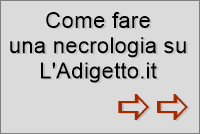Il radicalismo buddista in Myanmar e Sri Lanka – Di Alberto Parisi
Una reazione per proteggere i buddisti nel mondo dalla minaccia del fondamentalismo islamico
>
Nel corso della conferenza Buddhist Power Force, tenutasi il 28 settembre nella città di Colombo in Sri Lanka, il movimento buddista nazionalista del Myanmar «969» ha stretto un’alleanza con il suo omologo cingalese, Bodu Bala Sena (BBS), con l’obiettivo dichiarato di proteggere i buddisti nel mondo dalla minaccia del fondamentalismo islamico.
Benché non si conoscano specifici dettagli dell’accordo, questo rappresenta la nascita, per lo meno simbolica, di un’inedita alleanza transnazionale tra formazioni politiche rappresentanti del nazionalismo radicale buddista.
Entrambi di recente formazione, i due gruppi sono il frutto della pluriennale esperienza dei propri leader all’interno della galassia del radicalismo buddista, che ha inevitabilmente condizionato l’agenda delle due formazioni.
I due movimenti, infatti, sono promotori nei rispettivi Paesi di un programma politico nettamente anti-musulmano, tanto da essere stati più volte accusati di aver alimentato le violenze nei confronti delle minoranze islamiche attraverso la propria propaganda.
Risalgono all’estate scorsa, infatti, i più recenti episodi di violenza, scoppiati tra giugno e luglio in Sri Lanka e Myanmar, riconducibili alle attività dei due movimenti.
Nello Sri Lanka i cortei di protesta organizzati da Bodu Bala Sena, in occasione della presunta aggressione a un monaco buddista nella città di Dharga, hanno dato il via ad una serie di attacchi contro la comunità musulmana, provocando quattro morti, oltre 80 feriti e costringendo circa 10.000 persone ad abbandonare le proprie abitazioni.
Analoghi episodi si sono verificati in Myanmar, dove la propaganda anti-musulmana, fomentata dalla leadership di 969 sembrerebbe aver alimentato gli incidenti nella città di Mandalay, ultimi episodi di una spirale di violenza che, dal 2013, ha causato all’incirca 50 vittime.
Il movimento birmano 969 si struttura come vero e proprio network politico nel 2011, in seguito alla liberazione del suo leader Ashin Wirathu, arrestato sette anni prima con l’accusa di incitamento alla violenza nei confronti della comunità islamica.
Benché la formazione si autodefinisca pacifica e abbia sempre negato ogni accusa relativa all’aver fomentato gli scontri inter religiosi nel Paese, le misure proposte dal movimento, quali il boicottaggio di attività economiche riconducibili a proprietari di religione islamica e il tentativo di promuovere uno status sociale privilegiato per i cittadini buddisti, hanno inevitabilmente contribuito ad inasprire le relazioni inter-comunitarie.
Analoga l’agenda del movimento cingalese Bodu Bala Sena, considerata la più potente organizzazione buddista dello Sri Lanka nonché la principale promotrice di manifestazioni anti-islamiche all’interno del Paese.
Formata nel 2012 dai monaci Kirama Wimalajothi e Galagoda Aththe Gnanasaara dopo la loro fuoriuscita dal partito Jathika Hela Urumaya (JHU), di matrice nazionalista e conservatore ma giudicato poco efficace nella difesa dei cittadini di fede buddista, il movimento è contrario a un’identità nazionale multiculturale e persegue la marginalizzazione delle minoranze etniche e religiose.
Il gruppo è stato promotore di leggi per l’istituzione di canali preferenziali per i giovani buddisti nell’accesso agli studi universitari e per l’affidamento al clero dell’insegnamento delle principali materie nelle scuole pubbliche.
BBS ha promosso inoltre campagne dal forte contenuto simbolico, quali quella contro l’introduzione della certificazione halal per le carni macellate secondo il rituale islamico.
Oltre che dagli evidenti punti di contatto nelle agende tra 969 e BBS, la nascita di un’alleanza transnazionale buddista di matrice radicale sembrerebbe essere stata favorita in particolare dal momento di delicata transizione politica in cui si trovano lo Sri Lanka e il Myanmar, rispettivamente dal 2010, al termine del conflitto armato tra il governo e il gruppo indipendentista delle Tigri Tamil, e dal 2011, in seguito allo scioglimento della giunta militare.
Nonostante le diffuse aspettative per una maggiore democratizzazione dei due Paesi, le difficoltà dei nuovi governi nell’elaborare politiche sociali inclusive e trasversali al tessuto sociale della popolazione ha generato un inasprimento delle tensioni interreligiose.
A questo, inoltre, talvolta si aggiunge un vero e proprio senso di diffidenza da parte delle stesse autorità statali nei confronti della minoranza musulmana che, considerata un potenziale pericolo per la stabilità dello Stato, si trova marginalizzata rispetto al resto della popolazione, con inevitabili ripercussioni sulla coesione interna.
Un esempio significativo di questa tendenza è rappresentato dal controverso rapporto tra il governo birmano e la popolazione Rohingya, minoranza etnica di fede musulmana che rivendica la propria origine nella regione occidentale di Rakhine (nella quale vive tuttora il nucleo numericamente più consistente) ma che il governo centrale considera essere originario del Bangladesh e a cui, dunque, non riconosce il diritto di cittadinanza.
Con una popolazione di circa 800mila persone, il gruppo costituisce una delle componenti principali dell’Islam birmano.
Emarginati, dunque, dalle stesse istituzioni statali, i Rohingya portano avanti una battaglia contro il governo centrale per l’indipendenza delle aree settentrionali della regione di Rakhine dal resto del Paese.
Tale rivendicazione si è manifestata per più di sessant’anni in un vero e proprio conflitto con l’autorità centrale portata avanti da una serie di realtà militanti che, a partire dal 1998, si sono riunite sotto il cappello dell’Arakan Rohingya National Organization (ARNO).
La marginalizzazione e la conflittualità con lo Stato centrale ha, nel tempo, creato sempre maggior spazio per l’emersione delle realtà più radicali all’interno della comunità Rohingya e per un loro avvicinamento ad esponenti del network internazionale di al-Qaeda, preziosa fonte di addestramento e di rifornimento per i gruppi irridenti.
Il mancato riconoscimento dei diritti sociali da parte dello Stato, dunque, va ad acuire il senso di disagio di una comunità, quale la minoranza Rohingya di Rakhine, già fortemente interessata dalla continua conflittualità con la locale comunità buddista, scaturita spesso in sanguinosi episodi di violenza. La più recente recrudescenza del conflitto è avvenuta nel 2012, con aggressioni popolari da parte dei buddisti locali sostenuti, più o meno apertamente, da settori delle forze di sicurezza statali.
Gli incidenti hanno causato almeno 160 morti e la fuga dalle proprie case di oltre 100mila persone. Circa 500mila Rohingya hanno abbandonato il Paese negli ultimi decenni: la diaspora, che ad oggi rappresenta circa la metà del totale della popolazione, ha interessato in modo significativo Arabia Saudita, Bangladesh, Pakistan e Thailandia.
La diffidenza con cui i Paesi di destinazione hanno guardato l’esodo dei Rohingya ha determinato inevitabilmente l’impossibilità per i migranti di integrarsi all’interno delle nuove società.
La marginalizzazione sociale a cui sono costretti e la mancanza di politiche di integrazione da parte dei Paesi ospitanti, dunque, hanno acuito il senso di frustrazione all’interno di queste comunità, generando anche all’interno dei Paesi di accoglienza possibili focolai di tensione sociale.
La diffusione della presenza di minoranze Rohingya in una regione che si estende, di fatto, dal Bangladesh alla Thailandia, e le precarie condizioni sociali a cui queste sono sottoposte, potrebbe ora rivelarsi un fattore di grande criticità per tutta la regione.
Un simile contesto di politiche repressive da parte delle autorità centrali nei confronti delle minoranze, divisioni etniche, sia interne che transnazionali, e uno storico conflitto interreligioso che si riacutizza nell’attuale fase di transizione verso nuovi modelli di governance nazionale, è però comune anche ad altri contesti dell’Asia sud-orientale e del subcontinente indiano.
In uno scenario caratterizzato da forti politiche repressive delle autorità statali nei confronti delle minoranze musulmane e da divisioni etnico-religiose, spesso causa di violenti scontri intra-comunitari, infatti, il risentimento della comunità musulmana nei confronti dei diversi governi centrali e, più in generale, il senso di estraneità rispetto ad un contesto sociale in cui non si sente accolta potrebbe creare un terreno fertile per l’emersione di istanze maggiormente radicali e più sensibile al richiamo del jihadismo internazionale.
In un momento in cui i due grandi gruppi jihadisti, al-Qaeda e lo Stato Islamico (IS) si stanno contendendo il primato nel panorama del terrorismo internazionale, l’Asia meridionale e sud-orientale sembra poter essere il contesto in cui nei prossimi mesi potrebbe giocarsi questa partita. emerso, negli ultimi mesi, come il suo ultimo obiettivo strategico.
Già solo restando nel contesto birmano e in quello cingalese, la rapida successione di annunci e dichiarazioni da parte dei gruppi estremisti evidenzia la grande attività e interesse per l’area.
In seguito alla diffusione di materiale propagandistico di IS nella regione e alla formazione di gruppi simpatizzanti per l’operato del Califfato in Siria e in Iraq, quali lo Stato Islamico in Sri Lanka (gruppo di cui al momento non si hanno maggiori informazioni), infatti, anche la leadership di al-Qaeda, dopo mesi di silenzio sembra ora interessata a rinvigorire la propria presenza in questo territorio.
Ad inizio settembre, Ayman al-Zawahiri ha annunciato la nascita di al-Qaeda nel Subcontinente Indiano (AQIS): il gruppo ha tra i suoi obiettivi dichiarati la creazione di una struttura pronta ad agire attivamente nella difesa dei musulmani in una regione che si estende dal Pakistan al Myanmar, all’interno della quale il richiamo alla violenza jihadista potrebbe risultare attraente presso le minoranze islamiche perseguitate.
Ad accelerare l’esacerbazione del risentimento delle frange più radicali all’interno della comunità musulmana potrebbe contribuire anche il ritorno in patria di quei combattenti che, unitisi alle fila dei jihadisti in Siria e in Iraq, una volta rientrati in patria potrebbero non solo fomentare la formazione di gruppi strutturati di matrice jihadista ma soprattutto potrebbero dare valore aggiunto, in termini di expertise e abilità militari, ad un eventuale militanza all’interno della regione.
Fino ad ora in Medio Oriente è stata confermata la presenza di miliziani provenienti da nove nazioni dell’Asia meridionale e sud-orientale.
Il ruolo globale assunto dall’estremismo islamico, l’inserimento nella sua agenda del sostegno alle rivendicazioni locali dei musulmani dell’area e il consolidamento all’interno di queste della deriva jihadista, starebbe quindi spingendo anche le formazioni radicali buddiste a conseguenti risposte transnazionali.
L’alleanza sancita a Colombo tra il birmano 969 e il cingalese BBS potrebbe favorire la nascita di un vero e proprio network operativo buddista internazionale, spingendo questi movimenti ad abbracciare pienamente l’uso della violenza anti-islamica per esercitare un maggiore potere di controllo e indirizzo delle frange più radicali della popolazione.
Tali formazioni, già forti del controllo politico, qualora in futuro si dotassero di bracci armati in grado di provocare una sistematica escalation delle violenze, potrebbero essere sfruttate da gruppi di potere interni e diventare oggetto di attenzione e sostegno da parte di attori internazionali interessati al contenimento del fondamentalismo islamico nell’area.
La prospettiva di un’ulteriore allargamento dell’alleanza ad altre realtà buddiste radicali costituirebbe uno scenario in grado di far deflagrare nell’area un conflitto religioso dagli esiti potenzialmente destabilizzanti.
Con il rischio della creazione di una nuova linea di faglia interna all’Asia meridionale e sud-orientale, che potrebbe vedere contrapporsi nazioni e opinioni pubbliche nel sostegno a una delle due comunità religiose.
Alberto Parisi