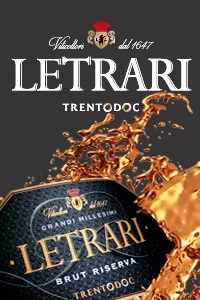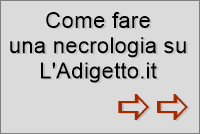C’è chi ha il vizio di non avere vizi – Di Daniela Larentis
«E questo è il vizio più imperdonabile di tutti»

C’è chi ha il vizio di non avere vizi e questo è il vizio più imperdonabile di tutti.
Scusate il gioco di parole e la battuta un po’ scontata, però le persone perfette o che si ritengono tali danno sui nervi a ognuno. Io, per esempio, ho anche quello di consumare un pezzetto di cioccolato fondente assieme al caffè, dopo pranzo, e lo faccio ogni santo giorno. Per me è un rito. Un momento di piacere irrinunciabile (il binomio caffè più cioccolata è davvero qualcosa di inenarrabile).
Diciamolo pure, un vizio più che un’abitudine, perché ne traggo un gran appagamento anche se ammetto che, avendo una certa predisposizione alle intolleranze alimentari, sarebbe meglio evitarlo per non scatenare possibili reazioni allergiche.
Cosa mi spinge a farlo? Debolezza? Non credo proprio, è un atto volontario, consapevole, è il concedersi un piacere a cui non si vuole proprio rinunciare.
Alle volte mi chiedo come sarebbe la mia vita senza quel minuscolo rettangolino scuro (sicuramente avrebbe meno sapore).
Ma quanti sono i vizi? Ce ne sono a centinaia, anzi, a migliaia.
Il punto è scegliere quale concedersi e quali evitare con assoluta fermezza. Infatti, non sono tutti uguali.
A mio parere, ce se ne può concedere anche uno, inteso come una passione per qualcosa che non deve però trasformarsi in una grave dipendenza, o addirittura in una patologia.
In altre parole, il vizio non deve essere portato all’eccesso e quindi arrivare a danneggiare se stessi e gli altri.
Cosa s’intende con questo termine nell’accezione più comune?
Alle volte se ne parla sottintendendo un’abitudine che ha comunque una connotazione negativa, ad esempio «il vizio di interrompere», «il vizio di parlare a sproposito», «il vizio di arrivare sempre in ritardo» ecc.
Negli altri casi ci si riferisce a un comportamento ripetuto nel tempo, potenzialmente nocivo (anche di lieve gravità), che mina il benessere individuale.
Sottolineo che ci sono vizi che è meglio davvero evitare. Condotte che annientano se stessi i cui effetti non si possono ignorare.
Non dimentichiamo che certi vizi uccidono.
Del resto ogni individuo deve riflettere profondamente sulle conseguenze delle proprie azioni. Sempre.
«Molti vizi, quando sono di moda, passano per virtù». Questo affermò con grande acume Molière, il drammaturgo e attore teatrale del Seicento, nel V atto della sua commedia «Don Giovanni».
E non succede forse così anche ai nostri tempi?
Non è sotto gli occhi di tutti? In un contesto diverso da quello di adesso, dove in gioco c’era la salvezza dell’anima, furono individuati i sette vizi capitali che rispecchiano, contrapponendosi alle virtù, inclinazioni distruttive dell’animo umano.
Aristotele li aveva definiti sommariamente «abiti del male» (i vizi derivavano secondo il filosofo dalla ripetizione di determinate azioni che formavano in chi li possedeva una seconda natura, un abito, che inclinava verso una determinata direzione. Più o meno questo il concetto).
Secondo la Chiesa i vizi capitali (i cosiddetti peccati capitali e cioè atteggiamenti che allontanano da Dio conducendo al male, «capitali» nel senso che generano altri vizi, altri peccati) sono: la superbia (il primo per la morale cristiana, il peggiore), l’avarizia, la lussuria, l’invidia, la gola, l’ira, l’accidia.
Quest’ultima è tipica dell’annoiato cronico, l’accidioso è infatti indolente e indifferente a ciò che gli accade intorno.
Se l’ira è intesa non come una sporadica sfuriata, ma come un atteggiamento che induce chi la prova a scatenare una furia incontrollata per ogni inezia, la gola si manifesta invece non unicamente come ingordigia, ma come l’abitudine a cibarsi solamente di cibi costosi e raffinati (il goloso è quindi l’amante del lusso alimentare).
L’invidia è proprio un brutto vizio, tanto che le ho dedicato, a suo tempo, pure un articolo, mentre della lussuria non saprei che dire, lascio a ognuno una libera interpretazione a riguardo.
L’avaro è molto oculato nelle spese, estremamente parco e poco propenso a condividere con chicchessia averi, soldi, perfino sentimenti.
Il superbo ama sminuire gli altri ed è colui che sopravvaluta se stesso.

Nel Medioevo i vizi capitali erano otto. Era considerato un peccato, infatti, anche la tristezza, intesa come abbattimento dell’anima.
Chi volesse leggere un libro dedicato proprio ai vizi capitali in questa epoca può leggere il saggio «I sette vizi capitali.
Storia dei peccati nel Medioevo» di Casagrande Carla e Vecchio Silvana, edito da Einaudi.
Ai vizi capitali Dante dedicò alcuni cerchi dell’Inferno nella Divina Commedia (il viaggio immaginario del poeta ha inizio la notte del Venerdì Santo del 1300, quando giunto a metà del cammino della vita umana si trova improvvisamente in una selva oscura, avendo smarrito la strada).
Nel secondo cerchio sistemò i lussuriosi (fra i quali Paolo e Francesca, che si amarono compiendo adulterio, sottomettendo la ragione alle passioni), nel terzo mise i golosi, nel quarto gli avari (puniti insieme agli scialacquoni).
Nel quinto piazzò gli iracondi e gli accidiosi.
Citati nel poema anche l’invidia e la superbia (l’esasperazione del desiderio naturale di eccellere potremmo definirla molto sinteticamente); quest’ultima secondo Gregorio Magno (papa della chiesa cattolica, venerato come santo e vissuto nel VI secolo) era la radice di tutti i mali.
Da lei nasceva la vanagloria (che vi confluiva), e da questa l’invidia che generava a sua volta l’ira.
Dall’ira nasceva la tristezza e da questa l’avarizia. Poi era il turne o di gola e lussuria.
Per tutto il Medioevo e nelle epoche successive filosofi e teologi ne parlarono a lungo (S. Agostino, poi San Tommaso d’Aquino, più tardi Kant, uno dei più importanti esponenti dell’illuminismo tedesco, tanto per citarne alcuni.
Nell’Illuminismo i vizi furono poi considerati non più come semplici «deviazioni dell’anima», ma come espressioni di determinate tipologie umane, poiché, al pari delle virtù, contribuirono allo sviluppo economico dell’uomo, perdendo in parte la loro connotazione morale).
Se gettiamo uno sguardo alla storia affiora alla mente un nome, quello dell’ultimo re di Roma (il settimo), Tarquinio il Superbo (e Dio solo sa cosa fece per meritarsi questo appellativo...).
Per la religione cristiana fu Lucifero il superbo per eccellenza, colui che non riconobbe la propria inferiorità nei confronti del suo Creatore.
Della superbia si potrebbe davvero parlare molto a lungo, lo si è fatto per secoli e succede anche oggi che se ne parli e se ne scriva in continuazione, quindi è inutile dilungarsi sulla questione (io non potrei aggiungere nulla di interessante).
Da persona comune, «non addetta ai lavori», osservo solo che chi è superbo se ne infischia del prossimo, non ha bisogno dell’adulazione di chi lo circonda, di instaurare delle relazioni per affermare il proprio valore, basta a se stesso ed è convinto di essere il migliore.
Non è capace di riconoscere i propri limiti. Chi è superbo spesso è arrogante, supponente.
Insomma, i superbi non piacciono a nessuno.
Non lo si confonda però con chi pecca di narcisismo, perché chi è narciso ha bisogno di continue conferme.
Ha bisogno degli altri. Tornando alla vanità, questa era riconducibile quindi alla superbia, ritenuta radice di tutti i mali.
Chi ha letto «Il ritratto di Dorian Gray» di Oscar Wilde non farà fatica a ricordare questa affermazione: «Ci sono peccati il cui fascino sta più nel ricordarli che nel compierli: strani trionfi che gratificano l’orgoglio più della passione e danno all’intelletto un intenso senso di gioia, maggiore della gioia che offrono, o possono offrire, ai sensi».
Se questa non si chiama vanità…
Daniela Larentis