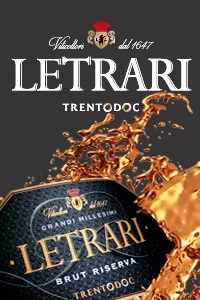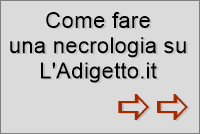Il testo e le immagini della «Lectio Degasperiana 2012»
La politica economica di De Gasperi nella ricostruzione dell’Europa – Di Vera e Stefano Zamagni

Nelle immagini (scattate da Adriano laner) vediamo in alto i professori Vera e Stefano Zamagni mentre pronunciano la loro «Lectio degasperiana», mentre in basso la foto del pubblico in cui spiccano il presidente della Camera dei Deputati Gianfranco fini e il presidente della Provincia autonoma di Trento Lorenzo Dellai.
Qui di seguito, dopo la foto, il testo degli interventi dei due relatori.

A ) Vera Zamagni
La politica economica di De Gasperi: le fondamenta del miracolo economico italiano
Nel descrivere molti anni fa il periodo dei governi di De Gasperi, che coincidono con quella che è stata definita “la ricostruzione”, usai l’espressione: “periodo fondazionale” per l’economia italiana. Non solo ne sono oggi sempre più convinta, ma aggiungerei che successivamente l’economia del nostro paese non ha avuto più occasioni di vero ripensamento e non è stata nemmeno in grado di estrarre da quelle fondazioni tutto il positivo in esse contenuto. Da qui due prime implicazioni: da un lato dovevano essere fondamenta “buone”, se hanno retto tanto a lungo, e dall’altro lato nessun governo ebbe in seguito il coraggio di progettare sul lungo periodo come allora si fece.
In realtà, ben poco possiamo rimproverare alla politica economica dei governi di De Gasperi, essendosi mossi “a tutto campo”. Il “miracolo economico” che ne seguì deve tutto a queste solide fondazioni: l’Italia fu in grado non solo di agganciarsi all’Europa, ma addirittura di essere protagonista del formidabile catching up della ripresa europea nei confronti degli Stati Uniti; si verificò un’enorme balzo produttivo, con una sorprendente capacità di allargare la  propria quota mondiale di esportazioni, in presenza di una stabilità del cambio che nemmeno paesi come Francia e GB furono capaci di mantenere: l’Italia dopo il 1949 non svalutò mai fino all’abbandono del gold standard.
propria quota mondiale di esportazioni, in presenza di una stabilità del cambio che nemmeno paesi come Francia e GB furono capaci di mantenere: l’Italia dopo il 1949 non svalutò mai fino all’abbandono del gold standard.
Il presente intervento è volto a sostanziare queste mie affermazioni iniziali. Dopo alcuni richiami generali sui contenuti delle politiche degasperiane, mi concentrerò su quattro aspetti che considero particolarmente significativi da un lato per mostrare tutta la lungimiranza di tali politiche e dall’altro lato per ricavarne qualche suggerimento per l’oggi. La politica economica generale dei governi degasperiani conobbe tre fasi, che esponiamo con le parole stesse del leader:
«Tre sono le fasi della nostra politica economica. La prima: lotta contro la fame e la paralisi nazionale. All’inizio il governo ha affrontata e vinta una lotta di emergenza … La seconda fase è stata la lotta per salvare la moneta e ottenere una certa stabilità dei prezzi. E’, quindi, quella fase dell’assestamento monetario e finanziario. Si è salvata la lira dalla svalutazione totale e si sono stabilizzati i prezzi costituendo le basi per lo sviluppo dell’attività produttiva … però non è vero che questa politica di stabilità monetaria sia stata una politica antiproduttivistica … La terza fase è quella in cui si cerca di dare all’economia uno sviluppo ampio e duraturo. Si tratta di ridurre i costi, di produrre su basi ampie ed economiche assicurando adeguati sviluppi alle esportazioni. Gli aspetti dell’azione in corso sono due: massima efficienza produttiva all’interno, cooperazione economica con gli altri paesi; … Tutto questo significa rifuggire dalle forme deleterie dell’autarchia, dare ai lavoratori una occupazione tranquilla e ridurre il costo della vita … E’ in questo quadro, con questa politica di aumento della produzione che noi specialmente vogliamo indirizzare ragionevolmente le riforme auspicate, e particolarmente, la riforma agraria, la riforma previdenziale, la riforma della scuola, la riforma tributaria … Nella linea di cui sopra furono particolarmente utili gli aiuti americani…».
Le linee generali della sua politica economica veniva sintetizzate da De Gasperi con efficacia e semplicità, perché i pensieri e le opere dello statista erano ben chiari nella sua mente, trasparenti e coerenti nel tempo. Vediamo ora brevemente i quattro temi di approfondimento.
1. L’industria.
Storicamente, l’Italia si era dibattuta in enormi difficoltà durante il suo decollo industriale per mettere in piedi un’industria di base sufficiente ad un paese di medie dimensioni, prevalentemente a causa di una sfortunata dotazione di materie prime. I successi erano stati fino ai tempi di De Gasperi assai parziali. Solo l’idroelettricità era stata un’avventura compiuta, ma i suoi limiti erano ormai evidenti, per carenza di ulteriori disponibilità di adeguati bacini idrici. Ebbene, questo annoso problema ricevette dai governi degasperiani risposte che si rivelarono in seguito lungimiranti:
a) energia. Due furono le direzioni prese. Da un lato, acquisizione della tecnologia americana per la termoelettricità da parte delle aziende private allora esistenti, particolarmente la Edison. Dall’altro lato, lancio di una vigorosa politica di sviluppo nel campo del metano e del petrolio attraverso l’ENI di Mattei.
b) metallurgia. Come è noto, il piano Sinigaglia era avversato dai metallurgici privati, che lo consideravano sproporzionato. Ma questo fu il piano adottato, che richiese in primo luogo un ampio ventaglio di negoziati internazionali attraverso la CECA, portati a termine con successo dalla diplomazia italiana dell’epoca. L’Italia passò da produttore marginale di acciaio a secondo produttore europeo . Partecipando alla CECA, si trovò naturalmente a diventare protagonista dei passi successivi di integrazione, di cui la CECA fu “instrumental”.
c) I due settori che erano emersi rafforzati dalle vicende del regime e della guerra furono la meccanica e la chimica. Si trattava di settori moderni, che erano sulla cresta dell’onda nelle esportazioni e che ricevettero dai governi di De Gasperi grandi supporti. Fu proprio pensando a questi due settori che si diede un forte impulso a siderurgia e a gas/petrolio. All’epoca della “linea Einaudi”, per aiutare il settore meccanico che abbisognava di grandi ristrutturazioni, venne messo in piedi il FIM, per finanziare appunto le ristrutturazioni. Dei fondi americani dedicati all’industria (Eximbank, ERP, FAS) 1947-54, il 26% andò alle industrie meccaniche, il 22% alle industrie metallurgiche, il 10% alle chimiche, il 15% alle elettriche (in totale 73%) . La costituzione nel 1948 della holding Finmeccanica da parte dell’IRI fu un altro passo cruciale, se si tiene conto che almeno 1/3 della meccanica italiana era finita nell’IRI . Si tratta di vere e proprie “politiche industriali”, da cui dipese in modo cruciale il futuro del paese.
2. La grande impresa.
La tecnologia su larga scala e i principi organizzativi delle imprese americane non erano ignoti agli imprenditori italiani, molti dei quali avevano fatto almeno un viaggio in America. Come scriveva giustamente Rosenstein Rodan: “they did not introduce it, because the size of the Italian market did not justify mass production. When the Italian economy grew into a sufficient size, the previously known methods were introduced”.
Il passaggio dalla produzione artigianale alla produzione di massa si verificò attraverso una “americanizzazione” delle imprese italiane, di cui il Piano Marshall fu ottimo strumento: non solo venivano acquistati i macchinari americani (spesso proprio con i fondi resi disponibili attraverso l’ERP), ma gli imprenditori e i tecnici italiani andavano negli USA per visitare gli impianti americani. Iniziò la diffusione dei principi organizzativi delle imprese americane, anche attraverso la creazione di nuove business schools .
Un’iniziativa speciale governativa fu quella della Commissione di indagini e studi sull’industria meccanica (CISIM), costituita con decreto ministeriale del 21 settembre 1950 e attiva nel 1951. Il 29 marzo di tale anno questa commissione firmò un contratto con lo Stanford Research Institute per l’avvio di un “gruppo di consulenza” sull’industria meccanica italiana, gruppo che arrivò in Italia il maggio successivo e redasse un nutrito rapporto entro il novembre 1951, dopo aver visitato 120 impianti e tenuto circa 150 incontri con esperti di varia provenienza.
È interessante notare che dei 13 membri del gruppo, solo 2 erano esperti di produzione, mentre gli altri erano esperti in contabilità aziendale, marketing, relazioni industriali e management. Dei 6 membri italiani del gruppo, invece, ben 4 erano ingegneri. Nella relazione finale, risultò che l’aspetto produttivo delle imprese era la loro parte migliore, mentre era totalmente assente il marketing, approssimativa la contabilità, quasi inesistente la ricerca applicata, insufficiente il disegno organizzativo generale dell’operatività aziendale. Stando così le cose, non ci si poteva meravigliare del fatto che: «caratteristica di molte aziende italiane [fosse] l’eccessiva fiducia nella capacità di soddisfare le specifiche richieste di prodotto improvvisando».
Come è ben noto, il modello aziendale americano è tutto l’opposto: pianificazione aziendale a lungo termine, basata su disegno di nuovi prodotti mediante la ricerca, ingegnerizzazione del processo attraverso accurato layout del macchinario in modo da eliminare tutti i tempi morti, accurata contabilità dei costi e analisi di mercato per il lancio di adeguate campagne di marketing. Ebbene, furono questi modelli di management “scientifico” a cui gli imprenditori italiani iniziarono ad ispirarsi, cercando di introdurli non solo nelle grandi imprese, ma anche in quelle medie .
In generale, si può dire che gli anni ’50 videro una buona crescita dimensionale ed innovativa delle imprese in Italia, che non continuò però oltre gli anni ’60. Molti infatti furono i soggetti che, per motivi assai diversi, ebbero una convergenza nel criticare pesantemente la grande impresa “privata”: le sinistre, per la loro dichiarata lotta ai cosiddetti “monopoli” (come venivano definite le grandi imprese private) e preferenza per le imprese di stato; i laico-radicali (Ernesto Rossi, Scalfari, Turani) per la loro idealizzazione di un mercato perfettamente concorrenziale; gli ambienti cattolico-sociali, per la loro preferenza per i “piccoli”.
Fu così che gran parte delle grandi imprese diventarono pubbliche, mentre i privati, salvo qualche eccezione, si organizzarono giocoforza preferibilmente sulla piccola-media dimensione, fino al capolavoro dei distretti. Sul lungo periodo, però, questa “persecuzione” della grande impresa privata, che non vide protagonista De Gasperi, si è rivelata deleteria, mentre quella pubblica ha subito i contraccolpi di una mal interpretata contiguità con la politica, che le ha imposto manager non sempre all’altezza e decisioni di investimento e di prezzo a volte del tutto scellerate. Ma sull’impresa pubblica conviene soffermarsi specificamente.
3. L’impresa pubblica
I governi degasperiani non ebbero una posizione pre-concetta contro l’impresa pubblica, peraltro sostenuti in ciò dalle numerose nazionalizzazioni che si verificavano in quegli anni sia in Francia, sia in Gran Bretagna. Avendo ereditato dal regime fascista una enorme holding industriale, l’IRI , la decisione fu presa di mantenerla in funzione, anche perché sembrava davvero difficile trovare investitori privati che volessero accollarsi i costi delle inevitabili ristrutturazioni che le centinaia di imprese dell’IRI richiedevano. In alcuni casi, erano già state create delle holding settoriali negli anni ’30 (Finsider e Telecom).
In altri casi, esse vennero create durante i governi degasperiani, come fu il caso già citato di Finmeccanica, con l’obiettivo di dare coerenza e strategie sinergiche alla miriade di imprese che erano state ereditate dall’IRI nel corso dei salvataggi (anche precedenti alla sua fondazione nel gennaio 1933) effettuati dallo Stato. Il compito affidato all’IRI fu soprattutto quello di investire nelle infrastrutture di base con piani poliennali finanziati in larga misura dalle banche d’investimento pubbliche, i cosiddetti ICM (Istituti di credito mobiliare), molti dei quali ereditati dagli anni precedenti (in sostanza, gli “Istituti Benedice”: Crediop, Icipu, Credito Navale, IMI, Efi), ma alcuni costituiti nell’immediato dopoguerra, fra cui soprattutto Mediobanca.
La lungimiranza che aveva spinto Beneduce a lasciare alle aziende IRI la forma giuridica della spa, ancorchè spesso di proprietà pubblica al 100%, venne sfruttata positivamente in termini di rapidità di decisione ed efficacia nel management. Un confronto fra le autostrade e le ferrovie è significativo: in mano all’IRI, le autostrade vennero rapidamente costruite, così che negli anni ’60 l’Italia si allineò ai livelli europei, mentre le ferrovie, nelle mani di un ente burocratico come le FFSS, subirono ritardi che scontiamo ancora oggi, nonostante i miglioramenti degli ultimi anni. La politica entrava solo in qualche decisione strategica e nella nomina dei vertici, i quali, tuttavia, condividevano generalmente la mentalità “sviluppista” dell’epoca. Fu solo in seguito che si diffusero gravi episodi di corruzione ma, soprattutto, l’uso “elettoralistico” delle imprese di Stato.
Un discorso a parte va fatto per l’ENI, creato nel1953 per riunire precedenti imprese attive nel settore del petrolio e del gas, che come è noto non fu un progetto degasperiano, ma venne da De Gasperi abbracciato con convinzione perché affrontava uno dei problemi più gravi per l’Italia (la disponibilità di energia) e aveva risvolti significativi nell’attivare attività economica nel Sud Italia.
Avere oggi un’impresa come l’ENI, che è una delle più grandi imprese a livello internazionale e ci presidia un settore ancor oggi strategico per il paese, è certamente dovuto alla mente brillante di Enrico Mattei, ma anche all’intuito degasperiano che era un cavallo giusto su cui puntare.
4. Le riforme
Non c’è il tempo qui per passare in rassegna le molte riforme dell’epoca degasperiana. Le più incisive riguardarono di certo il Mezzogiorno, nei confronti del quale si approvò la riforma agraria, ma anche venne varata un’agenzia di sviluppo, sulla base delle elaborazioni della SVIMEZ. Di questo argomento mi occupai con Mario Sanfilippo alla fine degli anni ’80 nell’introduzione ad un volume che descriveva le attività della Svimez delle origini . E’ noto che considerazioni di urgenza fecero inizialmente applicare l’Agenzia che venne creata nel 1951 (la Casmez) all’agricoltura, ma in seguito la vocazione industrialista dell’intervento venne recuperata, anche se purtroppo con un intreccio che non si rivelò del tutto positivo tra industria di base e impresa di Stato (le famose “cattedrali nel deserto). Dove questo non avvenne, come negli Abruzzi e in Molise, i risultati furono più positivi . In generale, va notato che il periodo del miracolo economico fu l’unico in cui il divario economico Nord-Sud accennò a chiudersi con un approccio basato sull’aumento della produzione (agricola e industriale) e non sull’assistenzialismo.
Mi avvio a qualche conclusione, che desidero introdurre con le parole stesse di De Gasperi, pronunciate in quello che a tutti gli effetti può essere considerato il suo testamento politico:
«A partire dal 1947 fu preoccupazione fondamentale del governo quella di delineare e porre in atto un programma organico, [intraprendendo] un organico sviluppo ed ammodernamento dei principali settori economici …[segue l’elenco delle iniziative portate avanti]… E’ vero che il mondo economico si possa spaccare in due grandi campi nettamente antitetici: quello del sistema capitalista e quello del collettivismo comunista? … Vi sono oggidì nel mondo vari modi di intendere e di applicare il sistema capitalista. Il capitalismo americano è diverso da quello europeo; il capitalismo inglese è differente da quello continentale; il capitalismo descritto dai classici dell’economia e confutato da Marx è in parte superato nei fatti e negli ordinamenti a causa dell’intervento dello Stato democratico, della pressione sindacale, della trasformazione organizzativa e meccanica dell’azienda, della crescente diffusione del credito … Sarà dunque più esatto dire che anche nel campo economico ci si trova in un periodo di evoluzione verso un tipo misto che esclude le rigidità degli estremi dottrinali e segue nelle strutture e negli ordinamenti, per quanto in ritardo, le trasformazioni del regime democratico.»
La tentazione del fondamentalismo, di Stato o di mercato, è sempre presente nel dibattito sulla politica economica, perché rappresenta una soluzione semplice da pensare e facile da inserire in progetti di egemonia politica ed economica. Lavorare invece con tutti i mezzi disponibili (impresa capitalistica, impresa cooperativa, impresa pubblica, impresa non profit) per il maggior benessere di tutti richiede una più ampia disponibilità alla rottura di schemi pre-formati e alla ricerca di un equilibrio virtuoso fra le diversità.
Ma, soprattutto, richiede che la politica sia pronta a scommettere su un senso (ossia direzione) da imprimere agli interventi e non solo a varare neutrali regole del gioco, che, guarda caso, proprio neutrali non risultano mai, perché con quelle regole le disuguaglianze economiche e sociali non fanno che crescere.
B) Stefano Zamagni
Il messaggio del disegno politico-economico di De Gasperi
Accolgo, convinto, l’invito di Giuseppe Tognon quando, nell’introduzione alle Lezioni degasperiane 2004-2009, scrive: «Ciò di cui si sente la mancanza è una lettura più libera e profonda della figura di De Gasperi, che sappia aprire nuove piste interpretative e soprattutto che liberi la sua figura da quel paludamento retorico in cui è tipico isolare le grandi personalità, soprattutto politiche».
È quel che cercherò di fare in quanto segue. E’ quanto meno strano che la storiografia su De Gasperi si sia soffermata più sui temi di politica interna ed estera che non su quelli di politica economica. (Proprio il contrario di quanto è accaduto ad un’altra grande figura di statista, quella di K. Adenauer).
Eppure, il pensiero e l’opera di De Gasperi in ambito economico non meritano l’oblio, perché hanno ancora tanto da dirci per l’oggi. Su tre questioni specifiche, ma di ampio spessore, desidero qui fissare l’attenzione. Prima, però, un’avvertenza. È  certamente riduttivo e perfino rischioso separare le diverse dimensioni del contributo di un personaggio della statura di De Gasperi. Ma ovvie ragioni di spazio non consentono di fare diversamente.
certamente riduttivo e perfino rischioso separare le diverse dimensioni del contributo di un personaggio della statura di De Gasperi. Ma ovvie ragioni di spazio non consentono di fare diversamente.
Una prima questione può essere posta nei seguenti termini: perché lo statista trentino, che pure conosceva bene e giudicava positivamente l’economia sociale di mercato (ESM) tedesca, non ritenne di tentarne un’applicazione al caso italiano? Prima di rispondere, conviene richiamare, in breve, le caratteristiche essenziali dell’ESM, espressione per primo coniata da Alfred Müller-Armack.
Per Eucken, uno dei pensatori che forgiarono il quadro concettuale dell’ESM, il sistema economico va guidato a partire da “principi formativi” – che definiscono la natura e l’essenza dell’economia di mercato – e da “principi regolativi” – che ne fissano i modi di funzionamento. Nei primi sono inclusi il primato della politica monetaria, che deve assicurare la stabilità del valore della moneta, l’apertura dei mercati alla libera concorrenza, la tutela dei diritti di proprietà, la libertà d’impresa, la continuatività dell’azione di politica economica da parte dello Stato.
I principi regolativi riguardano invece la lotta contro i monopoli naturali, la politica dei redditi allo scopo di assicurare un’equa distribuzione delle risorse; l’intervento statale volto a correggere per mezzo di un sistema di tasse e sussidi le varie esternalità negative; l’intervento governativo in tema di lavoro, che non può essere lasciato ai dettami delle leggi di mercato.
Sulla medesima linea si muove W. Röpke, quando invoca un “forte Stato” capace di garantire la sicurezza e «l’intelligente polizia dei mercati» (sic!), dato che questi non sono in grado di autogovernarsi, né di autocorregersi.
Ebbene, conoscendo in profondità la realtà del paese e quanto era accaduto durante la tragica esperienza del fascismo, De Gasperi aveva abbondanti ragioni di ritenere che la proposta del modello dell’ESM sarebbe stata presa a significare una riedizione dell’ordine sociale corporativista, tanto ampio e invasivo è il ruolo affidato dall’ESM allo Stato. (Giova ricordare che tale modello venne fatto proprio dalla CDU – Cristiano Democratici – nel 1949 e poi viene adottato dalla SPD – Socialdemocratici – nel 1959).
Per un verso, la Confindustria non voleva sentir parlare di cogestione, di monitoraggio dei comportamenti, di scambio di informazioni tra gli attori economici, elementi questi costitutivi dell’ESM. (Anche Pasquale Saraceno non vedeva di buon occhio il partecipazionismo operaio).
Per l’altro verso, i tre principali partiti dell’epoca non nascondevano la loro diffidenza nei confronti dell’impresa privata: PCI e PSI per ragioni ideologiche; la sinistra DC perché il capitalismo veniva percepito come contrario alla Dottrina Sociale della Chiesa. Al tempo stesso, De Gasperi non poteva certo spendersi – e pour cause – per il modello di economia liberale di mercato di tipo anglosassone.
Come è noto, la chiave della distinzione tra i due modelli è nella diversa modalità con cui gli imprenditori si coordinano fra loro per controllare la dinamica salariale, per incoraggiare l’innovazione e per favorire l’aggiustamento alle mutate condizioni di mercato.
Di qui quello che è stato chiamato – a mio giudizio impropriamente – il compromesso degasperiano, e cioè l’economia mista di mercato: nella sfera privata si accolgono i principi liberali; nella sfera pubblica si applica la nozione di Stato limitato. Quest’ultimo è uno Stato né minimo (come volevano i liberali), né interventista su tutti i fronti (come volevano gli statalisti); ma uno Stato che può essere anche forte purché si mantenga entro limiti ben definiti.
Quello limitato è dunque uno Stato abilitante che promuove e incoraggia tutte quelle forme di azione collettiva che generano effetti pubblici attraverso la promozione di assetti istituzionali che facilitano la “fioritura” dei corpi intermedi della società (Art. 2 della Costituzione).
Nell’ESM non v’è spazio né per il principio di sussidiarietà né per il principio di fraternità, ma solo per il principio di solidarietà. Ciò non sorprenderà se si considera che l’impianto filosofico dell’ESM è il deontologismo kantiano, mentre la bussola di De Gasperi fu piuttosto il personalismo di Mounier, Maritain, Sturzo, Toniolo.
La sintesi mirabile fra solidarismo cristiano e libero mercato è il vero capolavoro del Nostro, pari, per importanza, al capolavoro di Parigi del febbraio 1947 nella circostanza del Trattato di pace, quando De Gasperi riuscì a far accogliere l’Italia nel novero delle democrazie occidentali.
Mantenendo le due sfere in equilibrio dinamico, De Gasperi ha dimostrato di saper fare tesoro delle complementarità istituzionali. (Due istituzioni si definiscono complementari se la presenza dell’una accresce il rendimento dell’altra: è in ciò il segreto del nostro “miracolo economico”).
È anche per questa sua proverbiale capacità mediatoria – conseguenza del prolungato esercizio della virtù della pazienza – che De Gasperi veniva considerato punto di riferimento anche dagli altri interlocutori della classe politica del tempo (Bonomi, Croce, Sforza, La Malfa, Amendola, etc.).
La seconda questione concerne il modo in cui De Gasperi interpreta i principi della Dottrina Sociale della Chiesa con specifico riguardo al tema della giustizia sociale. Quest’ultima viene vista come un meccanismo di correzione e di compensazione dei risultati di mercato, come vuole il liberalismo di marca anglosassone, e non come un insieme di regole e provvedimenti che valgano a far funzionare in modo più equo il mercato.
La società giusta, per De Gasperi, non è solamente quella che garantisce l’equità intesa come eguagliamento dei punti di partenza, ma anche quella che assicura un certo grado di uguaglianza dei punti di arrivo del gioco di mercato. E ciò per la fondamentale ragione che la democrazia che mira al bene comune non può tollerare di assistere passivamente all’aumento sistemico delle diseguaglianze.
Di qui la lotta dello statista trentino contro i monopoli (privati), il latifondo, le varie forme di rendita parassitaria. Nel Programma della DC del 1943, predisposto dal Nostro, si legge:
«La giustizia vuole l’eliminazione delle eccessive concentrazioni di ricchezza, l’eliminazione del feudalesimo [sic!] finanziario, industriale, agricolo che ostacolano la piccola proprietà» (p. 28).
L’argomento, in breve, è che, come la democrazia politica è la difesa del cittadino dall’invadenza dello Stato dirigista, così la democrazia economica è la libertà del salariato dal potere del capitalista. E come “Pio XI rivendicò lo spazio vitale della persona rispetto allo Stato”, del pari la politica economica deve rivendicare lo spazio vitale del produttore rispetto al proprietario (p. 43).
Si trattava dunque di battere le numerose élite che cercavano il controllo del potere economico per esaltare la loro avidità. Disoccupazione strutturale e povertà estrema furono sin da subito i principali cavalli di battaglia di De Gasperi, il quale aveva ben compreso che sono i vested interests, gli interessi costituiti quando danno vita a forti coalizioni distributive a rappresentare la più grave minaccia alla crescita.
Il grande merito del Nostro fu quello di essere riuscito a far sì che le coalizioni distributive non prevalessero su quelle produttive. Come? Applicando la democrazia effettiva per contrastare le politiche (fiscali, finanziarie, industriali) di conquista del potere.
Per De Gasperi, la democrazia è effettiva quando riesce ad impedire che le diseguaglianze sociali si trasformino in diseguaglianze di potere politico. Ecco perché la libertà economica è fondamentale, perché consente a tutti di beneficiare delle condizioni per lo sviluppo delle proprie capacità. Il riferimento al principio di sussidiarietà – di cui Pio XI (1931) aveva fornito la definizione canonica nella Quadragesimo Anno – è al riguardo esplicito.
Infine, non si può non fare parola della straordinaria intuizione di De Gasperi a proposito della distinzione tra istituzioni economiche estrattive e inclusive: le prime sono quelle che concentrano ricchezze e poteri nelle mani di pochi; le seconde tendono a ridistribuire il potere, a realizzare cioè la poliarchia. Sono infatti le istituzioni economiche a promuovere lo sviluppo assai più e meglio delle condizioni geografiche e delle stesse matrici culturali.
Ma le istituzioni, in quanto regole del gioco, nascono dalla politica. Dunque senza un mutamento politico adeguato, a poco serve cercare di applicare ricette o modelli che pure hanno dato buona prova di sé in altri contesti.
Una sola citazione del Nostro. Il 9 agosto 1951 alla presentazione del 7° governo De Gasperi, questi afferma, in esplicita risposta ai sostenitori di sinistra della linea keynesiana (si pensi al Piano del lavoro della Cgil del 1949 e a documenti come quello di Giorgio La Pira dell’aprile 1950, L’attesa della povera gente): «La teoria della massa consumatrice è difficile da applicare dove la materia prima bisogna importarla»! Se si vuole crescita con sviluppo – e non solo crescita – occorre allora puntare ad istituzioni economiche inclusive. Quelle estrattive possono, al più, assicurare crescita, ma di corto respiro.
Ecco perché De Gasperi si batté con decisione contro quel modo di fare politica oggi indicato con l’espressione di private politics, la politica, cioè, di rappresentanze extra-parlamentari che esercitano pressione su organi dello Stato, disintermediando così la politica democratica.
Facendo propria la nozione di Johannes Althusius di democrazia come consociatio symbiotica, De Gasperi nei suoi innumerevoli discorsi non perde occasione per ricordare che l’uomo non è una monade e che la società non è un aggregato di identità separate. Ebbene, il centrismo degasperiano da tanti criticato trova qui il suo fondamento di filosofia politica: ci vuole una simbiosi per realizzare la convivenza sociale e l’amicizia politica.
Un esempio per tutti: è noto l’atteggiamento di De Gasperi nei confronti del comunismo; ma mai volle assumere l’anticomunismo come posizione aggregante per il suo partito. De Gasperi si battè sempre, con decisione, a favore dalla public politics.
Ritengo si possa ragionevolmente sostenere che De Gasperi ha anticipato quello che trenta anni dopo sarà chiamato il paradosso di Böckenförde, secondo cui lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che esso non può garantire. Il cuore del paradosso sta in ciò che lo Stato liberale può esistere solo se la libertà, che esso promette ai suoi cittadini, è inscritta nella costituzione morale dei singoli e in strutture sociali tese al bene comune.
Se invece lo Stato liberale tenta lui stesso di assicurare tale presupposto, avvalendosi del suo potere di coercizione, esso rinuncia alla sua cifra, finendo col ricadere in quella stessa istanza di totalità da cui afferma di emanciparsi. De Gasperi dimostra di afferrare appieno ante litteram il senso di tale paradosso quando osserva che il mercato postula l’eguaglianza tra tutti coloro che vi prendono parte, ma al tempo stesso genera ex-post disuguaglianze di risultati.
E quando l’eguaglianza nell’essere diverge troppo e troppo a lungo dall’eguaglianza nell’avere, il mercato produce effetti perversi. Ecco perché la sfera economica ha bisogno della guida politica, proprio per conservare la sua autonomia.
Alla luce di quanto sopra, si possono capire le incomprensioni, le critiche e le accuse, spesso ingenerose, avanzate anche da taluni settori della DC, nei confronti del disegno degasperiano di politica economica. Il fatto è che De Gasperi, al pari di chi è parte di minoranze profetiche, pensa e si esprime in anticipo sui tempi. Ecco perché i contemporanei del celebre trentino non hanno saputo far di meglio che occuparsi del gioco sterile della catalogazione e della attribuzione di appartenenza.
Non si è voluto – ed in parte ancor oggi non si vuole – riconoscere l’originalità di un pensiero che aveva bensì radici profonde, ma che per la sua novità spingeva più avanti la frontiera delle conoscenze e dei modi di intervento. Si pensi alle fatiche che il Nostro incontra nella mediazione tra la linea Sturzo-Pella e quella della Comunità del Porcellino (Dossetti, La Pira, Fanfani, Lazzati).
Penso, in particolare, al dibattito spesso aspro a proposito dell’art. 41 della Costituzione. Il contrasto che oppose Dossetti a De Gasperi riguardò la formulazione del comma 3 dell’art. 41, che alla fine risultò così:
«La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica, pubblica e privata, possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali» (corsivo aggiunto). Non ci vuole molto a capire come a De Gasperi una tale formulazione non potesse andare a genio. Ciò soprattutto dopo la dichiarazione di Dossetti del 3 ottobre 1946 alla Commissione per la Costituzione:
«Il dilemma che si pone ha due sole alternative… e cioè che la vita economica si debba svolgere spontaneamente, ritornando al sistema fondamentale dell’ottimismo liberale. Ora, l’esperienza storica insegna che il lasciare il libero gioco alle forze naturali e economiche porta ad una sopraffazione.»
Si pensi, anche, all’accusa di austriacentrismo nell’occasione del patto De Gasperi- Gruber sull’Alto Adige; e da ultimo, la svolta che si consuma a fine 1953 quando nasce, sulle ceneri del dossettismo, la corrente “Iniziativa Democratica” (Rumor, Taviani, Galloni, Moro, Fanfani) che porrà definitivamente in ombra l’esperienza della prima fase della DC, portando quest’ultima su una linea di avanzato statalismo. Può essere di interesse ricordare che Togliatti nel discorso del 10 febbraio 1950 alla Camera definì reazionario questo programma che prevedeva un forte intervento dello Stato:
«Quanto alle cosiddette sinistre democristiane, la riserva deve essere forte e per quel che riguarda gli uomini e per quel che riguarda le idee, che fanno di questo gruppo uno dei più reazionari fautori di una sorta di corporativismo feudale.»
Con un commuovente e generoso intervento, De Gasperi cercò fino all’ultimo di trovare una mediazione, come si trae dal suo ultimo discorso pubblico del 27 giugno 1954, meno di due mesi prima della sua dipartita.
«Anche per la scuola cristiano-sociale mi pare che le conclusioni della contemporanea esperienza si possano formulare così: né capitalismo, né comunismo ma solidarismo di popolo in cui lavoro e capitale si associno, con crescente prevalenza del lavoro sotto il controllo, e ove occorra con la propulsione, dello Stato democratico… Si tratta di una linea mediana, di un incontro tra due esigenze e due interessi.»
(Una linea, questa, che verrà poi ripresa al n. 172 del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa).
Vado a chiudere.
«Hanno spine le rose, fango gli argentei rivi» (W. Shakespeare, Sonetto 35). Ritengo che queste parole bene sintetizzino la vicenda umana di De Gasperi.
Tutte le grandi idee vanno soggette all’ eterogenesi dei fini e tutti i grandi uomini cadono vittime di incomprensioni e travisamenti. Sappiamo che senza memoria il pensiero non può volare alto, perché la memoria è la permanenza del passato capace di orientarci.
Non è vero che il pensiero si muove più liberamente nel vuoto. Senza memoria, il pensiero tende a riprodurre acriticamente errori, come quelli di chi, sebbene in buona fede, pur di veder avanzare il proprio particolare punto di vista – non dico interesse – è disposto a mettere a repentaglio il bene comune della civitas.
Viene alla mente, a tale proposito, l’aforisma di David Hume: «Piuttosto che farmi male all’unghia del mignolo, perisca il mondo intero».
A ciò conducono i tanti personalismi e gli egoismi di gruppo – fenomeni questi che hanno tristemente connotato di sé l’esperienza politica dei cattolici italiani dal dopoguerra ai giorni nostri.
Ravvivare oggi la memoria di De Gasperi è allora operazione tutt’altro che oziosa o retorica.