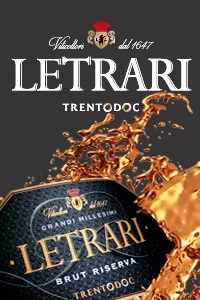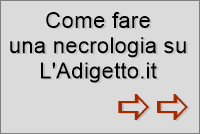Sopravvivere al Vajont – Di Maurizio Panizza
La triste storia di Rinaldo Aste, un carabiniere trentino che il 9 ottobre del 1963 era in servizio a Longarone: perse la moglie e i due bambini

>
A Sant’Anna, nell’unico bar della minuscola frazione di Vallarsa, Guerrino Aste stava aspettando da un quarto d’ora la telefonata del figlio Rinaldo.
Negli anni del primo dopoguerra i telefoni erano una rarità in Trentino e per questo i bar dei piccoli paesi fungevano da «posto telefonico pubblico».
Chi doveva parlare con un amico o un parente, chiamava il bar e il gestore andava poi ad avvisare il destinatario che qualcuno lo cercava e che di lì a poco sarebbe arrivata una  telefonata per lui.
telefonata per lui.
Il giovane Rinaldo era giunto alla fine del periodo di leva e adesso era sua intenzione lasciare l’Arma per ritornare al suo paesello. E questo, appunto, era il motivo della sua telefonata.
«Ma che razza di idee ti vengono in mente? – rispose nervoso il padre, dopo avere ascoltato alla cornetta non più di tre-quattro parole. – Non lo sai che qui in Vallarsa non c’è lavoro per nessuno? Ah, vuoi lasciare i carabinieri? Bene, allora torna pure in paese e avrai due sole alternative: andare al pascolo con le capre, oppure rifare la valigia e partire per le miniere del Belgio o della Francia. Vedi tu, cosa è meglio per il tuo futuro.»
Rinaldo, sopraffatto dalla disapprovazione del padre, era rimasto senza parole. Certo, il modo era stato piuttosto brusco, ma le argomentazioni del vecchio sembravano un reale dato di fatto per chi si fosse messo in cerca di un lavoro in quei tristi anni del dopoguerra.
A pensarci bene, lasciare un’occupazione sicura, pure discretamente retribuita, per andare a scavare carbone a mille metri sotto terra, non pareva adesso neppure a lui un’idea da prendere in seria considerazione. Così, Rinaldo, ritornò sui suoi passi e rimase nell’Arma, inconsapevole, allora, che quella scelta gli avrebbe cambiato completamente la vita.

Quant'era bella Longarone...
Passati più di dieci anni da quella conversazione, dopo diversi cambi di sede l’appuntato Rinaldo Aste era giunto nella valle del Piave. Si stava bene lì, a Longarone, un paese noto in quegli anni per via della sua diga costruita da poco, un capolavoro della tecnica dicevano, una delle più grandi d’Europa. Un posto tranquillo a 18 chilometri da Belluno, un posto dove portare anche la famiglia. Difatti, assieme alla moglie Pia e al piccolo Graziano di due anni, Rinaldo aveva preso affitto in via Marconi, nella parte alta del paese. E lì, in quel piccolo, ma grazioso appartamento, nel febbraio del 1963 era poi nato anche il secondogenito, Stefano.
Il 9 ottobre di quello stesso anno, accadde l’imponderabile. Quella sera si giocava la finale di Coppa dei Campioni tra il Real Madrid e il Glasgow Rangers e nei paesini veneti della valle del Vajont i pochi appassionati che possedevano il televisione guardavano la partita in casa, gli altri, invece, gremivano le piccole sale dei bar della zona.
Erano passate da poco le 20.00 e a casa Aste i bimbi dormivano già. Mamma Pia era  occupata a riassettare la cucina. Papà Rinaldo era in pigiama e, stanco per la giornata, stava già per mettersi a letto. Qualche avvisaglia di ciò che sarebbe poi successo, per la verità c’era stata.
occupata a riassettare la cucina. Papà Rinaldo era in pigiama e, stanco per la giornata, stava già per mettersi a letto. Qualche avvisaglia di ciò che sarebbe poi successo, per la verità c’era stata.
La diga del Vajont poco prima del crollo del monte Toc (sulla destra).
Ripetuti allarmi da giorni arrivavano alla stazione dei carabinieri: era necessario scongiurare un grave pericolo che incombeva sulla diga del Vajont, che si trovava proprio lì, in faccia a Longarone. Già da parecchio tempo - si può dire sin dall’inizio dell’invaso, nel 1960 - tutti gli abitanti della valle avevano avuto sentore che il monte Toc era diventato instabile al punto che ormai veniva chiamato da molti la montagna che cammina.
Dal versante di sinistra del bacino, infatti, frammenti sempre più grossi di montagna scivolavano nel lago. Le infiltrazioni d’acqua avevano messo a nudo una montagna dai piedi d’argilla, instabile e molto pericolosa: spesso la terra tremava, nel terreno si aprivano fenditure e le porte delle vecchie case non riuscivano più a chiudersi. L'Enel, titolare della diga e dell’impianto idroelettrico, per mesi aveva minimizzato il pericolo, nascosto e alterato le perizie geologiche: evidentemente il business dell’energia era talmente ghiotto da poter mettere a rischio pure la vita di quei «poveri montanari»
Alla fine, i dirigenti dell’azienda, non potendo più prendere tempo, inviarono un telegramma il giorno precedente la tragedia, ma ormai era troppo tardi.

Il telegramma giunto al Sindaco di Erto, comune confinante con il bacino del Vajont, il giorno prima del disastro.
Quella sera il campanello di casa Aste suonò concitato per alcune volte: era il carabiniere Francesco D’Arrico che portava l’ordine del comandante la stazione di Longarone di raggiungere al più presto la strada per le frazioni di Dogna e di Provagna e di chiuderla alla circolazione.
Pur avendo finito il suo turno di lavoro alle 18.00, gli ordini non si potevano discutere per cui Rinaldo si rimise in fretta la divisa. Alla moglie che lo pregava di fermarsi giusto il tempo per prendere un caffè, l’uomo rispose solo con un cenno del capo e con un sorriso che voleva essere rassicurante. Poi le diede un bacio e uscì di casa dicendole che sarebbe tornato presto.
Quelle sarebbero state le ultime parole fra loro.
Prima delle 21.00 la strada era stata bloccata, ma alla gente dei paesi non venne dato alcun avviso di evacuazione semplicemente perché non esisteva nessun ordine in tal senso.
Un’ora dopo, esattamente alle 22.39, all’improvviso un cupo e lungo boato spezzò il silenzio in cui era avvolta la valle. Un’enorme frana staccatasi dal pendio che occupava da millenni, scese rapidissima verso il lago artificiale, creando un’ondata gigantesca. In pochi attimi la tragedia: l’onda d’acqua e fango, alta più di 200 metri, oltrepassò la diga - che resistette all’urto - piombando sulla valle, distesa lungo il Piave, come a straziarne il corpo e l’anima.

Mattina del 10 ottobre 1963: nella valle del Piave i superstiti si aggirano tra le macerie.
Rinaldo Aste, che assieme al collega stava quasi sotto la diga, per prima cosa vide un grande bagliore che illuminò la notte per alcuni secondi, causa i tralicci da 220 mila volt spazzati via come fuscelli. Poi dalla diga scese un vento fortissimo e iniziarono a piovere pietre e alberi che costrinsero i due carabinieri a correre per cercare riparo. Infine arrivò l’onda terribile, tragica, incontenibile che passò sopra di loro, miracolosamente.
I due carabinieri videro solo la loro camionetta trascinata via dalla marea scura, mentre giù lungo la valle, nel giro di un minuto, venivano travolte e sepolte quasi 2.000 persone. Ma i due carabinieri dal punto in cui si trovavano non potevano vedere nulla, non potevano sapere, perché dopo l’acqua fu il buio più nero a calare su Longarone.
Rimasero lì fino all’alba per paura dei fili dell’alta tensione e di altre frane, poi scesero verso il paese, o meglio verso quello che ne rimaneva
| La «vendetta» del Vajont Dieci anni erano durati i lavori per la costruzione della diga del Vajont. Chi l’aveva finanziata voleva indurre l’avara montagna ad essere dispensatrice di alti profitti per gli investitori. Ma poi, per avidità e imperizia, con silenzi e menzogne costoro avevano iniziato a coprire gravi responsabilità e pericoli enormi per la popolazione. La diga, in sostanza, era stata costruita nel posto sbagliato e così la montagna alla fine si era presa un’atroce vendetta. In pochi minuti un’enorme massa d’acqua aveva tolto la vita a 1917 persone, fra cui 487 bambini, il 95 per cento della popolazione di Longarone e dei paesi vicini. Solo poche case nelle zone più alte vennero miracolosamente risparmiate dal cataclisma. E su quelle porte i superstiti, inebetiti dal dolore, non sapevano più se benedire o maledire la loro salvezza. |
Durante la notte, intanto, la notizia del disastro aveva fatto il giro del mondo. E in quell'alba livida del 10 ottobre 1963, il Messaggero Veneto era appena uscito in edizione straordinaria con un titolo sbagliato: «Sfondata la diga del Vajont da una valanga di fango e acqua».
Ma la diga non era caduta, aveva fatto sino in fondo il suo dovere resistendo a quell’immane forza distruttiva. Era caduta, invece, la fiducia negli uomini delle istituzioni e forse anche quella in Dio per quell’atroce sciagura annunciata.
I giornalisti del Messaggero Veneto furono i primi ad arrivare in valle e a comunicare all’Italia quanto era successo: «La strada per Longarone era bloccata da una fiumana di detriti. Lasciammo l'auto e proseguimmo a piedi o approfittando di qualche passaggio su mezzi di soccorso.
«Arrivammo a Longarone che era ancora buio, carabinieri e genieri avanzavano con le fotoelettriche. Trovammo un deserto di ghiaia: la cittadina era stata spazzata via, restava  solo una striscia di case nella parte alta.»
solo una striscia di case nella parte alta.»
Poi la cronaca prosegue: «Poche persone, sfuggite al disastro, si aggiravano mute fra le macerie, lo sguardo lontano, quasi inconsce, quasi come personaggi senza volto che il destino avesse lasciato lì, in mezzo al fango, ai sassi, all’acqua».
E l’inviato del giornale L’Adige scriveva: «Un capitano dell’esercito ci ha raccontato questo episodio: accorso per estrarre dal fango alcune persone rimaste uccise all’interno della loro casa, mi sono imbattuto in un appuntato dei carabinieri e l’ho invitato a seguirmi perché eventualmente potesse identificare i cadaveri.
«L’appuntato mi ha risposto: “So già chi essi sono: mia moglie e i miei due bambini” e senza profferire parola il povero uomo si è staccato allontanandosi da quella che era stata la sua casa nella quale aveva trascorso ore felici.»
Quell’appuntato era Rinaldo Aste, ma i cadaveri non erano dei suoi famigliari. Quelli, purtroppo, non sarebbero mai più stati ritrovati. Infatti, dopo essere sceso a valle col cuore in gola, Rinaldo era corso affannosamente in paese, verso la sua casa dove la sera prima aveva lasciato la moglie e i due figlioletti. Ma lì non c’era più nulla: era rimasta solo un’enorme, indistinta spianata di fango e ghiaia. Come in un incubo, l’uomo iniziò allora a girovagare, disperato e stordito sulle macerie del paese. Lo fece per alcune ore, poi sfinito dal dolore si accasciò a terra, venne quindi soccorso e portato in ospedale.
Per alcuni giorni fu ospitato in casa di parenti a Rovereto, per riprendersi dallo scock. Poi volle ritornare a Longarone a cercare ancora nel fango almeno un corpo su cui piangere. E nel vagare a fianco di altri superstiti venne riconosciuto e accusato da quei compaesani di avere saputo e taciuto. Ma come avrebbe potuto mantenere in quel posto la sua famiglia se mai avesse saputo del pericolo che incombeva su di loro?  «Io ho eseguito solo gli ordini, – rispose a chi voleva chiamarlo in causa. – Guardatemi, sono un povero disgraziato come voi, rimasto solo, maledettamente solo.»
«Io ho eseguito solo gli ordini, – rispose a chi voleva chiamarlo in causa. – Guardatemi, sono un povero disgraziato come voi, rimasto solo, maledettamente solo.»
Rinaldo Aste impiegò diversi anni per riuscire a dormire la notte: infatti l’incubo di quell’immane tragedia lo accompagnò per molto tempo, né riuscì mai a cancellarlo del tutto.
Nei mesi successivi l’Arma dei Carabinieri lo trasferì in Trentino, dove in seguito conobbe Mercede, una gentile signora che anni dopo sarebbe diventata la sua seconda moglie. Più avanti nacque anche un figlio che venne chiamato Stefano, come il secondogenito perito nella tragedia a soli otto mesi.
Rinaldo aveva così ricevuto dal destino una seconda possibilità, ma aveva anche dovuto imparare a convivere con la disperazione, la rabbia e la paura. Del suo dramma non ne parlava mai volentieri perché è la gioia che si deve condividere non tanto il dolore. Tuttavia aveva avuto il coraggio di iniziare una seconda vita, anche se i lucidi fatti di quella notte, i visi e l’amore di Pia e dei loro due bambini non sarebbero mai più scomparsi dalla sua memoria. Vivere con il cuore nei ricordi belli e tentare, per quanto possibile, di rimuovere con la mente la tragedia del 9 ottobre 1963 fu per lui un duro esercizio di vita. E la nuova famiglia lo aiutò molto in questo.
Rinaldo Aste morì a 81 anni, nel 2005 a Mori, dove tempo prima si era trasferito. Fra i pochi sopravvissuti del Vajont aveva trovato un nuovo futuro grazie ad una vita intensa, fatta di lavoro e di affetti.
Nel 1985 la sorte lo aveva costretto nuovamente a rivivere - con altrettanta rabbia e sbigottimento - un altro analogo dramma: quello del disastro di Stava, stavolta accaduto nel suo amato Trentino. Anche in quel caso, dove morirono 268 persone innocenti, furono interessi economici e irresponsabilità umana a causare il crollo di un bacino e a spazzare via case e persone.
Rinaldo lo sapeva bene che quella era una storia molto simile alla sua. Un’altra storia di avidità e criminale leggerezza che pur nel dolore non doveva essere dimenticata, ma rimanere come monito a insegnamento per le future generazioni.
 Maurizio Panizza
Maurizio Panizza
© Il Cronista della Storia
[email protected]
Si ringraziano Stefano Aste e Mercede Marocchi Aste per la loro preziosa testimonianza.
© Copyright - Maurizio Panizza 2016. Tutti i diritti riservati. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, del testo e/o delle fotografie originali sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta.