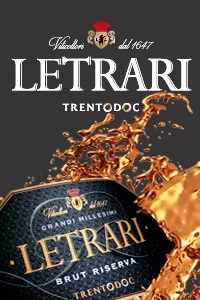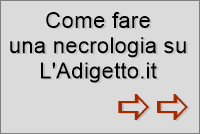Da una foto una storia/ 11 – Di Maurizio Panizza
«Il mio nome è Benito Albino» – Il passaggio dal Trentino dello sfortunato figlio del Duce, il suo rapimento, il manicomio, la condanna a morte

Testi e immagini © Maurizio Panizza, cronista della Storia - Nella foto: Arnaldo e Benito.
 Ci sono immagini che nascondono segreti. Ci sono immagini che nascondono segreti.Saperle osservare senza pregiudizio, collegare più elementi, interpretare il contesto, consultare altre fonti, può diventare un’operazione molto interessante. Un’operazione che a volte può rivelare sorprese inaspettate. |
Chissà se nei giardini di qualche scuola italiana ci saranno ancora delle grandi querce a fare ombra ai cortili d’estate. Chissà. Se fosse realmente così, se cioè qualche albero si fosse salvato dal tempo e dagli uomini, è possibile - anzi probabile - che quelle antiche piante siano le stesse messe a dimora il secolo scorso in ricordo di un personaggio italiano assai importante. Molti di voi, immagino, si chiederanno chi mai fosse costui.
Ritenendo che tali vicende oggi non le conosca più nessuno, forse è utile ricordarle.
Era il 1931 e mancavano pochi giorni a Natale, quando Benito Mussolini mandò un telegramma a tutte le scuole del Regno, ordinando di piantare «in memoria del defunto, una quercia, simbolo di forza, di maestosità e di vita eterna».
Evidentemente lo scomparso doveva essere molto vicino al Capo del Governo fascista, se questi si scomodò di persona imponendo ad ogni istituzione educativa una specie di memoria di Stato. In effetti, la persona in onore della quale era partito quell’ordine era suo  fratello minore, Arnaldo, morto improvvisamente per infarto all’età di soli 46 anni.
fratello minore, Arnaldo, morto improvvisamente per infarto all’età di soli 46 anni.
Arnaldo Mussolini, insegnante e giornalista, era stato in quegli anni tempestosi il pensiero moderato, il saggio consigliere del fratello maggiore, colui che nell’ombra si occupava per suo conto delle questioni più delicate, anche familiari, fra cui una in particolare, della quale oggi vi vogliamo raccontare.
Tutto - compresa la nostra storia - era iniziato l’11 novembre del 1915 con la nascita, a Milano, di un bambino.
Ufficialmente non è certo se la madre avesse contratto matrimonio, tuttavia il padre riconobbe il bimbo, dandogli il suo cognome. Quell’uomo - all’epoca uno qualunque - si chiamava Benito Mussolini; la donna, Ida Dalser, una bella trentacinquenne proveniente dal piccolo paese di Sopramonte, in Trentino-Sud Tirolo, allora provincia dell’Impero Austro-Ungarico.
Ma non è dei genitori che desideriamo parlare oggi. Della loro burrascosa relazione e delle vessazioni subite dalla Dalser da parte del suo presunto marito e soprattutto della sua fine disperata in manicomio, si è già scritto molto. È del piccolo Benito Albino - questo il nome del loro figlioletto - che intendiamo rendere conto, in particolare del suo breve e doloroso passaggio in Trentino.
Dopo la nascita del bimbo, Ida Dalser ben presto si rese conto che l’arrivo di quella creatura, anziché rinsaldare il legame con Mussolini, lo stava facendo allentare. Di mezzo si mise pure l’inizio della guerra e la chiamata dell’uomo alle armi per un breve periodo. Ma purtroppo non era solo quello. Lei, che si era privata di tutto il suo cospicuo patrimonio per permettere al compagno di aprire l’anno prima il giornale «Il Popolo d’Italia», ora si stava convincendo di essere stata solo usata. Semplicemente usata, come accadrà a molte altre donne del Duce.
Già nel 1915, e sempre più nei mesi successivi, Mussolini preso da mille impegni politici (e da altre relazioni amorose) iniziò a trascurare il figlio e sua madre, la quale - è da dire - con quel suo atto di generosità era rimasta nullatenente. In effetti, nel corso del 1916 la sua situazione economica si aggravò a tal punto da indurre la donna a rivolgersi al Tribunale di Milano per vedere almeno riconosciuti gli alimenti al piccolo Benito Albino. Il giudice le diede ragione e ingiunse al futuro Capo del Governo di pagare un assegno di mantenimento di 200 lire al mese, tenuto conto del buon tenore di vita che l’uomo poteva ora permettersi grazie ai cospicui introiti del giornale.
Con tale sentenza, la storia fra i due era evidentemente arrivata al capolinea, ma da donna orgogliosa e ferita nei sentimenti, Ida non voleva accettare di aver perduto per sempre il suo uomo.
La forte determinazione la portò così ad avviare una lunga battaglia altalenante nei confronti di Mussolini, una  battaglia che la vide passare da suppliche, a volte patetiche, a invettive esasperate colme di insulti e maledizioni, arrivando persino al punto di imbastire rumorose sceneggiate davanti alla redazione del giornale.
battaglia che la vide passare da suppliche, a volte patetiche, a invettive esasperate colme di insulti e maledizioni, arrivando persino al punto di imbastire rumorose sceneggiate davanti alla redazione del giornale.
Nel maggio del 1917, diventata sempre più scomoda la presenza a Milano della sua «ex», grazie a pressione di influenti personaggi, Mussolini la fece allontanare convincendoli di una sua presunta pericolosità in quanto cittadina austriaca. La donna, con il figlioletto, venne quindi condotta forzatamente a Caserta.
Fu durante tale periodo che la Dalser decise di vendicarsi di quell’ignobile azione, convinta, a ragione, che tutto ciò fosse stata opera di Mussolini. Si rivolse quindi a un quotidiano e denunciò pubblicamente che attorno al Popolo d’Italia ruotavano interessi sporchi di Governi stranieri, per prima la Francia, oltre a quelli di banche e finanzieri italiani.
Mussolini incassò il colpo, ma giurò che quella donna sarebbe stata messa al più presto nelle condizioni di non nuocere.
Alla fine del 1918, finita la guerra, la Dalser tornò libera a Milano, stavolta come cittadina italiana, ma lì rimase ben poco. Nel 1919, infatti, assieme al bambino, che all’epoca aveva 8 anni, rientrò a Sopramonte presso la casa di suo padre Albino, già sindaco del paese.
Per il piccolo Benito Albino pareva essere finalmente arrivato il momento per godere di un po’ di serenità dopo continui trasferimenti e litigi. Ma non sarà così.
Il bambino iniziò a frequentare la locale scuola elementare e come riferiscono delle testimonianze raccolte da alcuni ricercatori, fra cui il giornalista Marco Zeni, «voleva avere sempre una parola in più degli altri, come suo padre. Inoltre era sfrontato: Io so più di te. Tu non sai chi sono io» - diceva spesso, e ogni tanto dava anche qualche sberla ai compagni».
Tuttavia, al di là di tale comportamento di supponenza, chi lo conobbe racconta che c’era nel bambino una profonda amarezza, un grande vuoto per essere cresciuto senza il padre. E un’anziana signora, ricorda: «Andava a bottega, sgraffignava una caramella e poi scappava a gambe levate gridando: Passerà mio papà Benito a pagare!».
Ma purtroppo per lui quel papà tanto vagheggiato, come non l’aveva mai visto prima, così  non l’avrebbe conosciuto neppure in futuro.
non l’avrebbe conosciuto neppure in futuro.
Anche Ida, nonostante numerosi tentativi, non incontrerà mai più Benito Mussolini e per quanto si trovasse ora circondata dall’affetto dei suoi cari non riuscirà a trovare conforto all’ossessione di vedersi riconosciuta da lui come moglie legittima.
E così, dopo che il suo Benito si era sposato (per davvero) con Rachele Guidi e avuto da lei pure due figli, Ida continuò a chiedere incessantemente aiuto a politici, a funzionari e ad alti prelati. Scriverà persino al Papa e al Re perché intervenissero in suo favore, innervosendo con ciò, ulteriormente, quello che era diventato l’uomo più potente d’Italia.
Fu per questa sua ostinazione che casa Dalser, a Sopramonte, dapprima venne fatta oggetto di sorveglianza a distanza, più avanti picchettata permanentemente dai carabinieri affinché la donna non perseverasse nei suoi propositi a danno del Capo del Governo.
Per comprendere il clima ostile che circondava la donna, significativa è la lettera scritta da Mussolini ad un alto dirigente di Trento, suo conterraneo: «La persona di cui mi parli (Ida Dalser, ndr) è una pericolosa squilibrata e criminale ricattatrice. Dimmi cosa fa, dove e come vive. Nello stesso tempo falla sorvegliare e cacciala in galera.»
Il 19 giugno del 1926, in occasione dell’arrivo a Trento di un ministro che lei aveva conosciuto a Milano, la Dalser decise di andare ad incontrarlo all’Hotel Bristol, dove era ospite. Il motivo, ovviamente, era sempre lo stesso.
Non fu mai chiarito chi fu la spia, ma a quanto risulta dalle testimonianze è che i suoi propositi furono scoperti anzitempo. Infatti, lungo il tragitto la donna venne bloccata dalla polizia e tratta in arresto.
Al commissariato di Piazza della Mostra fu poi convocato in fretta e furia un medico compiacente che dispose l’immediato ricovero della Dalser presso il vicino manicomio di Pergine, dichiarandola inferma di mente.
Quanto chiesto a gran voce da Mussolini si era compiuto e per madre e figlio quello sarà l’inizio di un lungo calvario.
Ida verrà sepolta per sempre negli ospedali psichiatrici.
Benito Albino - «il nostro piccolo grande amore» come lei scrisse in una lettera al Duce - quale innocente vittima sacrificale sarà invece dato in tutela a tale Giulio Bernardi, commissario prefettizio di Sopramonte.
Attraverso quest’opportunista personaggio, venne raggiunto un accordo economico con Arnaldo Mussolini (eccolo riapparire nella nostra storia!), il quale fino a quel momento, per conto del Duce, si era occupato con discrezione della questione Dalser.
Capitò così che non molti giorni dopo l’internamento coatto di Ida in manicomio, si presentò a casa Dalser un manipolo di poliziotti con alla testa il Bernardi: erano lì per portare via anche Benito Albino, allora undicenne.
Il bambino, però, non voleva assolutamente saperne di seguire colui che era stato nominato suo tutore, per cui reagì con forza. Neppure i parenti rimasero ad assistere inermi a quello che di fatto era un rapimento, e si opposero.
Nella concitazione del momento, tra urla e spintoni, fu allora che qualcuno fra i poliziotti si fece avanti con un fazzoletto imbevuto di cloroformio. Narcotizzato, Benito Albino fu strappato ai familiari, portato via di peso e caricato su di un’automobile nera che attendeva sotto casa.
Da Sopramonte l’auto della polizia scese prima a Trento e poi proseguì verso Rovereto, fermandosi davanti all’Istituto Educativo Provinciale di Sant’Ilario, quello che al tempo la gente comune chiamava semplicemente «il ricovero dei derelitti».

In realtà il grande edificio, inaugurato nel 1912, era stato destinato dalle autorità austriache a bambini fra i 6 e i 14 anni, molto spesso orfani, figli illegittimi, o, in qualche caso, esposti a «pericoli sociali» a causa di situazioni famigliari di povertà, di violenza o di alcolismo.
Qui, l’arrivo del piccolo Mussolini non passò inosservato.
Carlo Calzà, scomparso nel 2006, figura storica di Rovereto grazie del suo lungo impegno in ambito sociale, ricorderà infatti per tutta la vita quel ragazzino dai grandi occhi smarriti, condotto dai poliziotti entro i cancelli dell’istituto.
Non che la scena fosse del tutto inusuale per chi viveva all’istituto: infatti, negli otto anni che Carlo aveva già trascorso a Sant’Ilario, lui ne aveva visti  parecchi di avvenimenti analoghi allorquando dei ragazzi fuggiaschi venivano presi e ricondotti indietro dalla polizia.
parecchi di avvenimenti analoghi allorquando dei ragazzi fuggiaschi venivano presi e ricondotti indietro dalla polizia.
Carlo Calzà, orfano di padre caduto in Galizia, vi era giunto bambino, subito dopo la guerra, al rientro dalla Boemia dove era stato sfollato con la famiglia. In questo istituto, lui verrà cresciuto, educato e avviato all’insegnamento della musica. Qui, sotto la direzione dei Padri Concezionisti, imparerà anche il mestiere di tipografo, che poi, a sua volta, insegnerà ad altri giovani ospiti. Complessivamente trascorrerà nell’istituto più di vent’anni.
Nel giugno del 1926, come detto, Carlo, allora quindicenne, ebbe la ventura di incrociare gli occhi del giovane Mussolini e di vederlo poi girare nei cortili e lungo i corridoi dell’edificio.
«Vedi quello? – si sentì dire un giorno dal ragazzino, mentre indicava un’immagine del Duce appesa alla parete. – Quello è mio padre, Benito Mussolini.»
Ma, oltre a Carlo, il nuovo arrivato ripeteva ossessivamente la stessa cosa a tutti i compagni che passavano nei paraggi di quella fotografia incorniciata.
Triste e taciturno, sempre in disparte rispetto agli altri che giocavano allegri in cortile, solo davanti a quell’immagine Benito Albino pareva trovasse la voglia di parlare.
Forse era quella la sua unica consolazione, forse l’unico modo per superare nell’orgoglio di quel nome e di quel cognome il dolore del distacco da sua madre e dalla sua famiglia.
«Benito Mussolini, il Duce: lo conosci, vero? Io, sono suo figlio.  Questa frase la ripeté fino alla noia, fino a quando, all’istituto e anche fuori, tutti non vennero a conoscenza di quell’identità e di quella presenza. Del resto la sorprendente somiglianza nei tratti fisici non poteva che avvalorare quelle parole: il bambino era evidentemente il figlio del Capo del Governo fascista.
Questa frase la ripeté fino alla noia, fino a quando, all’istituto e anche fuori, tutti non vennero a conoscenza di quell’identità e di quella presenza. Del resto la sorprendente somiglianza nei tratti fisici non poteva che avvalorare quelle parole: il bambino era evidentemente il figlio del Capo del Governo fascista.
Per le autorità, però, la situazione stava diventando delicata anche perché Benito Albino non dichiarava ad alta voce solo le sue generalità, ma denunciava pure ciò che sapeva a riguardo dell’abbandono del padre e all’internamento forzoso della madre in manicomio.
Per di più, in quei giorni, il ragazzo aveva già tentato la fuga.
La questione stava per degenerare e doveva dunque essere riconsiderata: troppi occhi e troppe voci in città si erano appuntate sull’Istituto.
Così, per ordine di Arnaldo Mussolini, il ragazzo fu caricato nuovamente su di un’automobile e portato a Moncalieri, stavolta in un collegio destinato alla ricca borghesia piemontese.
Di quel breve passaggio da Sant’Ilario è rimasta traccia in un carteggio intercorso fra il direttore dell’istituto e il padre generale dell’Ordine: «Il piccolo Benito è stato ritirato ieri sera alle 21,30 da un Commissario di P.S. di Rovereto e da un Maresciallo di Polizia di Trento e condotto su un’automobile verso destinazione ignota. «È cessato così lo stato di cose anormale che attirava l’attenzione degli esterni, specialmente per la continua presenza di Poliziotti.»
Nel «Real Collegio Carlo Alberto» di Moncalieri, dove rimarrà per cinque anni, Benito Albino non riuscrà a stringere legami di amicizia significativi con nessuno dei suoi compagni: «Troppo orgoglioso, troppo ostinato nelle sue certezze» – riferirà qualcuno.
Del tutto simile al difficile carattere del padre (oltre a essere «quasi identico» sia nel modo di parlare che nei movimenti) i pochi testimoni a lui vicini, raccontarono che in quel periodo il ragazzo si prestò spesso ad imitare il Duce in indimenticabili ed esilaranti parodie.
Lo zio Arnaldo, comunque, continuò a seguire quel suo nipote particolare, scrivendogli di frequente e qualche volta andando pure a fargli visita, mosso a quanto pare da un sincero sentimento di affetto, ricambiato pure dal giovane.
È del luglio 1929 la lettera seguente.
«(…) So che sei ubbidiente verso i tuoi buoni superiori. Di questa ultima cosa ti faccio una speciale raccomandazione. Spero di venirti a trovare fra non molto tempo.
«Ad ogni modo rassicurati che penso spesso a te e al tuo avvenire. Sii buono e sii bravo e ricevi un abbraccio dal tuo affezionatissimo Arnaldo.»

Nel frattempo, il ragazzo era cresciuto e si era fatto grande, così come erano cresciute negli anni le pietose bugie che avevano riempito l’assenza di una madre reclusa, mai più vista né sentita.
Chissà, forse il giovane se n’era fatta una ragione: la psiche, sappiamo, sa sempre inventare qualcosa per travisare la realtà e alleviare i dolori della vita. Adesso Benito Albino pareva godere di una relativa tranquillità. Una tranquillità che purtroppo non sarebbe durata a lungo. Infatti, nel dicembre del 1931 - come abbiamo già visto - morirà all’improvviso Arnaldo Mussolini.
Per il ragazzo quell’evento luttuoso segnerà l’inizio della fine. Persi completamente i contatti con la madre, allentati quelli con i parenti, con la morte dello zio venne a mancare, in sostanza, l’unico punto di riferimento avuto in quei lunghi anni passati a Moncalieri. Anni fondamentali per la formazione di un giovane uomo.
Da quel momento in poi, gli avvenimenti della sua vita si fecero incalzanti. Nel 1932, a 17 anni, il ragazzo ritornò a Trento dal padre adottivo, Giulio Bernardi, il quale lo iscrisse dapprima all’Istituto tecnico e, successivamente, all’Istituto agrario di San Michele all’Adige.  Ma qualcosa evidentemente non funzionava. Nel 1933, Benito Albino cambiò nuovamente e si iscrisse alla Scuola navale di La Spezia assieme ad un nipote dello stesso Bernardi.
Ma qualcosa evidentemente non funzionava. Nel 1933, Benito Albino cambiò nuovamente e si iscrisse alla Scuola navale di La Spezia assieme ad un nipote dello stesso Bernardi.
Nel 1934, quindi, decise di imbarcarsi per la Cina. Ciò che non funzionava, per le autorità fasciste, era il fatto che il ragazzo non si rassegnava a nascondere le sue origini dietro ad un cognome che non gli apparteneva.
Sapeva chi era il suo vero padre e in un sentimento contrastante di odio e di ammirazione, lo reclamava continuamente.
Nonostante i divieti, lui voleva poter pronunciare liberamente il suo vero cognome. Lo fece una volta e da lì in avanti lo ripeté ad alta voce in ogni circostanza: «Il mio nome è Benito Albino e sono il figlio di Benito Mussolini.»
Alla lunga, pure lui diventò pericoloso per il Duce. Rimpatriato nel 1935 con un falso telegramma che gli annunciava la morte della madre, all’arrivo in Italia era atteso dalla polizia che lo prese in consegna e lo portò al manicomio di Mombello, vicino a Milano.
Anche per lui era stato preparato lo stesso crudele trattamento riservato alla madre: la presunta follia, l’ospedale psichiatrico, l’oblio, la condanna a morte per stenti.
Per Benito Albino Mussolini quella è la fine della libertà, la fine della speranza e della vita.
E come la sua, anche la nostra storia finisce tristemente qui.
Ida Dalser cesserà di vivere nel manicomio di Venezia nel 1937, a 57 anni.
Benito Albino morirà nel manicomio di Mombello nel 1942, a 26 anni.
Il malvagio tiranno, dopo avere finalmente eliminato i suoi pericolosi oppositori, ora poteva dormire sonni tranquilli.
La resa dei conti del destino poteva aspettare ancora, ma non poteva attendere all’infinito. Al tragico appuntamento di Giulino di Mezzegra mancavano poco meno di tre anni.
Maurizio Panizza - [email protected]