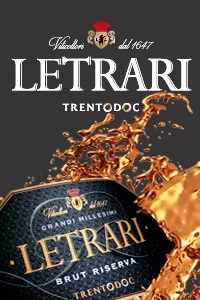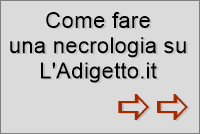Un salvagente al vescovo: «Matteo Miotto, ma quale eroe?»
Che bisogno c'era di esprimersi in maniera così intempestiva, quando ancora non sono asciugate le lacrime dei genitori?

Non vorrei sembrare di parte, dato
che ho passato una decina di giorni in Afghanistan con i nostri
alpini, ma mi ha fatto una certa impressione leggere che il vescovo
di Padova si sia apertamente schierato contro l'idea di considerare
«eroe» Matteo Miotto, l'alpino che è morto in un conflitto a fuoco
in un avamposto del Gulistan.
Quantomeno piuttosto intempestivo.
«Non è un eroe. - Ha detto il vescovo. - Come si diventa
eroi? Quali azioni deve compiere un uomo per fregiarsi
dell'appellativo di eroe? C'è qualche corsia preferenziale
da percorrere per diventarlo? Chi decide chi è un eroe e chi non lo
è? Se è un eroe chi muore combattendo per lo Stato, lo è anche chi
muore lavorando in fabbrica? Domande forse banali e poco
interessanti ma che nelle ultime ore hanno scatenato l'ennesima
polemica sulla presenza delle truppe italiane in Afghanistan.»
«Certo sono dispiaciuto per la morte di questo ragazzo, - ha subito
precisato il vescovo - Ma non sono d'accordo con una certa
esaltazione retorica. Non facciamone degli eroi. Magari poi si
scopre che un soldato è morto per una mina fabbricata in
Italia.»
Poi ha avanzato i propri dubbi sulla «missione di pace».
«Ma quelle non sono missioni di pace. I nostri soldati vanno lì con
le armi…»
Il nostro commento è semplice e si svolge in cinque
considerazioni.
Matteo non è morto dando la vita per salvare qualcuno, se è questo
che l'iconografia popolare intende per eroe. D'altronde esistono
vari livelli di encomio proprio per dare diverso peso ai singoli
episodi.
Ma il fatto che Matteo non abbia messo in dubbio che la vita doveva
rischiarla, lo pone comunque su un livello decisamente elevato di
per sé.
Che sia o non sia una missione di pace, è ininfluente per un
soldato: è la politica (cioè il Paese) che lo decide, che lo manda
in un teatro anziché in un altro.
Ma la differenza tra una missione di guerra e una di pace non è una
sottile linea rossa. Consiste nel diverso codice militare. In
quello di pace, l'uso delle armi è talmente circoscritto da rendere
la missione paradossalmente molto più rischiosa di una di
guerra.
Basti pensare che se i nostri militari venissero presi a cannonate
da un villaggio, in missione di pace non potrebbero rispondere al
fuoco finché non hanno accertato che nel villaggio non ci sono
civili.
E per favore non paragoniamo il militare a un operaio di
fabbrica.
Quest'ultimo va a lavorare in un posto dove la morte non può essere
neppure messa in discussione nei contratti di lavoro. Tanto vero
che se accade qualcosa, la proprietà ne è responsabile.
Il primo invece lavora in un posto e in condizioni dove la morte è
considerata un evento possibile.
Quanto alle armi «che magari sono costruite da italiani», per
carità, almeno non incolpiamo le vittime!
Infine, l'opportunità di parlare. Tutti possono farlo in questo
Paese, grazie a Dio. Anzi, grazie al nostro Dio, dato che
nei paesi islamici non c'è proprio una gran libertà di parola.
Quindi il vescovo ha espresso la sua soggettività, così come noi
stiamo esprimendo qui la nostra.
Probabilmente ha ragione a invitare di non esagerare sugli atti di
eroismo.
Ma poiché siamo certi che chi dovrà valutare il comportamento di
Matteo lo farà con estrema obbiettività, ci domandiamo che senso
abbia avuto declamarlo ai quattro venti.
Non si poteva lasciare che i poveri familiari pensassero che tutto
il paese considerasse il proprio figlio un Eroe?
Anche perché lo è a tutti gli effetti.
GdM
[email protected]