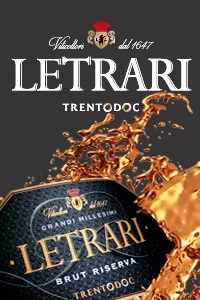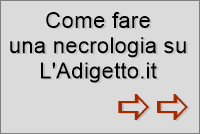La tavola del contadino – Di Giuseppe Casagrande
L'intervento del decano dei giornalisti enogastronomici trentini alla cena ecumenica dell'Accademia Italiana della Cucina all'Hotel Liberty di Riva del Garda

L'intervento di Giuseppe Casagrande - Foto Fabio Galas.
| La tavola del contadino Giovedì scorso tutte le Delegazioni dell’Accademia Italiana della Cucina, in Italia e nel Mondo (sono più di 320) si sono ritrovate nello stesso giorno in occasione della tradizionale «Cena Ecumenica». L'incontro conviviale di quest'anno aveva come tema «La tavola del contadino». Gli Accademici della Delegazione di Rovereto e Riva del Garda si sono dati appuntamento al Grand Hotel Liberty di Riva del Garda. Vi proponiamo il testo integrale dell'intervento del giornalista Giuseppe Casagrande, decano dei critici enogastronomici trentini. |
Cari amici Accademici, cari ospiti, autorità.
Sono felice di condividere con voi questo incontro conviviale in occasione dell'annuale cena ecumenica dell'Accademia Italiana della Cucina dedicata quest'anno alla Tavola del Contadino: il campo, il cortile, la stalla.
Compito impegnativo quello assegnatomi per la vastità del tema. Tema, comunque, affascinante. Cercherò di onorarlo come scrissi al delegato avv. Berteotti attraverso racconti, ricordi, aneddoti, curiosità, non certo con la pretesa esaustiva di una lectio magistralis.
L'atavico pregiudizio sulla cucina «povera»
Tema affascinante, dicevo, che mi sta a cuore avendo più volte parlato della cucina contadina spesso etichettata, per atavici pregiudizi, con il termine spregiativo di cucina povera.
Una cucina spesso di sopravvivenza fatta di pochi ingredienti, anche i più umili, ma ricca di inventiva come giustamente suggerisce il presidente dell'Accademia Paolo Petroni nel bellissimo volume dedicato al tema.
Ingredienti che le nostre nonne e le nostre mamme, pur nel contesto di un territorio di montagna spesso aspro e soprattutto in tempi di ristrettezze economiche, guerre e carestie, hanno saputo trasformare in autentiche prelibatezze.
Pietanze che, ripescate da un passato ricco di antichi saperi e sapori, molti ristoranti, trattorie e agritur, dopo l'ubriacatura della nouvelle cuisine, della cucina etnico-esotica, della cucina molecolare, della cucina fusion (che ho ribattezzato «cucina confusión») oggi ripropongono come piatti della tradizione contadina.
Quando la cucina diventa un gesto d'amore
Presentando un mio libriccino «Cucina Trentina» (casa editrice Panorama, 2010) scrivevo: «Possono le patate, la polenta, i cavoli, le cipolle, i germogli d'ortica o altre erbe spontanee rendere un piatto straordinario? Senz'altro sì, purché le varie pietanze siano preparate con amore per il territorio, poiché la cucina è soprattutto un gesto d'amore come ha confessato in una recente intervista anche Massimo Bottura del ristorante tristellato La Francescana di Modena (tra parentesi: di lui ricordo una peccaminosa spuma di mortadella bolognese spalmata su crostini di pane).»
L'intervento del delegato dell'Accademia di Rovereto e Riva avv. Germano Berteotti.
La minestra di ortiche del mitico Gigi Caresia
Ho citato le ortiche poiché conservo il ricordo di uno dei piatti più poveri della cucina trentina: la minestra di ortiche, assaggiata 40 e più anni fa a Rovereto nella «cambusa» di Gigi Caresia (il «Pellegrino Artusi del Trentino») con dei crostini di pane e un filo d'olio extravergine del Garda. Un piatto sublime che Caresia interpretò con il tocco magico dei grandi chef.
Ma lo stesso dicasi degli Strangolapreti, del Tónco de pontesèl, dello Smacafàm, dello Sguazét, del Tortèl de patate, altri piatti tipici della cucina trentina che, grazie anche all'opera meritoria di alcune Confraternite gastronomiche, dopo anni di oblio sono stati rivalutati e figurano nei menu di molti ristoranti.
Un tempo nelle valli del Trentino era la polenta, assieme ai cavoli, ai fagioli e alle patate, l'alimento-base delle popolazioni di montagna visto che gli insaccati, le uova, il formaggio, il burro, i polli, i conigli venivano venduti per racimolare quelle poche lire indispensabili per sopravvivere.
Quei piatti ruspanti delle trattorie di campagna
Nei miei 55 anni di professione giornalistica «vissuti pericolosamente tra ristoranti, trattorie, cantine e peccati di gola» e raccontati su quotidiani (per 35 anni sulle pagine dell'Adige con cadenza settimanale), riviste nazionali («Italia a Tavola», «Itinerari dei Sapori», «Convivium»), guide enogastronomiche (Best Gourmet of Alpe Adria) e come direttore della rivista mitteleuropea Papageno, (in italiano e tedesco), bene in tutti questi anni ho conosciuto grandi chef pluristellati, ma - confesso - che le emozioni più intense le ho provate assaggiando i piatti ruspanti di alcune trattorie di campagna poiché la cucina non è fatta solo di foie gras, aragoste, caviale, ostriche e tartufi.

Paolo Donei Malga Panna, Moena.
I «rufioi» della Valle dei Mòcheni
Un esempio per tutti: i rufioi della Valle dei Mòcheni che oggi abbiamo assaggiato e che 25 anni fa Fabio Barba Decarli presentò a Venezia alla finale del concorso «Fogher d'oro» ideato dai gastronomi trevigiani Bepo Maffioli e Annibale Toffolo, concorso riservato ai ristoranti di Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli, Austria, Ungheria, Slovenia e Croazia.
Ricordo il suo timore quando, dopo aver salutato in cucina alcuni mostri sacri della ristorazione, disse alla moglie in dialetto trentino: «Renata, ma cosa facciamo noi qui, andiamo a casa».
Lo convinsi a rimanere e alla fine vinse proprio con i rufioi: piatto di una semplicità disarmante (verze, porri, pangrattato, un pizzico di cannella, salvia, burro fuso e Trentingrana), piatto premiato dalla giuria internazionale con voto unanime. All'epoca Fabio gestiva con la moglie il ristorante Al Ponte di Pergine.
Poi sbarcò Trento, all'Orso Grigio, e quei rufioi sono ancora oggi, dopo la sua dipartita, uno dei piatti cult del locale.
Nobilitare i prodotti del territorio e la cucina della nonna
A questo punto avrete capito quanto io ami la cucina schietta e genuina, che rispetta la materia prima e segue il corso naturale delle stagioni.
Una cucina senza fronzoli, voli pindarici e barocchismi. Una cucina verace che incontro e riscopro ogni giorno non solo nelle nostre città e nelle nostre borgate, ma in molte regioni della Penisola e in molti Paesi europei anche attraverso le ricette della nonna. Ricette che ognuno di noi custodisce nel proprio cuore e che tramanda ai propri figli.
La cucina della nonna è un luogo magico che anche i grandi chef stellati ricordano con un pizzico di nostalgia.
Niko Romito, ad esempio, il tristellato chef abruzzese del Ristorante Reale di Castel di Sangro (L'Aquila) incoronato dal Gambero Rosso miglior chef d'Italia, ricorda quando nonna Raffaella la domenica tirava la sfoglia per preparare la pasta ripiena, le tagliatelle, gli gnocchi.
«Ricordo – racconta – la farina e i tuorli d'uovo che si appiccicavano alle dita, i dischi di pasta dei ravioli che noi bambini chiudevamo uno a uno e poi la nonna li metteva in pentola.»

Alfio Ghezzi.
Alfio Ghezzi, Alessandro Gilmozzi, Paolo Donei, Peter Brunel
Mi ha fatto piacere che anche alcuni chef stellati di casa nostra, nei giorni scorsi in occasione del Festival delle bollicine Trentodoc, abbiano sposato questa causa: cioè il ritorno alla cucina del territorio.
Alfio Ghezzi (chef stellato del Mart), ad esempio, ha nobilitato la funzione dell'orto e dei campi parlando in particolare della Cooperativa sociale Villa Maria di Calliano, i cui prodotti (patate, cavoli, broccoli, carote gialle, sedano, rape, finocchi) sono ormai diventati un «must» della sua cucina.
E lo ha dimostrato al pubblico cucinando un cavolo cappuccio rosolato alla piastra e insaporito con cacao, liquirizia, nocciole e una riduzione di Chardonnay.
Alessandro Gilmozzi (Ristorante «El Molin», Cavalese), oltre all'orto di casa, ha ridato dignità anche ai prodotti del bosco: i funghi, i licheni, le bacche, i fiori, le erbe spontanee raccolte giorno dopo giorno e utilizzate nelle varie stagioni, il burro di malga insaporito con il ginepro, senza peraltro trascurare le risorse dei nostri allevamenti bovini, suini e quanto ci può offrire la montagna con la selvaggina.
Sulla stessa lunghezza d'onda di Gilmozzi lo chef stellato di «Malga Panna» Paolo Donei (Moena) che al cospetto di un pubblico rapito dalle sue parole mentre cucinava un maialino alla brace presentato poi su una purea di patate con un brodo di erbe realizzato con una moka da caffè, sentenziò: «Ogni prodotto della terra è un dono del Signore. Rispettiamolo».
Rigoroso rispetto per i prodotti del territorio è nel Dna di un altro talentuoso chef stellato trentino: Peter Brunel (Arco) che all'orto e alle patate in particolare, patate che cambiano colore e sapore a seconda della terra in cui crescono (ne esistono oltre 5 mila varietà nel mondo), dedica molti piatti dei suoi menu.
«Per noi cuochi – dice – sono una risorsa preziosissima, direi fondamentale.»
Con le patate, ad esempio, Peter Brunel fa anche gli spaghetti, mentre la spuma di patate la utilizza nelle vellutate o come salsa con l'uovo di montagna spolverato di un peperoncino dolce, made in Trentino anche questo.

Peter Brunel Ristorante PB, Arco.
Il «tortel» e la torta di patate della Val di Non
Le patate arrivano in Italia, dalla Spagna, nella seconda metà del Cinquecento. La loro presenza è confermata dagli archivi dell'orto botanico di Padova.
Però si ha notizia delle prime coltivazioni solo un secolo dopo, in via sperimentale. Destinatari di questo tubero erano gli animali. Solo a fine Ottocento le patate entrano in cucina.
In Trentino molte sono le ricette che hanno la patata come protagonista, in particolare nelle valli di Non e Sole.
Uno dei piatti tipici è il tortèl di patate, piatto proposto, assieme alla torta di patate, in molti ristoranti. Piatto valorizzato da una Confraternita gastronomica presieduta dal Gran Maestro Mario Tonon che nella scelta delle patate raccomanda quelle a pasta bianca, in particolare le Kennebec e le Majestic.
Di quale colore politico è la minestra?
Altro capitolo importantissimo è quello delle minestre, dei minestroni e delle zuppe. Nei giorni scorsi ho recensito un simpatico volumetto dal titolo «Non è la solita minestra» scritto da un collega friulano Enzo Cattaruzzi e da un maestro di cucina Germano Pontoni che avevo conosciuto ai miei esordi giornalistici a Udine durante la presentazione del prosciuttino d'oca dell'azienda Jolanda de Colò (il patron Antonello Pessot all'epoca allevava un migliaio di oche a Palmanova, oggi in Ungheria controlla ben 700 allevamenti di oche e anatre).
Cattaruzzi si chiede: di quale colore (politico) è la minestra? Giorgio Gaber, nella famosa ballata meneghina Destra-Sinistra non aveva dubbi.
«Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra». Decidete voi.
Tra le mille ricette di Germano Pontoni emblematica è la zuppa d'orzo e fagioli con lo speck, ricetta che accomuna le popolazioni delle Dolomiti trentine, venete e friulane colpite in occasione della disastrosa tempesta Vaia del 2018.
E ancora, solo per citarne alcune, il minestrone di verze, patate e fagioli; la minestra maritata; il brut brusà; la panàda; la minestra di zucca; la zuppa di castagne; la vellutata di cipolle; la jota.

Amarcord personali: la cultura del cucchiaio
Un amico scrittore croato, Drago Orlic, durante i nostri frequenti incontri in Istria quando entrava in una gostiona (trattoria) e non vedeva sul tavolo apparecchiato il cucchiaio da minestra salutava l'oste e mi portava nelle locande dove il ruolo di protagonista della tavola era riservato alla «supa» servita nella classica bokaleta o alle minestre di fagioli e patate o di bobici (chicchi di mais) insaporite con il culetto di «prsut».
La cultura del cucchiaio è uno dei precetti anche di Tomaz Kavic, stella Michelin, proclamato da Gault&Millau miglior chef di Slovenia, nume tutelare del castello di Zemono, nella valle di Vipacco, a due passi da Gorizia, dove nasce la bora.
«Non posso immaginare – sostiene – la cucina senza una zuppa d'orzo o di verdure o senza patate e fagioli.»
Piatti che sono gli ingredienti base della famosa jota del Carso che Tomaz Kavcic propone come piatto iconico nei congressi internazionali di alta cucina cui partecipa.
La pasta e fagioli di Lidia Bastianich
E per rimanere in zona non posso dimenticare un fantastico minestrone dell'orto e la frittata con gli asparagi selvatici che una decina di anni fa Lidia Bastianch, esule istriana proprietaria di numerosi ristoranti negli Stati Uniti, ci preparò (ero con il fotografo di Papageno per un'intervista dopo l'acquisizione assieme al figlio Joe di una tenuta agricola e di un ristorante a Cividale del Friuli).
Il suo piatto più gettonato a New York? La pasta e fagioli.
La mitica «Pasta e Fasioi», per rimanere in tema, è anche il piatto cult (assieme alle «castraure», i carciofi dell'isola di Sant'Erasmo) di Arrigo Cipriani a Venezia (Harry's Bar), altro monumento della ristorazione mondiale (vanta un impero di 27 locali).
Lo intervistai la primavera scorsa in occasione della festa per i 90 anni del maestro. Fu in quell'occasione che si scagliò contro i reality show e i porofeti della cucina spettacolo. «Non ne posso più» tuonò.

Lo scrittore istriano Drago Orlic, grande amico del Trentino.
Sua maestà la polenta: Storo docet
Oltre alle minestre voglio ricordare un altro prodotto un tempo povero del Trentino: la polenta che dopo anni di oblio, sta vivendo un momento magico grazie soprattutto ad un vulcanico personaggio della Valle del Chiese, Vigilio Giovanelli, che a Storo negli anni Novanta del secolo scorso è riuscito a ridare slancio ad una coltivazione, quella del mais, che stava per essere abbandonata.
E in pochi anni ha trasformato l'umile cereale in una pepita d'oro: l'oro giallo di Storo oggi conosciuto e apprezzato anche sulle tavole dei grandi chef non solo in Italia, ma anche all'estero.
Un esempio per tutti: Jacques Chibois, chef pluristellato de «La Bastide Saint Antoine» a Grasse.
Nella capitale mondiale dei profumi propone una polenta all'onda di Storo (galeotta per fargliela conoscere fu una mia trasferta in Costa Azzura una ventina d'anni fa), polenta che propone con le seppie in umido.
Il Festival della Polenta e le «Polentiadi» di Parenzo
A decretare il successo della polenta di Storo (un successo travolgente se pensiamo che la produzione del Maranello Nostrano è passata in pochi anni da 300 a 15mila quintali) furono i Festival della Polenta con le famose Polentiadi di Parenzo-Porec, cittadina istriana (tra parentesi fu anche grazie a questo evento che nel Duemila l'amministrazione comunale mi conferì la cittadinanza onoraria).
Una simpatica disfida tra ristoranti croati, sloveni e italiani, cui parteciparono, vincendola, molti ristoranti trentini.
Oltre alla farina da polenta, la cooperativa Agri '90 oggi produce una farina bianca di grano tenero (qualche giorno fa è stato inaugurato il nuovo mulino), una farina di grano saraceno e le gallette di granturco.
La stalla e gli animali da cortile
Per quanto riguarda la stalla (maiali, mucche, pecore) e gli animali da cortile (polli, galline, tacchini, oche, anatre, conigli) il Trentino non vanta sicuramente la carrellata di prodotti che hanno reso famose molte località del Veneto, dell'Emilia, della Lombardia.
Parlando di Lombardia, un ricordo personale. Quel petto d’anatra all’aceto balsamico e mostarda di mele campanine del ristorante tristellato «Dal Pescatore» di Nadia Santini (Canneto sull'Oglio, Mantova), più volte premiata come la migliore chef donna al mondo.
Un'icona Nadia Santini, amica di Paul Bocuse, che la onorava di una sua visita quando si recava in Italia per assaggiare i tortelli di zucca o i tortelli in brodo preparati con i tuorli d'uovo delle galline di casa.
Discepola ideale delle mitiche Mère, madri dell'alta cucina francese (Eugénie Brazier su tutte), Nadia Santini è sicuramente la figura che più di altri ha dato lustro al nostro Paese con i suoi piatti legati al territorio.

La carne salada, uno dei piatti tipici dell'entroterra del Garda trentino.
Sua Maestà il «divin porcello»
Purtroppo da noi sta scomparendo la tradizione contadina legata al rito della macellazione del «divin porcello» e così pure sono sparite le pantagrueliche abbuffate (le famose maialate) organizzate da molti ristoranti.
Tradizioni che, invece, sono ancora vive nella Padania. Ad esempio nel Veronese, nel Vicentino, nel Mantovano.
Da Nizzoli, ad esempio, il ristorante amato da Cesare Zavattini, a Villastrada di Dosolo, nella Bassa Mantovana.
Qualche anno fa partecipai anch'io ad una di queste maialate con alcuni colleghi giornalisti e accademici mantovani (erano presenti anche il conte Giovanni Nuvoletti e il presidente del Centro Studi dell'Accademia Franco Marenghi).
Il mitico carrello dei bolliti
Da noi purtroppo è sempre più raro incontrare anche il carrello dei bolliti.
Ricordi di gioventù: nel periodo invernale il papà, la domenica, ci portava da Marietto all'Astoria prima stella Michelin del Trentino (oggi Ostello della Gioventù) per assaggiare quel ben di Dio: cotechino, zampone, lingua salmistrata, manzo, polpettone, testina con relative salse e mostarde.
Ricordo il mitico carrello dei bolliti del Ristorante Chiesa, sempre a Trento, con l'imponente figura di Mario Giovanella che prendeva per la gola i commensali. Ed altri ancora, ma a questo punto non vorrei abusare della vostra pazienza.
La ciuìga del Banale e la mortandèla
Oltre ai cotechini e agli zamponi, il maiale ci regala molte altre ghiottonerie: lo speck, la pancetta, il lardo, gli insaccati: le luganeghe, i salami, i cotechini. Tra gli insaccati merita un accenno la ciuìga del Banale, Presidio Slow Food, un insaccato a base di carne suina con l'aggiunta di rape cotte e macinate. Un tempo le rape erano la parte predominante, oggi non più.
Largo spazio (70%) è lasciato alle carni: coppa, pancetta, spalla, gola.
Altro salume tipico di casa nostra è la mortandela (da non confondere con la mortadella), una polpetta affumicata di carne suina che ricorda la pitina della Val Tramontina, preparata con carni di pecora, capra e selvaggina.
Siamo in Friuli, nelle Prealpi Carniche, a conferma del fil rouge che accomuna le cucine dell'arco alpino.

Alessandro Gilmozzi - El Molin, Cavalese.
I grandi formaggi del Trentino
Motivo d'orgoglio, in Trentino, sono altresì i formaggi. Molti sono Presìdi Slow Food: dal Casolet della Val di Sole al Puzzone di Moena, dal formaggio di malga del Lagorai al Vezzena, dal Trentingrana d'Alpeggio al Nostrano del Casel.
Testimoniano la ricchezza di questa nostra terra di confine che non ha proprio nulla da invidiare, quanto ad eccellenze enogastronomiche, ad altre regioni.
Il futuro? Sono ottimista. Ho fiducia nei giovani
E per il futuro? chiederà qualcuno. Io sono ottimista poichè vedo l'entusiasmo di molti giovani imprenditori (laureati, ingegneri, enologi) che hanno riscoperto il fascino dell'agricoltura, della campagna, della terra.
Di quella Madre Terra, cara a Slow Food, da amare come bene primordiale. Si ritorna, insomma, alle origini, con grande soddisfazione dei nostri nonni e, perché no, anche di noi buongustai impenitenti.
Giù le mani dalla «carne salada»
In chiusura consentitemi, anche per ringraziare la città di Riva che ci ospita, di spezzare una lancia a favore della «carne salada».
Una tradizione antica, specialità di questo angolo di Trentino «baciato dalla brezza del Garda» scrivevo nel 2008 in un reportage di Papageno corredato dalle splendide foto di Renato Vettorato.
«Giù le mani dalla carne salada» scrissi allora. Giù le mani ripeto oggi, con ancor maggiore forza. Grazie per l'attenzione e la pazienza con la quale mi avete ascoltato.
Evviva l'Accademia Italiana della Cucina.
Giuseppe Casagrande – [email protected]